Che succede se si copia una tesi di laurea?

Egregio Avvocato
Pubblicato il 17 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
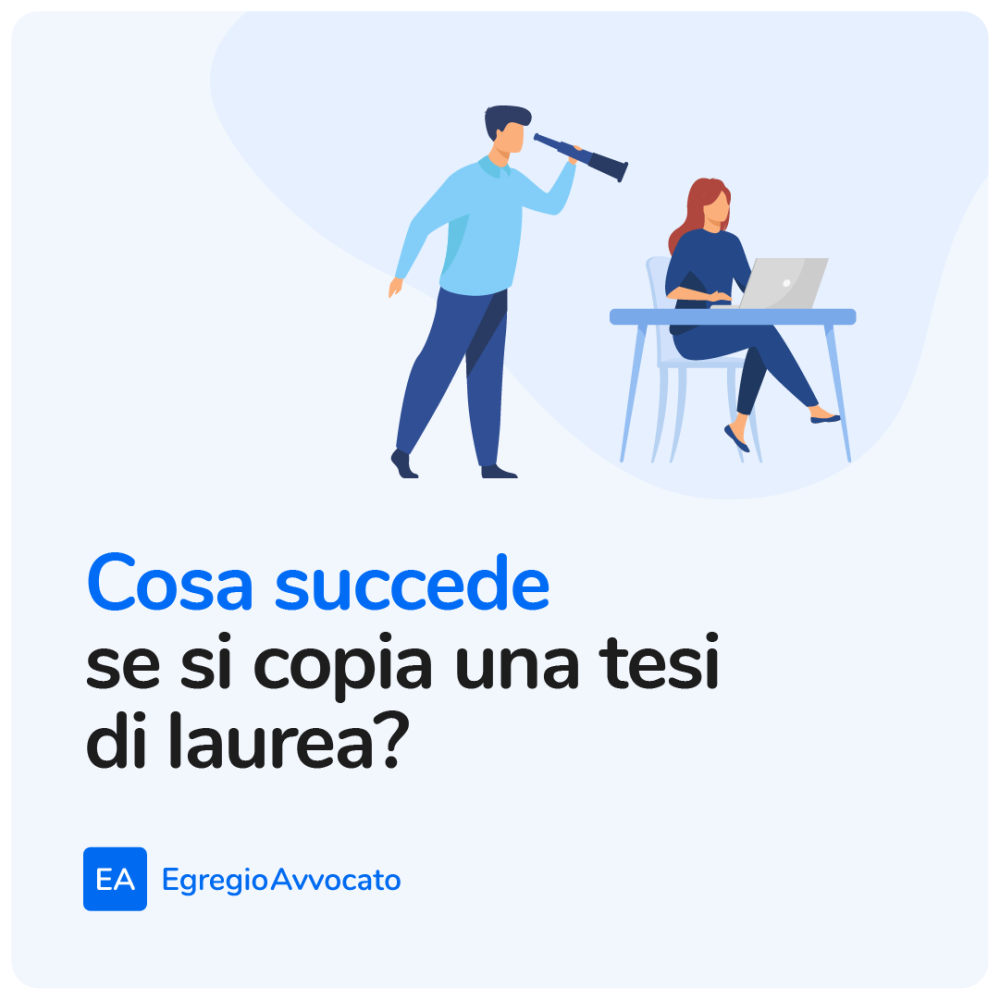
La scrittura di una tesi rappresenta spesso il lavoro conclusivo di un percorso di studi, come quello universitario, e deve essere un’opera originale e unica del suo autore, scritta autonomamente e personalmente.
Appropriarsi del lavoro di altri con la copiatura dei contenuti è un’attività vietata che può avere diverse conseguenze. Oltre a quelle “interne”, previste dalla singola Università, vi sono quelle previste dalla legge italiana, di natura civilistica ma anche penale e amministrativa.
Il soggetto che subisce il plagio, infatti, potrebbe chiedere il risarcimento dei danni determinati dalla violazione del diritto d’autore che tutela la sua opera.
La condotta, però, potrebbe integrare anche il reato previsto all’art. 1 della Legge 475/1925.
La norma prevede la reclusione da tre mesi a un anno per chiunque, in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o ogni altro grado titolo scolastico o accademico, o per l’abilitazione all’esercizio di una professione o per il rilascio di diplomi o patenti, presenti come propri dissertazioni, studi, pubblicazioni o progetti tecnici o ogni altro lavoro opera di altri soggetti.
Il reato è aggravato nel caso in cui viene conseguito l’intento voluto o se il soggetto agisce a fine di lucro o la condotta è abituale.
È, inoltre, prevista anche la pena accessoria della revoca del titolo conseguito.
Nei casi più gravi, potrebbe essere adottata anche la sanzione amministrativa dell’espulsione dall’Università.
Il plagio è escluso se l’autore cita opportunamente le fonti e i testi ai quali si fa riferimento, seguendo le indicazioni all’uopo previste.
La giurisprudenza è comunque incline a ritenere che il reato si configuri solo quando ci sia una consistente (e non marginale) riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo altrui.
Condividi:
Che succede se si copia una tesi di laurea?
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
La clausola penale
1 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Un istituto che viene spesso assimilato a quello della caparra confirmatoria (già visto nei post precedenti) è quello della clausola penale, che trova la sua disciplina nell’art. 1382 c.c. In particolare, la clausola penale prevede che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, la quale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, fatta salva la possibilità di prevedere la risarcibilità del danno ulteriore.Tuttavia, è opportuno evidenziare le differenze tra le due fattispecie. Da un punto di vista strutturale, la clausola penale è solo promessa; mentre la caparra confirmatoria è una clausola reale, e quindi si perfeziona con la consegna della res.Inoltre, mentre normalmente la clausola penale grava solo su una parte, la caparra confirmatoria è bilaterale, è un vincolo per entrambe le parti. Poi ancora, non è prevista la possibilità di rinunciare alla clausola penale e al massimo si può avere il risarcimento del danno ulteriore; mentre la caparra è rinunciabile e si può decidere di operare con i rimedi generali. Infine, per la clausola penale è espressamente prevista la riduzione ad equità se manifestamente eccessiva; mentre è fortemente controverso se questo potere sia estensibile anche alla caparra confirmatoria.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Il referendum abrogativo
31 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il referendum abrogativo è uno degli strumenti principali di democrazia diretta, il quale consente al corpo elettorale di incidere direttamente sull’ordinamento giuridico attraverso l’abrogazione di leggi o atti con forza di legge dello Stato, oppure di singole disposizioni in esse contenute. È una forma di legislazione negativa: serve solo a togliere, abrogare, le disposizioni di legge e non anche ad aggiungerne di nuove; tuttavia è ben possibile che mediante la eliminazione di singole parole si vada a manipolare il testo normativo e, di conseguenza, a creare nuove norme.Il procedimento è disciplinato dalla legge n. 352/1970. Il referendum può essere proposto da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali, che depositano le richieste presso la cancelleria della Cassazione tra il 1 gennaio e il 30 settembre di ciascun anno; non possono essere depositate richieste nell’anno precedente la scadenza ordinaria della legislatura e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali. Presso la Cassazione si costituisce l’Ufficio centrale per il referendum che esamina le richieste per giudicarne la conformità alla legge, ed entro il 31 ottobre può rilevare le eventuali irregolarità. Tale fase deve concludersi entro il 15 dicembre, con una decisione definitiva di tale Ufficio. I quesiti dichiarati legittimi vengono trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di ammissibilità, il quale deve essere deciso con sentenza pubblicata entro il 10 febbraio successivo. Se la Corte dichiara ammissibile il referendum, il Presidente della Repubblica deve fissare il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno.Affinché il referendum sia valido è necessario il raggiungimento di un cd. quorum strutturale, ovvero che si rechino alle urne la metà più uno degli aventi diritto al voto; e di un cd. quorum funzionale, cioè che i “si” superino i “no”. Ove ciò avvenga, spetta al presidente della Repubblica con proprio decreto proclamare l’avvenuta abrogazione.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Che differenza c’è tra proscioglimento e assoluzione?
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Le sentenze che intervengono all’esito di un processo penale possono ricondursi a due macro categorie: quelle di proscioglimento e quelle di condanna. Tra le sentenze di proscioglimento è possibile distinguere tra le sentenze di «non doversi procedere» e le sentenze di «assoluzione» (che rappresentano quindi un sottotipo).La differenza principale sta nel fatto che soltanto quelle di assoluzione contengono un accertamento da parte del giudice, compiuto mediante prove, e come tali sono in grado di fondare l’efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari.Le sentenze di non doversi procedere, invece, si limitano a statuire su aspetti processuali che impediscono l’accertamento stesso – e come tali sono definite come pronunce “meramente processuali”. Ciò si verifica quando l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (ad es. perché manda una condizione di procedibilità, come la querela); o quando il reato si è estinto (ad es. perché il reato è prescritto).Un aspetto formale, comune ad entrambi i tipi di proscioglimento, è che il giudice deve adottare una delle “formule terminative” previste dalla legge, che servono a precisare e sintetizzare la causa della decisione, fungendo anche da sorte di riassunto della motivazione. Il fatto che solo nel caso di assoluzione vi sia un vero e proprio accertamento nel merito rende tali sentenze più “vantaggiose” rispetto alle altre, anche per l’impatto che esse hanno sull’opinione pubblica.Per conciliare il possibile interesse dell’imputato a ottenere l’assoluzione nel merito (e non una pronuncia processuale) con le esigenze di economia processuale – che invece imporrebbero di non proseguire il processo in carenza dei presupposti – l’ordinamento prevede il giudice debba pronunciare sentenza di assoluzione quando l’innocenza dell’imputato risulti «evidente dagli atti» disponibili quando si verifica anche il fatto estintivo.È inoltre sempre possibile per l’imputato rinunciare alla prescrizione del reato ai sensi dell’art. 157 c.p.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Le lettere di patronage: deboli e forti
29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Le lettere di patronage sono delle dichiarazioni che vengono rilasciate ad una banca da un soggetto (di solito, una società capogruppo) in modo da indurre la banca stessa a concedere, rinnovare o mantenere un finanziamento ad un altro soggetto (di solito, una società controllata dalla prima).Sono molto utilizzate nell’ordinamento italiano, sebbene non esplicitamente disciplinate. Si differenziano, da un lato, dal mandato di credito (art. 1937 c.c.), che prevede un incarico vero e proprio a fare credito, il quale viene accettato dall’altra parte; e dall’altro lato, si differenziano dalla fideiussione (artt. 1936 e ss. c.c.), ove la volontà di prestare garanzia deve essere espressamente manifestata.Vi sono le cd. lettere di patronage deboli, ove il soggetto capogruppo si limita a dare alla banca delle informazioni riguardanti l’altro soggetto rispetto al quale si ha interesse a che venga erogato il credito. Se le informazioni fornite sono sbagliate, si risponderà a titolo di responsabilità precontrattuale, nel caso in cui sia stato falsato il processo di conclusione del contratto (si rientra nella fase delle trattative).Ma vi sono anche le cd. lettere di patronage forti, alla luce delle quali sussiste una vera e propria garanzia atipica. In questi casi, secondo una prima tesi si ha un contratto atipico con obbligo di facere, e cioè impegnarsi a tenere un certo comportamento nella gestione della società controllata. Secondo una diversa tesi, invece, si ha una promessa del fatto del terzo, che dà luogo ad un’obbligazione indennitaria o risarcitoria nel caso in cui non venga mantenuto il comportamento promesso.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti


