Decreto legge e decreto legislativo: le differenze

Egregio Avvocato
Pubblicato il 19 nov. 2021 · tempo di lettura 2 minuti
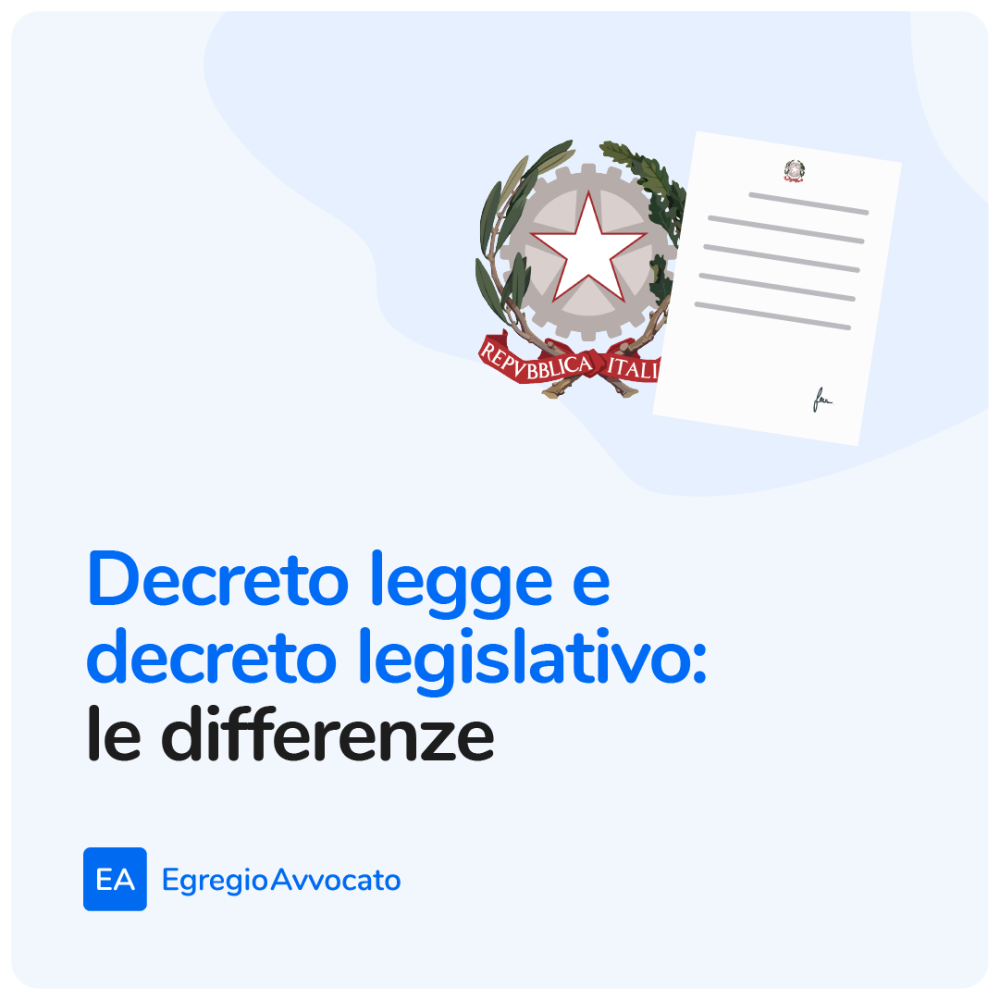
Uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico italiano è il principio di separazione dei poteri, secondo il quale i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) devono essere esercitati da tre istituzioni differenti e indipendenti tra loro. In particolare, ad avere il monopolio del potere legislativo è il Parlamento: essendo l’organo rappresentativo dell’intera collettività nazionale, è considerato l’unico in grado di avere una visione d’insieme tale da comprendere in che modo intervenire con lo strumento legislativo.
Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali è previsto che il potere legislativo possa essere esercitato anche da un’altra istituzione: il Governo. Quest’ultimo può intervenire con degli atti definiti “atti aventi forza di legge”, proprio per il fatto che, pur non essendo formalmente legge, esplicano comunque i medesimi effetti.
Nello specifico si tratta del decreto legislativo (D.lgs.) e del decreto legge (D.L.), i quali, nonostante le caratteristiche in comune (in primis, il soggetto emanante), presentano importanti differenze tra loro.
Il decreto legge, previsto dall’art. 77 Cost., può essere emanato dal Governo come atto avente forza di legge ordinaria soltanto nei casi di necessità e urgenza (es. calamità naturali). Ha una validità temporanea di 60 giorni, entro i quali deve essere convertito in legge dal Parlamento (cd. legge di conversione). Se tale conversione non avviene entro questi 60 giorni, i decreti perdono efficacia sin dall’inizio.
Il decreto legislativo, cui fa riferimento l’art 76 Cost., viene invece emanato dal Governo su delega dello stesso Parlamento. L’assemblea parlamentare, infatti, mediante una cd. legge delega chiede esplicitamente al Governo di emanare leggi riguardanti discipline particolarmente complesse e articolate, le quali richiedono pareri tecnici e specifici. È un rimedio che viene utilizzato soprattutto per disciplinare delle materie destinate a veloce obsolescenza (es. disciplina sulle sostanze stupefacenti). La legge delega del Parlamento, affinché possa validamente attribuire il potere legislativo al Governo, deve delineare chiaramente i principi e i criteri direttivi che devono essere seguiti nell’emanazione del decreto legislativo.
Si evidenzia, dunque, che mentre in un caso (decreto legge) il Parlamento interviene in via successiva rispetto all’emanazione dell’atto avente forza di legge da parte del Governo; nell’altro caso (decreto legislativo) è proprio il Parlamento che demanda al Governo il potere di emanare atti aventi forza di legge, delineando preventivamente l’ambito entro il quale l’organo esecutivo può muoversi.
Condividi:
Decreto legge e decreto legislativo: le differenze
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Che succede se si copia una tesi di laurea?
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La scrittura di una tesi rappresenta spesso il lavoro conclusivo di un percorso di studi, come quello universitario, e deve essere un’opera originale e unica del suo autore, scritta autonomamente e personalmente. Appropriarsi del lavoro di altri con la copiatura dei contenuti è un’attività vietata che può avere diverse conseguenze. Oltre a quelle “interne”, previste dalla singola Università, vi sono quelle previste dalla legge italiana, di natura civilistica ma anche penale e amministrativa. Il soggetto che subisce il plagio, infatti, potrebbe chiedere il risarcimento dei danni determinati dalla violazione del diritto d’autore che tutela la sua opera.La condotta, però, potrebbe integrare anche il reato previsto all’art. 1 della Legge 475/1925.La norma prevede la reclusione da tre mesi a un anno per chiunque, in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o ogni altro grado titolo scolastico o accademico, o per l’abilitazione all’esercizio di una professione o per il rilascio di diplomi o patenti, presenti come propri dissertazioni, studi, pubblicazioni o progetti tecnici o ogni altro lavoro opera di altri soggetti.Il reato è aggravato nel caso in cui viene conseguito l’intento voluto o se il soggetto agisce a fine di lucro o la condotta è abituale.È, inoltre, prevista anche la pena accessoria della revoca del titolo conseguito.Nei casi più gravi, potrebbe essere adottata anche la sanzione amministrativa dell’espulsione dall’Università.Il plagio è escluso se l’autore cita opportunamente le fonti e i testi ai quali si fa riferimento, seguendo le indicazioni all’uopo previste.La giurisprudenza è comunque incline a ritenere che il reato si configuri solo quando ci sia una consistente (e non marginale) riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo altrui.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Cosa è il funzionario di fatto?
10 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Con l’espressione funzionario di fatto, ci si riferisce a quelle ipotesi in cui l’atto di investitura del titolare dell’organo sia viziato ovvero manchi del tutto. Questa situazione si può definire come l’esercizio dell’azione amministrativa da parte di soggetti privi della relativa legittimazione.La ratio del riconoscimento giuridico di tale figura è da individuare principalmente nell’esigenza di risolvere il problema della rilevanza giuridica rispetto all’attività compiuta dal funzionario di fatto.La dottrina ha individuato tale esigenza nella soddisfazione della continuità dell’esercizio della funzione pubblica, nonché della tutela della buona fede e dell’affidamento dei terzi e di quella relativa all’economia dei mezzi giuridici che comporta la conservazione degli atti amministrativi utili alla P.A.In merito alle figure riconducibili al funzionario di fatto, non vi è omogeneità di opinioni in dottrina, infatti, si discute in merito alle ipotesi di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.), dell’occupazione bellica, della prorogatio e dell’ingerenza autorizzata da un atto di investitura formale, risultato in seguito viziato.Per quel che riguarda il regime giuridico degli atti compiuti dal funzionario di fatto, applicandosi la regola del c.d. fatto compiuto, una volta decorsi i termini per l’impugnativa dell’atto di investitura, gli atti saranno considerati validi, fatta salva la loro impugnazione per un vizio diverso rispetto a quello della competenza.Infine, relativamente alla tutela dei terzi destinatari degli atti, si invoca il principio di conservazione in forza del quale gli atti, nonostante siano invalidi, si ritengono produttivi di effetti nei confronti dei terzi, eccezion fatta per le ipotesi di usurpazione, per cui si propende per l’inapplicabilità del principio. Si ritiene in giurisprudenza prevalente l’orientamento che fonda sul principio di buona fede del privato destinatario degli effetti dell’atto, il fondamento della salvaguardia dello stesso.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Cosa è l’incidente probatorio?
30 nov. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
L’incidente probatorio consiste in una udienza che si svolge dinanzi al giudice per le indagini preliminari in camera di consiglio, e quindi senza la presenza del pubblico, e nella quale si assumono le prove non rinviabili al dibattimento (art. 392 c.p.p.) Tali prove sono assunte nelle medesime forme prescritte per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta con l’esame incrociato.A poter fare richiesta di incidente probatorio sono il pubblico ministero, l’indagato e il suo difensore. La persona offesa non può invece rivolgersi direttamente al giudice, ma può fare richiesta solo mediante il pubblico ministero, il quale valuterà se accogliere o meno l’istanza.Il codice di procedura penale prevede dei casi tassativi di non rinviabilità della prova all’art. 392 c.p.p., tra cui ricordiamo la testimonianza e il confronto, i quali sono ammessi se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un grave impedimento (es. infermità) o di una minaccia affinché non deponga o deponga il falso. Vi sono però anche degli altri mezzi di prova che devono essere assunti nell’incidente probatorio sulla base del solo presupposto che il p.m. o l’indagato ne abbiano fatto richiesta al gip, senza che sia necessario il requisito della non rinviabilità né dell’urgenza. Ciò accade, ad esempio, quando si tratta dell’esame del testimone di giustizia (art. 392, co. 1, lett. d).La funzione dell’incidente probatorio, dunque, è quello di consentire una non dispersione delle prove, e di far salvi anche quei mezzi di prova che altrimenti potrebbero non arrivare in dibattimento. Le prove assunte in sede di incidente probatorio, infatti, hanno lo stesso valore delle prove assunte in dibattimento, e possono essere poste a fondamento della decisione del giudice. Unico limite di utilizzabilità delle prove assunte in sede di incidente probatorio è quello delle prove che siano state assunte senza la partecipazione del difensore dell’imputato, e quindi senza la garanzia del contraddittorio.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Cosa è l’obbligazione naturale?
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
L’obbligazione naturale è quella obbligazione che scaturisce da un dovere morale o sociale. Essa determina la c.d. soluti retentio ai sensi dell’art. 2034 c.c., cioè impedisce al soggetto che abbia pagato in adempimento di quel dovere di pretendere la restituzione della prestazione effettuata. Ai sensi della legge, questo costituisce l’unico effetto giuridicamente rilevante dell’obbligazione naturale.Secondo la tesi prevalente, tale norma evidenzia come per l’ordinamento i doveri morali e sociali vigenti in un certo contesto storico/culturale possano costituire valida “causa solvendi”, cioè una ragione idonea a giustificare uno spostamento di ricchezza, consistente nel pagamento realizzato. Ciò in conformità al divieto generale di arricchimenti senza giusta causa.Per converso, gli stessi doveri morali o sociali non permetterebbero di giustificare ulteriori effetti normalmente correlati alla disciplina delle obbligazioni.In particolare, diversamente dalle obbligazioni “civili” normalmente intese, le obbligazioni naturali non sarebbe passibili di tutela giurisdizionale: il creditore naturale, cioè colui che in base all’asserito dovere avrebbe diritto a ricevere la prestazione, non potrebbe agire in giudizio per ottenere il pagamento dovuto. L’unica tutela che l’ordinamento gli riconosce è, infatti, quella di ritenere il pagamento una volta che lo abbia ricevuto.La legge contempla espressamente alcune ipotesi di obbligazioni naturali, quali il pagamento del debito di gioco (ma, secondo la tesi prevalente, solo nel caso di gioco “tollerato” e non per il gioco proibito) o la fiducia testamentaria. Più controversa è invece l’ipotesi del debito prescritto: per alcuni si tratterebbe di un'obbligazione naturale che prende il posto di quella civile, estinta al momento stesso della prescrizione; per altri la prescrizione opera solo se viene fatta valere in giudizio e sarebbe possibile agire in giudizio per ottenere il pagamento del debito prescritto (salva la possibilità per il convenuto di evitarlo eccependo la prescrizione). Accanto a queste tipiche, ne esistono delle altre, atipiche, che costituiscono casi in cui i doveri della morale sociale di volta in volta rilevanti, normalmente irrilevanti ai fini del diritto, vengono “elevati” a obbligazioni con una qualche rilevanza giuridica.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti


