La libertà sindacale e il diritto di sciopero

Egregio Avvocato
Pubblicato il 8 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
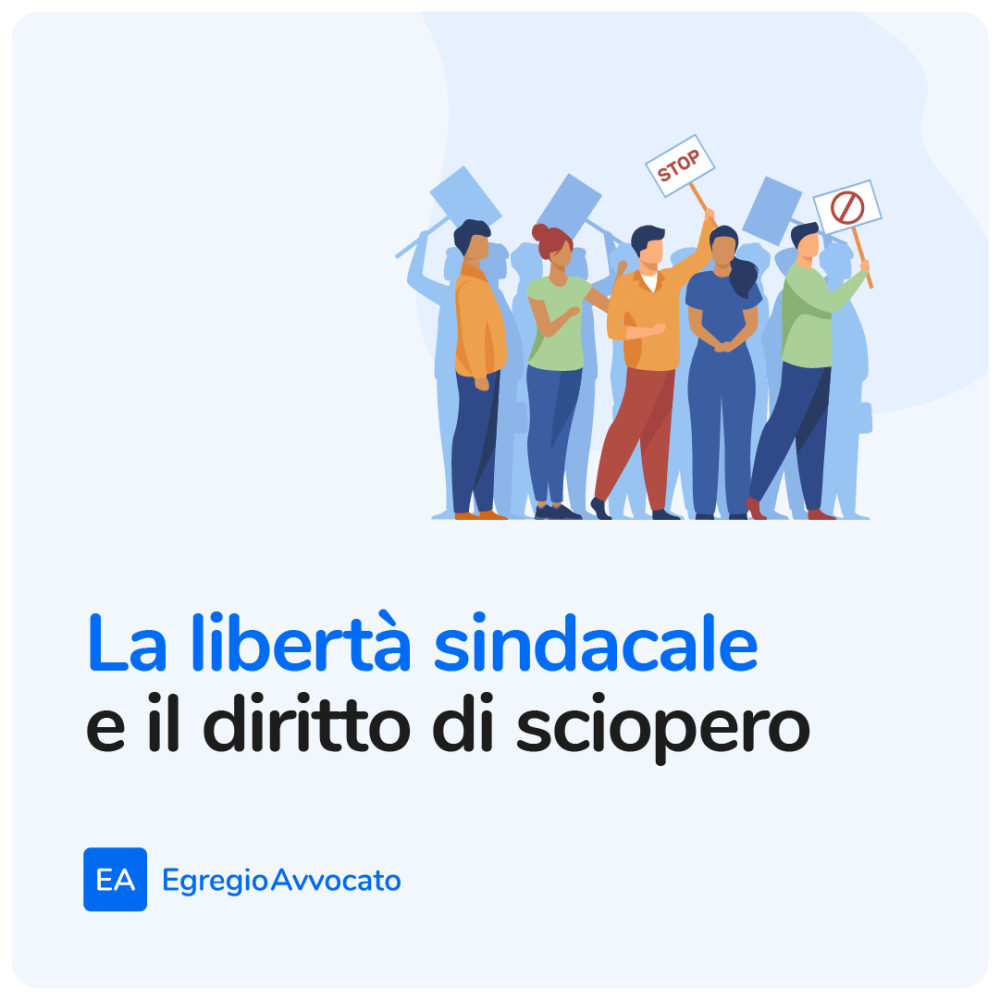
L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale.
La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria.
I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.
Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).
Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione.
L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero.
Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.
Condividi:
La libertà sindacale e il diritto di sciopero
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Il diritto di sciopero
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 40 della Costituzione sancisce il diritto di sciopero, da esercitarsi nell’ambito delle leggi che lo regolano. È la principale forma di autotutela dei lavoratori, e si configura come un’astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei propri interessi collettivi. Il diritto di sciopero non è soggetto ad alcuna limitazione, se non a quelle derivanti da norme che tutelano posizioni giuridiche concorrenti quali il diritto alla vita, il diritto alla salute, la libertà all’iniziativa economica.Una particolare disciplina è prevista per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, stabilita con la legge n. 146/1990, successivamente modificata dalla legge n. 83/2000. Sono essenziali quei servizi finalizzati a garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati, i quali sono tassativamente individuati: diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione. Si evidenzia che ad essere tassativamente individuati sono i diritti della persona, e non anche i servizi pubblici essenziali finalizzati a garantire tali diritti: è quindi possibile includere nuovi servizi che tutelino però i diritti di rilevanza costituzionale previamente individuati.L’art. 2 della legge in esame dispone le condizioni affinché possa essere esercitato il diritto di sciopero nell’ambito dei servizi essenziali: è necessario adottare misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili; osservare un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni; fornire informazioni alle utenze circa lo sciopero almeno 5 giorni prima dell’inizio; esperire un tentativo di conciliazione, vincolante e obbligatorio per le parti.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
La giustizia riparativa
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La giustizia riparativa, anche conosciuta come mediazione penale, è quel processo, utilizzato ai fini deflattivi, rivolto alla dimensione dualistica reo-vittima. Tale processo consente alle persone che subiscono un pregiudizio a causa di un delitto e alle persone responsabili di tale pregiudizio (autori del reato) di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito.Molteplici sono le spinte europeiste volte a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell’ambito dei propri sistemi penali (da ultimo la Raccomandazione UE n. 8/2018).La caratteristica principale della giustizia riparativa è quella di identificare il reato non più soltanto come un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l’ordine costituito, ma invece come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che provoca un pregiudizio alla vittima, la quale assume un ruolo principe all’interno di tale processo. Per raggiungere la propria finalità, quale la riparazione del pregiudizio, è necessario che la partecipazione sia volontaria e non coatta, deve essere esplicitamente espresso il consenso di entrambe le parti, le quali potranno in ogni momento revocarlo. Fondamentale, inoltre, è la figura del facilitatore (o mediatore), il quale deve intervenire come parte terza, qualificata ed imparziale. Tale ruolo non può essere svolto dal giudice che decide sul fatto di reato, in quanto le dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione non possono essere utilizzate, né possono influenzare il procedimento penale.Nel sistema penale italiano si ritrovano degli aspetti di giustizia riparativa nell’ambito del procedimento minorile, ove si tiene conto del fatto che il soggetto autore dell’illecito ha una personalità ancora in formazione; nell’ambito del procedimento penale ordinario, mediante l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.); e anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000), ove sono previsti gli istituti della mediazione (art. 29) e della estinzione del reato come conseguenza di condotte riparative (art. 35).
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Denuncia e querela: quali sono le differenze?
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
I termini “querela” e “denuncia” vengono generalmente utilizzati come sinonimi, ma è bene sapere che tale utilizzo è improprio.Mentre la denuncia può essere presentata da chiunque abbia avuto notizia di un reato, la querela può essere presentata solo dalla persona offesa del reato (quindi dalla vittima dello stesso) entro un determinato termine (generalmente 3 mesi dalla commissione del reato) ed è l’atto con il quale viene manifestata la volontà di perseguire penalmente il fatto di reato. La querela presenta un elemento in più rispetto alla denuncia: non solo la notizia di reato, ma anche la manifestazione di volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo.Nel caso in cui il reato sia sottoposto a condizione di procedibilità (es. reato di diffamazione), è bene assicurarsi di aver sporto la querela, poiché solo mediante quest’ultima - e non anche con una semplice denuncia - potrà avere inizio il processo penale.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
La caparra confirmatoria
25 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 1385 c.c. prevede l’istituto della caparra confirmatoria. Si tratta di una sorta di acconto, e quindi di una somma in denaro, che può essere dato da una parte all’altra al momento di conclusione del contratto. In caso di adempimento la somma già versata a titolo di caparra viene imputata alla prestazione dovuta; in caso di inadempimento, invece, svolge una duplice funzione: da un lato rappresenta una somma forfettaria della liquidazione del danno, e dall’altro lato integra un’ipotesi di risoluzione stragiudiziale. Dall’art. 1385 co. 3 c.c. infatti emerge una alternatività tra risoluzione mediante caparra e risoluzione del contratto in via giudiziale: il soggetto creditore può decidere di non avvalersi della caparra, e avvalersi invece dei rimedi generali, tra cui la risoluzione (artt. 1453 e ss.).Ne consegue che è possibile attivare la caparra confirmatoria non a fronte di tutti i tipi di inadempimenti, ma a fronte dello stesso tipo di inadempimento che legittimerebbe il rimedio alternativo, cioè la risoluzione giudiziale, e quindi si tratta necessariamente di inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) Se così non fosse, non avrebbe senso che il legislatore abbia previsto la alternatività tra i due rimedi, e verrebbe inoltre tradita l’ulteriore funzione deflattiva che è riconosciuta alla caparra. La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato questa impostazione, sostenendo che la vera alternativa non è tra le due risoluzioni, una costitutiva e una di accertamento, ma è tra il certo e l’incerto, e deve valere il principio per cui chi sceglie l’incerto perde per sempre il certo.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti


