Si può dire “reato penale”?

Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
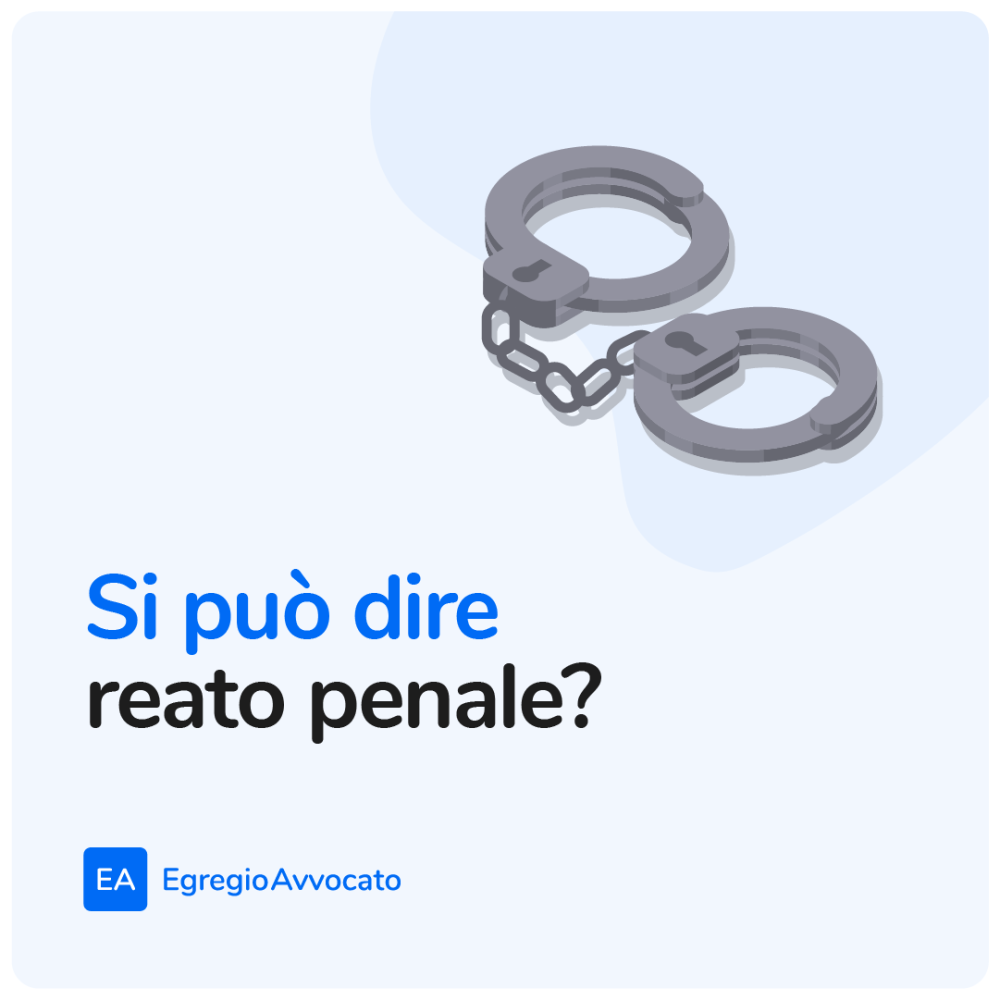
Il reato è un fatto giuridico umano vietato dall’ordinamento di uno Stato, al quale è collegato una sanzione di tipo penale.
Esso appartiene alla più generale categoria degli “illeciti”, cioè tutti i comportamenti che violano un obbligo o un dovere posto da una norma giuridica, ai quali la legge collega una sanzione.
Proprio il tipo di sanzione serve a classificare i vari tipi di illeciti e, se la sanzione è penale, si tratta necessariamente di un reato.
Pertanto, il reato appartiene per definizione all’ambito penale e, quindi, aggiungere tale aggettivo al sostantivo “reato” è grammaticalmente scorretto, perché equivale a ripetere due volte lo stesso concetto – accostando al sostantivo (reato) un aggettivo qualificativo (penale) contenuto già nella sua definizione.
Condividi:
Si può dire “reato penale”?
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Il giudizio immediato
8 mar. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Uno dei procedimenti speciali previsto dal c.p.p. è il cd. giudizio immediato, il quale sacrifica il controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio: non prevede lo svolgimento dell’udienza preliminare, e dalle indagini preliminari si transita direttamente all’udienza dibattimentale.Può essere richiesto sia dall’imputato sia dal Pubblico ministero. Nel primo caso, l’imputato può avanzare richiesta di giudizio immediato soltanto dopo che il PM abbia formulato l’imputazione ed il giudice fissato l’udienza preliminare. La richiesta deve essere presentata nella cancelleria del giudice almeno tre giorni prima dell’udienza preliminare e deve essere notificata al PM e alla persona offesa.Il PM, invece, è obbligato ad avanzare richiesta di giudizio immediato nell’ipotesi di evidenza della prova (cd. ipotesi tradizionale), o quando l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare (cd. ipotesi custodiale). Il PM è esentato dall’obbligo di avanzare tale richiesta nel caso in cui ciò possa pregiudicare gravemente le indagini.In particolare, nell’ipotesi tradizionale il PM deve chiedere al Gip il rito immediato se vi è l’evidenza della prova; vi è stato interrogatorio dell’indagato; e non sono decorsi più di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p.Nell’ipotesi custodiale, invece, i presupposti per la richiesta di giudizio immediato sono: lo stato di custodia cautelare; un determinato grado di stabilità del provvedimento custodiale (es. confermato in sede di riesame); la non decorrenza di 180 giorni dall’esecuzione della misura; la permanenza della valutazione dei gravi indizi per la misura custodiale.Sulla richiesta del PM decide il giudice per le indagini preliminari inaudita altera parte, e quindi sentendo esclusivamente la parte pubblica. Se ritiene sussistenti i presupposti, dispone con decreto il rito immediato e provvede a formare il fascicolo per il dibattimento. Il decreto, non motivato, viene comunicato al PM e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno 30 giorni prima della data fissata per l’udienza.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
La motivazione del provvedimento amministrativo
2 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta lo strumento attraverso il quale la P.a. esterna i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all’emanazione di un dato provvedimento.L’art. 3 L. 241/1990 contiene disposizioni di applicazione generale, valide per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi e il personale, ad eccezione degli atti normativi e a contenuto generale. Sottratte alla motivazione sono anche le forme di silenzio assenso di cui all’art. 20 L. 241/1990.La ratio della motivazione va individuata, nell’esigenza di garantire agli interessati la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’amministrazione, anche allo scopo di verificarne la correttezza nonché eventuali profili di illegittimità.Per quanto riguarda la struttura della motivazione, l’art. 3 fa riferimento tanto alle ragioni di fatto, quanto ai presupposti di diritto. Per presupposti di fatto si intendono gli elementi e i dati fattuali acquisiti durante l’istruttoria, oggetto di valutazione da parte della PA. Invece, le ragioni giuridiche, comprendono le argomentazioni condotte sul piano del diritto, cioè le norme che sono state considerate applicabili nella fatt. concreta all’esame dall’amministrazione procedente.Per quel che riguarda i canoni della motivazione, dottrina e giurisprudenza li individuano nella congruità (quindi nel percorso logico seguito dalla P.a.) e nella sufficienza (nell’eliminare i dubbi di irrazionalità e di arbitrio nell’operato della P.a.).Infine, l’ultimo comma dell’art. 3 dispone che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità a cui è possibile fare ricorso.Per quanto riguarda i profili giurisdizionali attinenti all’obbligo di motivazione, bisogna considerare che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 241/1990, la mancanza di motivazione può essere considerata come una violazione di legge, mentre in precedenza si parlava di un vizio attinente all’eccesso di potere.In caso di motivazione perplessa e contraddittoria, invece, si può continuare a parlare di eccesso di potere, riguardando il vizio e non la motivazione in sé, ma il concreto svolgimento del potere amministrativo.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
I poteri impliciti della PA
19 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il tema dei poteri impliciti della Pubblica Amministrazione è particolarmente rilevante, e ha interessato nel passato i poteri di autotutela (oggi disciplinati dalla legge n. 241/90) e attualmente i poteri delle Autorità amministrative indipendenti. Si tratta di poteri per i quali è assente una base normativa: è un potere innominato che si ritiene si possa desumere da un altro potere, che invece è nominato. Trova fondamento anche nel principio di inesauribilità dei poteri amministrativi, secondo cui il pubblico interesse ha costante necessità di essere curato e richiede un costante intervento da parte della Pubblica amministrazione.La teoria dei poteri impliciti è una teoria antica, che normalmente trova una sua elaborazione negli Stati federali. Lo Stato centrale mantiene dei poteri nominati, ma di regola c’è anche una cd. clausola di flessibilità che consente allo Stato centrale di esercitare dei poteri anche diversi da quelli espressamente nominati ma comunque strumentali al raggiungimento degli obiettivi che le sono stati affidati. Ad esempio ciò avviene nella Costituzione americana; ma lo troviamo anche nell’art. 352 TFUE.Oggi, dunque, la teoria dei poteri impliciti si giustifica in questi termini: quando un potere è strumentale, e quindi strettamente funzionale, all’esercizio di una competenza attribuita, allora si ritiene che una base normativa ce l’abbia ancorché implicita.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
I doveri del pubblico dipendente
10 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Con il contratto di lavoro le parti si impegnano a reciproche obbligazioni.Prestazione lavorativa e retribuzione costituiscono i principali obblighi derivanti dal contratto di lavoro e rappresentano l’oggetto del contratto. Anche il lavoro di pubblico impiego è un rapporto di tipo bilaterale, da cui derivano una serie di doveri e diritti sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.I doveri del dipendente possono essere raggruppati in due ampie tipologie: l’una di stampo pubblicistico, riconducibile al dovere di fedeltà alla Repubblica ex. art. 51 Cost., ai principi di imparzialità e buon andamento ex. art. 97 Cost., e al carattere democratico della repubblica ex. art. 1 Cost., che impone di favorire i rapporti tra amministrazione e cittadino.L’altra tipologia si richiama, invece, ai doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà, sanciti, come per il rapporto di lavoro privato, dagli artt. 2104 e 2105 c.c.La definizione dei doveri del dipendente compete al codice di comportamento che nel pubblico impiego, da ultimo, è previsto dal D.P.R. 62/2013. Questo nuovo Codice, definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Esso trova applicazione per tutti i dipendenti pubblici, dirigenti e non, specificandosi che le relative prescrizioni costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale sottratte alla privatizzazione, previste dall’art. 3 D. Lgs. 165/2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Il nuovo Codice presenta dei profili innovativi rispetto al passato.In primo luogo, per quel che riguarda la disciplina in tema di regali, compensi e altre utilità. Il dipendente non deve sollecitare per sé o per altri, né regali o altre utilità ma soprattutto non ne deve accettare, salvo quelli modico valore, rinvenibili nelle normali relazioni di cortesia, quelli, orientativamente, di valore non superiore ai 150 euro.Importante è anche il nuovo richiamo alla prevenzione degli illeciti nella P.A., correlato alla normativa in tema di corruzione e trasparenza, nella quale si prevede che tutti i dipendenti sono tenuti, non solo a rispettare le misure di prevenzione della corruzione, ma anche a garantire la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione. Sull’applicazione del Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti


