Tentativo circostanziato di delitto e tentativo di delitto circostanziato

Egregio Avvocato
Pubblicato il 31 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
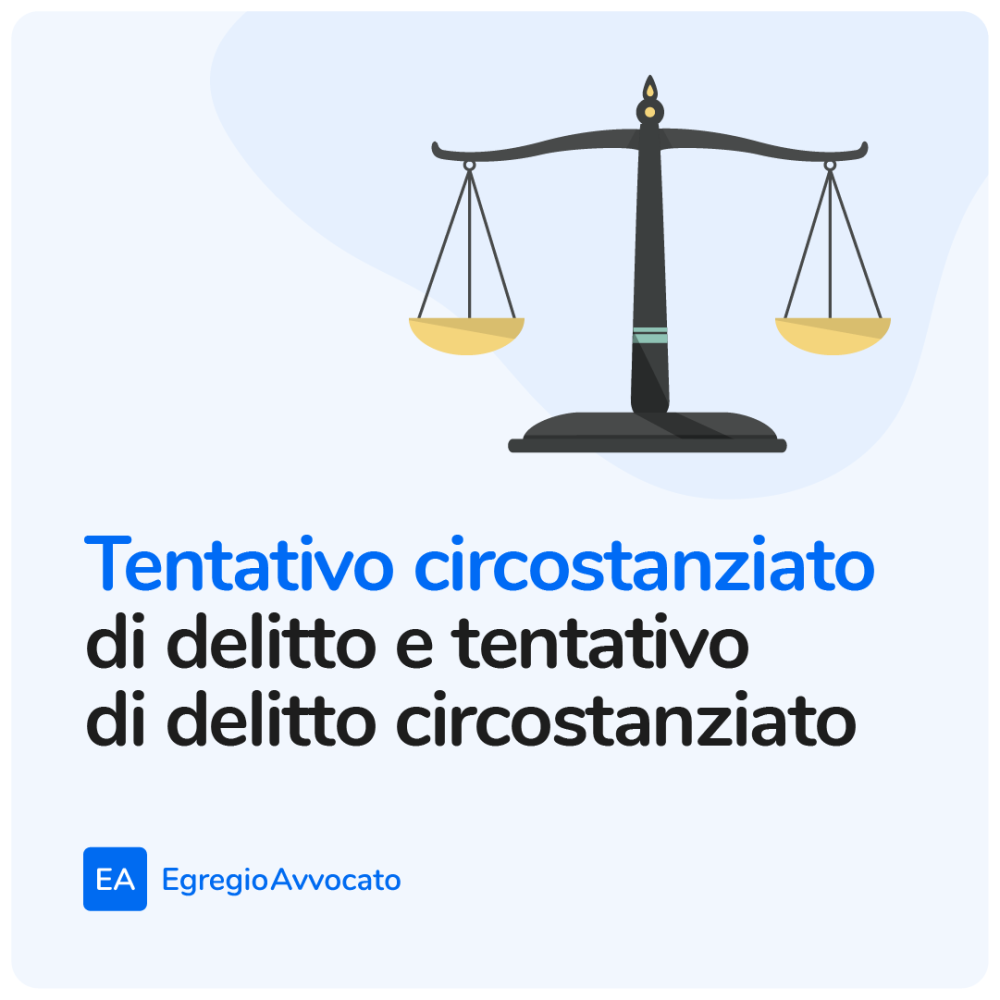
Il tentativo circostanziato di delitto è quella fattispecie ove il soggetto agente pone in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato, nei quali sia presente in rerum natura una circostanza di reato.
Si può fare l’esempio di un soggetto che si reca in banca per commettere una rapina con un’arma, però viene arrestato in flagranza: si ha una tentata rapina e la circostanza dell’uso delle armi sussiste in rerum natura.
Il tentativo di delitto circostanziato, invece, è quella fattispecie nella quale la circostanza di reato non esiste nella realtà, ma vi sarebbe stata solo se il reato fosse arrivato a consumazione. Ad esempio, il soggetto agisce per rubare un famosissimo quadro, ma viene arrestato mentre lo sta afferrando: è un tentato furto, e la circostanza del danno ingente non c’è ma ci sarebbe stata solo in caso di consumazione.
Mentre l’ammissibilità della prima fattispecie è pacificamente ammessa, la seconda fattispecie, il tentativo di delitto circostanziato, pone maggiori problemi. La dottrina prevalente ritiene non ammissibile tale fattispecie, perché la norma sul tentativo (art. 56 c.p.) si riferisce solo al delitto e non anche alla circostanza. La giurisprudenza a Sezioni Unite, invece, ritiene ammissibile il tentativo di delitto circostanziato per un’esigenza di proporzionalità e ragionevolezza della pena, ma richiede due presupposti: la certezza della verificazione della circostanza in caso di consumazione; e che nel proposito criminoso del soggetto agente rientri anche la sussistenza della circostanza (che, quindi, deve essere oggetto di rappresentazione).
Condividi:
Tentativo circostanziato di delitto e tentativo di delitto circostanziato
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
La giustizia riparativa
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La giustizia riparativa, anche conosciuta come mediazione penale, è quel processo, utilizzato ai fini deflattivi, rivolto alla dimensione dualistica reo-vittima. Tale processo consente alle persone che subiscono un pregiudizio a causa di un delitto e alle persone responsabili di tale pregiudizio (autori del reato) di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito.Molteplici sono le spinte europeiste volte a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell’ambito dei propri sistemi penali (da ultimo la Raccomandazione UE n. 8/2018).La caratteristica principale della giustizia riparativa è quella di identificare il reato non più soltanto come un illecito commesso contro la società, o come un comportamento che incrina l’ordine costituito, ma invece come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che provoca un pregiudizio alla vittima, la quale assume un ruolo principe all’interno di tale processo. Per raggiungere la propria finalità, quale la riparazione del pregiudizio, è necessario che la partecipazione sia volontaria e non coatta, deve essere esplicitamente espresso il consenso di entrambe le parti, le quali potranno in ogni momento revocarlo. Fondamentale, inoltre, è la figura del facilitatore (o mediatore), il quale deve intervenire come parte terza, qualificata ed imparziale. Tale ruolo non può essere svolto dal giudice che decide sul fatto di reato, in quanto le dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione non possono essere utilizzate, né possono influenzare il procedimento penale.Nel sistema penale italiano si ritrovano degli aspetti di giustizia riparativa nell’ambito del procedimento minorile, ove si tiene conto del fatto che il soggetto autore dell’illecito ha una personalità ancora in formazione; nell’ambito del procedimento penale ordinario, mediante l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p.); e anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000), ove sono previsti gli istituti della mediazione (art. 29) e della estinzione del reato come conseguenza di condotte riparative (art. 35).
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Differenza tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza d’interesse
26 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito da cui ne deriva la integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento emesso spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale. La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa che soddisfa pienamente l’interesse azionato. È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi a pieno ed in modo non più retrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, in modo da non far residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice. La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo si caratterizza per il contenuto che si accerta, ossia si indaga il merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione. Decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Qual'è la differenza tra locazione e affitto?
16 feb. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il codice civile prevede all’art. 1571 la definizione generale del contratto di locazione, nell’ambito della disciplina dei contratti tipici, in base alla quale, si può classificare come “locazione” quel negozio giuridico con il quale una parte, detta locatore o concedente, si obbliga a far utilizzare una cosa per un certo periodo di tempo ad un altro soggetto, detto, a seconda dei casi, conduttore o inquilino o concessionario o affittuario, in cambio di un corrispettivo, usualmente denominato canone.All’interno di questa categoria generale si possono distinguere: le locazioni di beni mobili (ad esempio dei macchinari o mezzi di trasporto), quelle di beni immobili urbani, le più frequenti, cui il legislatore dedica una diversa disciplina a seconda che siano ad uso abitativo o ad uso diverso (ad esempio adibiti ad attività commerciali o professionali). A queste ultime, in particolare, è dedicata copiosa legislazione speciale, volta a bilanciare le esigenze della proprietà con quelle abitative. Unitamente, sono previste anche le locazioni di beni immobili non urbani, come nel caso dei fabbricati rurali.Diversamente, il vero e proprio contratto di affitto, a discapito della diffusione che tale termine ha nel linguaggio comune, tecnicamente fa riferimento alla sola locazione di beni produttivi mobili o immobili, quali ad esempio fondi rustici, aziende, alberghi. L’affitto è pertanto una species del genus della locazione, alla quale peraltro la legge dedica una disciplina specifica perché correlata al fatto che la cosa locata è una res produttiva. Ne deriva, ad esempio, che l’affittuario deve curare la gestione della cosa, conformemente alla sua destinazione economica, e che se quest’ultima viene mutata o v’è inosservanza delle regole di buona tecnica, il concedente può chiedere la risoluzione del contratto. Inoltre, all’affittuario spettano i frutti e le altre utilità tratte dalla res, oltre che la facoltà di prendere iniziative che comportino un aumento del reddito della stessa, purché non comportino obblighi per il locatore.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Rifiuti e rinunce nel diritto civile
12 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il soggetto titolare di una situazione giuridica, di regola, possiede diversi tipi di poteri, tra i quali il potere di rifiutare e il potere di rinunciare ad un diritto inerente la propria sfera. Tali poteri sono espressione del principio di intangibilità della propria sfera giuridica: ogni soggetto è unico titolare e non può vedere modificata la propria situazione per mera volontà di altri soggetti, ma ha sempre il diritto di opporsi a qualsiasi interferenza.In primis, vi è il potere di rifiuto, cioè il potere di impedire una modificazione imposta da altri soggetti. Si distingue tra il rifiuto impeditivo, che interviene prima della eventuale modificazione, ed è volto ad impedire la suddetta interferenza (come avviene nel caso dell’art. 1333 c.c.); e il rifiuto eliminativo, volto a far venire meno una modifica già intervenuta (ad es. quello previsto ai sensi dell’art. 1411 c.c.) Diverso è il potere di rinuncia, cioè il potere di far venire meno un diritto che faceva già parte della propria sfera giuridica. Può essere una rinuncia abdicativa, mediante la quale il soggetto si limita a dismettere un diritto di cui era titolare (ad oggi è riconosciuta la rinuncia abdicativa anche avente ad oggetto diritti di proprietà); le eventuali conseguenze in questo caso sono dovute alla legge. Può aversi anche una rinuncia traslativa, con la quale il soggetto rinuncia ad un proprio diritto con il fine di trasferirlo ad un altro soggetto. Ed infine, una rinuncia liberatoria, mediante la quale il soggetto con la rinuncia al proprio diritto fa venire meno anche una obbligazione di cui era debitore (es. nel caso di diritti condominiali, ai quali sono legate le cd obbligazioni propter rem).
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti


