Qual'è la differenza tra beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile?

Egregio Avvocato
Pubblicato il 12 gen. 2022 · tempo di lettura 2 minuti
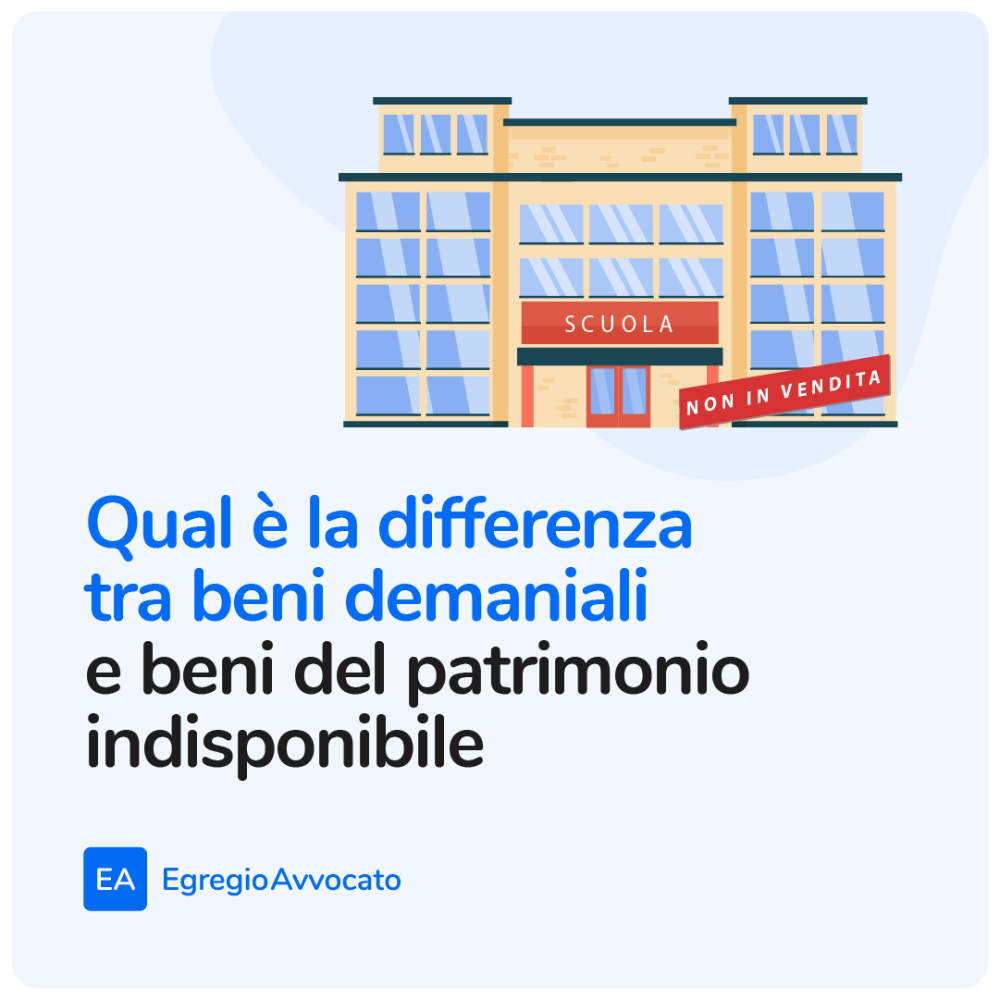
I beni di appartenenza dello Stato, degli enti pubblici e degli enti ecclesiastici possono essere divisi in tre categorie: i beni demaniali, i beni patrimoniali indisponibili ed i beni patrimoniali disponibili.
- I beni demaniali, cioè immobili o universalità di mobili indicati tassativamente all’art. 822 c.c., che possono appartenere solo ad enti territoriali (cioè lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni), che a loro volta si distinguono in beni del demanio necessario, cioè il demanio marittimo, idrico e militare, e beni del demanio accidentale, cioè strade, autostrade, immobili di interesse storico ed artistico, raccolte di musei etc.
- I beni patrimoniali indisponibili, mobili e immobili, che appartengono ad enti pubblici anche non territoriali, che si individuano in via residuale quali beni non appartenenti alla categoria precedente. Anche questi possono essere distinti in beni patrimoniali per natura (quali miniere, acque minerali termali..) e per destinazione (come gli edifici adibiti a sede di pubblici uffici e i relativi arredi).
- I beni patrimoniali disponibili, cioè beni di diritto privato, che potrebbero appartenere a qualsiasi soggetto, non gravati da alcun vincolo o regime particolare.
Per quando riguarda il regime giuridico, la legge prevede che i beni appartenenti alla prima categoria non possano essere alienati né formare oggetto di diritti dei terzi, salvo che nei casi e modi previsti dalla legge. Questi sono pertanto da considerare incommerciabili.
Per i beni della seconda categoria è invece ammissibile la commerciabilità, ma essi sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all’uso pubblico che permane anche se fossero oggetto di negozi traslativi di diritto privato.
Deve tuttavia osservarsi come questa risalente distinzione sia oggi ritenuta meramente nominalistica, anche perché le differenze di regime sono in concreto esigue, anche in punto di commerciabilità. In concreto è infatti difficile individuare dei casi in cui i beni patrimoniali indisponibili possano essere effettivamente alienati senza nuocere alla funzione pubblicistica cui sono attribuiti.
Condividi:
Qual'è la differenza tra beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile?
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Cosa è l’incidente probatorio?
30 nov. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
L’incidente probatorio consiste in una udienza che si svolge dinanzi al giudice per le indagini preliminari in camera di consiglio, e quindi senza la presenza del pubblico, e nella quale si assumono le prove non rinviabili al dibattimento (art. 392 c.p.p.) Tali prove sono assunte nelle medesime forme prescritte per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta con l’esame incrociato.A poter fare richiesta di incidente probatorio sono il pubblico ministero, l’indagato e il suo difensore. La persona offesa non può invece rivolgersi direttamente al giudice, ma può fare richiesta solo mediante il pubblico ministero, il quale valuterà se accogliere o meno l’istanza.Il codice di procedura penale prevede dei casi tassativi di non rinviabilità della prova all’art. 392 c.p.p., tra cui ricordiamo la testimonianza e il confronto, i quali sono ammessi se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un grave impedimento (es. infermità) o di una minaccia affinché non deponga o deponga il falso. Vi sono però anche degli altri mezzi di prova che devono essere assunti nell’incidente probatorio sulla base del solo presupposto che il p.m. o l’indagato ne abbiano fatto richiesta al gip, senza che sia necessario il requisito della non rinviabilità né dell’urgenza. Ciò accade, ad esempio, quando si tratta dell’esame del testimone di giustizia (art. 392, co. 1, lett. d).La funzione dell’incidente probatorio, dunque, è quello di consentire una non dispersione delle prove, e di far salvi anche quei mezzi di prova che altrimenti potrebbero non arrivare in dibattimento. Le prove assunte in sede di incidente probatorio, infatti, hanno lo stesso valore delle prove assunte in dibattimento, e possono essere poste a fondamento della decisione del giudice. Unico limite di utilizzabilità delle prove assunte in sede di incidente probatorio è quello delle prove che siano state assunte senza la partecipazione del difensore dell’imputato, e quindi senza la garanzia del contraddittorio.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Gli atti dell’UE: vediamo le differenze
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'UE adotta diversi tipi di atti legislativi. La prima differenza fondamentale tra tali tipi di atti è il fatto di essere vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni), o non vincolanti (raccomandazioni, pareri). Tra gli atti vincolanti, i regolamenti si caratterizzano per essere atti giuridici che si applicano automaticamente e in modo uniforme a tutti i paesi dell’UE non appena vengono adottati, senza bisogno di essere recepiti nell’ordinamento nazionale. Sono vincolanti in tutti i loro elementi per tutti i paesi dell’UE.Le direttive, invece, impongono ai paesi dell'UE di conseguire determinati risultati, lasciando al tempo stesso la libertà di scegliere i mezzi per realizzarli. Gli Stati membri, quindi, devono adottare le misure necessarie per recepire le direttive nell'ordinamento nazionale e conseguire gli obiettivi stabiliti e devono farlo entro il termine fissato dalla direttiva stessa (generalmente entro 2 anni). Quando un paese non recepisce correttamente una direttiva, la Commissione può avviare un procedimento d’infrazione.Infine, le decisioni si caratterizzano per essere atti giuridici vincolanti per i soli soggetti specifici cui si riferiscono (che possono essere uno o più paesi dell’UE, imprese o cittadini). La parte interessata deve essere informata e la decisione entra in vigore a seguito della notifica. Le decisioni non devono essere recepite nella legislazione nazionale.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
La manipolazione affettiva e narcisismo
14 ott. 2023 • tempo di lettura 7 minuti
Cosa vuole dire manipolazione affettiva La manipolazione affettiva consiste nell'"usare" gli altri per raggiungere i propri interessi. Nella nostra società, questa forma di persuasione viene utilizzata in diversi contesti: nel lavoro, nelle relazioni sentimentali e familiari o persino attraverso la pubblicità.La verità è che, a vari livelli, la maggior parte di noi ha utilizzato una strategia di manipolazione ad un certo punto; ad esempio, nella nostra infanzia, per ottenere un giocattolo o una caramella. Il problema sorge quando diventa la modalità predominante all’interno di una relazione con le altre persone e smette di essere una strategia passeggera.Molte persone che soffrono pensando di trovarsi in relazioni tossiche consultano uno psicoterapeuta, ma spesso accade anche che, durante le sedute, emerga una manipolazione affettiva nella coppia oppure in altre relazioni, da parte di una persona significativa della propria vita. La manipolazione psicologica affettiva può apparire, infatti, in ogni tipo di relazione: pensiamo alla manipolazione affettiva dei genitori, di una madre oppure a quella nell’amicizia. Manipolazione affettiva: come riconoscerla Come riconoscere la manipolazione affettiva? Possiamo dire innanzitutto che l’obiettivo del manipolatore è il controllo. Secondo lo psicoterapeuta e psichiatra A. Lowen, il controllo ha la stessa funzione del potere: proteggere da una possibile umiliazione. Il manipolatore ha una vera e propria mania del controllo e, per prima cosa, controlla se stesso negando i propri sentimenti. Poi deve anche controllare le situazioni in cui è coinvolto e accertarsi che altri non abbiano alcun potere su di lui/lei. Il manipolatore sceglierà un partner sottomesso e insicuro, nel quale saprà trovare a poco a poco la zona vulnerabile che consentirà l’instaurarsi di un rapporto di dipendenza affettiva.Manipolazione affettiva e narcisismoIn alcuni casi colui che mette in atto una manipolazione relazionale è un individuo narcisista. Il narcisista nelle relazioni tende a manipolare l’altro, allo scopo di ottenere soddisfacimento alle proprie richieste. "Se mi vuoi davvero bene, devi farlo" è una delle frasi della manipolazione affettiva più comuni. La manipolazione affettiva del narcisista patologico si esplica anche attraverso le bugie, usate per favorire il suo punto di vista e il suo bisogno di approvazione. A volte, però, è possibile trovare una manipolazione affettiva patologica anche in chi ha una personalità remissiva che, attraverso atteggiamenti differenti, può comunque manipolare l’altro, utilizzando la propria presunta debolezza e fragilità.A differenza delle persone in relazioni sane, in cui i partner dimostrano per lo più reciprocità e cooperazione, un manipolatore emotivo cerca di usare, controllare o persino vittimizzare qualcun altro. Manipolazione psicologica nella coppia: dominare per proteggersiPotere e controllo sono due facce della stessa medaglia, che insieme concorrono a proteggere l’individuo dal sentirsi vulnerabile. L’altro diventa così un oggetto da possedere e distruggere. Mosso da un’invidia incontrollabile e del tutto inconscia, il manipolatore individua nell’altro tutti quegli aspetti che a lui mancano e lavora metodicamente per distruggerli, così da non rappresentare più un pericolo per la propria carente autostima Tecniche di manipolazione affettivaNella manipolazione in amore, i partner che hanno la tendenza a salvare la persona amata da se stessa, sentendosi in dovere di portare avanti la relazione quando il compagno sembra troppo vulnerabile e avendo così la sensazione di essere indispensabili, risultano essere le vittime ideali dei manipolatori.Autocommiserandosi, il manipolatore sa bene come servirsi del partner facendo appello alla sua compassione, comunicando il bisogno di appoggio e d’amore. Le tecniche che mette in atto sono diverse:Colpevolizzare: la persona manipolatrice attribuisce agli altri colpe inesistenti. È in grado di prendere alcune parole di una frase detta dalla vittima, estrapolarle dal contesto ed accusarla. Se il partner ha la tendenza a colpevolizzarsi, diventerà il suo bersaglio preferito: gli verrà confermata la convinzione di essere inetto, ignorante, indifferente, suscitando emozioni difficili da gestire.Proiezione: attraverso il meccanismo della proiezione, il manipolatore si illude di non avere difetti ma li attribuisce agli altri, accusandoli e deresponsabilizzando se stesso spesso in modo inconsapevole e con una tale incoerenza da sembrare sconcertante. Gaslighting: è una delle tecniche di manipolazione mentale usate in amore, ma non solo. Il manipolatore nega di aver fatto oppure detto delle cose con lo scopo di difendersi e non mettere in discussione le proprie affermazioni. In questa maniera crea confusione e distorce la realtà della vittima, che inizierà ad avere sempre meno fiducia in se stessa.Bugie e omissioni: il manipolatore non si limita a chiedere, imporre e ordinare, ma cerca di raggiungere i propri fini per vie traverse come bugie, omissioni, false promesse. È la manipolazione affettiva fatta di bugie a fin di bene, quando per bene si intende il proprio. I manipolatori credono che mentire sia giusto al fine di salvaguardare il proprio ego ed ottenere benefici. Manipolazione affettiva: i sintomiI sintomi da manipolazione affettiva possono essere sottili. Spesso sono difficili da identificare, specialmente quando stanno accadendo a te. Le persone che diventano vittime della manipolazione affettiva possono iniziare a sperimentare cambiamenti nel loro umore o modo di reagire. Alcuni effetti della manipolazione affettiva che possiamo prendere in considerazione sono:Pensieri di vulnerabilità e perdita di sicurezza in se stessi.Diminuzione dell’autostima e difficoltà nel prendere decisioni senza chiedere un consiglio. Tra le conseguenze della manipolazione affettiva ci sono anche sentimenti di confusione quando non si riconosce la propria volontà in determinati atti.Paura di perdere il controllo di se stessi. Potresti credere che tutto ciò che dici sia distorto o che il significato di ciò che volevi trasmettere sia cambiato.Pensiero di non riuscire mai a soddisfare le aspettative dell'altro, che causa senso di colpa verso il partnerConseguenze fisiche come insonnia o disturbi del sonno, tachicardia, vertigini, sudorazione, mal di testa, nausea e altro.Le fasi della manipolazioneChi manipola agisce secondo precisi schemi utili a raggiungere il suo scopo. Possiamo suddividere le sue azioni in fasi precise, che definiscono l’escalation della manipolazione mentale nella coppia.1) La fase seduttivaIn questa fase la vittima verrà fatta sentire la persona più importante del mondo. Senza che se ne renda conto abbasserà le proprie difese tanto da raccontare tutto di sé:debolezzevalori moraliil proprio passatole ferite più profonde.2) La fase della distruzione e dell’odioTutte le risorse della vittima verranno via via distrutte in cambio di:dolore e risentimentoapatia e rabbiadubbi e sensi di colpa.A questo punto, dopo essere stata del tutto prosciugata e non avendo più nulla da "offrire", verrà buttata via come un oggetto inutile.3) Il post e i ritorniUscire da un trauma da manipolazione affettiva sarà difficilissimo: i segni potrebbero rimanere a lungo e la vittima passerà mesi, a volte anni, ripensando ai momenti belli e brutti, rimuginando e tormentandosi, alternando la rabbia alla nostalgia dei primi tempi.Quando sembrerà che tutto sia finito, nel momento in cui la vittima ricomincerà a vivere, ecco che il manipolatore ritornerà sui suoi passi per provare ad annientarla un’altra volta e farla rientrare nel ciclo della violenza da cui era finalmente riuscita a liberarsi. Come uscire dalla manipolazione affettiva Spesso, dietro ad un rapporto di coppia in crisi, ci sono diverse difficoltà che vanno dalla manipolazione alla dipendenza affettiva. Come liberarsi dalla manipolazione affettiva?Uscire dalla manipolazione affettiva è un compito non facile, ma neppure impossibile. Lasciare andare un manipolatore affettivo significa rinunciare alla sua approvazione e visione del mondo, smettere di accontentarsi delle briciole e sintonizzarsi sulla propria approvazione, autostima e visione di sé.Finché cerchi di adattarti alla prospettiva distorta del manipolatore, o cerchi di fargli vedere e capire la tua prospettiva, ti perderai in un labirinto di perplessità e confusione. Uno dei primi step per difendersi dalla manipolazione affettiva sta nel capire cosa senti tu da solo, cosa vuoi fare e poi seguirlo.Il manipolatore emotivo vuole che tu corrisponda a lui e all’immagine che vuole far passare di te. Come abbiamo detto, non corrispondere a ciò che vogliono i manipolatori emotivi ti espone alla loro rabbia e disapprovazione. Liberarsene significa innanzitutto smetterla di compiacere il manipolatore o cercare di ottenere il suo sostegno per ciò che senti, pensi o fai. Questa è la chiave contro la manipolazione affettiva: lasciare andare le sue richieste per prenderti cura dei tuoi desideri e bisogni. Imparare ad ascoltare maggiormente le proprie emozioni, le proprie idee come degne di valore, e come unica e vera bussola per capire qual è la giusta via da intraprendere. Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoDiritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency
Continua a leggere
Che succede se si copia una tesi di laurea?
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La scrittura di una tesi rappresenta spesso il lavoro conclusivo di un percorso di studi, come quello universitario, e deve essere un’opera originale e unica del suo autore, scritta autonomamente e personalmente. Appropriarsi del lavoro di altri con la copiatura dei contenuti è un’attività vietata che può avere diverse conseguenze. Oltre a quelle “interne”, previste dalla singola Università, vi sono quelle previste dalla legge italiana, di natura civilistica ma anche penale e amministrativa. Il soggetto che subisce il plagio, infatti, potrebbe chiedere il risarcimento dei danni determinati dalla violazione del diritto d’autore che tutela la sua opera.La condotta, però, potrebbe integrare anche il reato previsto all’art. 1 della Legge 475/1925.La norma prevede la reclusione da tre mesi a un anno per chiunque, in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o ogni altro grado titolo scolastico o accademico, o per l’abilitazione all’esercizio di una professione o per il rilascio di diplomi o patenti, presenti come propri dissertazioni, studi, pubblicazioni o progetti tecnici o ogni altro lavoro opera di altri soggetti.Il reato è aggravato nel caso in cui viene conseguito l’intento voluto o se il soggetto agisce a fine di lucro o la condotta è abituale.È, inoltre, prevista anche la pena accessoria della revoca del titolo conseguito.Nei casi più gravi, potrebbe essere adottata anche la sanzione amministrativa dell’espulsione dall’Università.Il plagio è escluso se l’autore cita opportunamente le fonti e i testi ai quali si fa riferimento, seguendo le indicazioni all’uopo previste.La giurisprudenza è comunque incline a ritenere che il reato si configuri solo quando ci sia una consistente (e non marginale) riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo altrui.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti



