Qual è la differenza tra la Corte di Giustizia e la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (c.d. Corte EDU)?

Egregio Avvocato
Pubblicato il 16 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
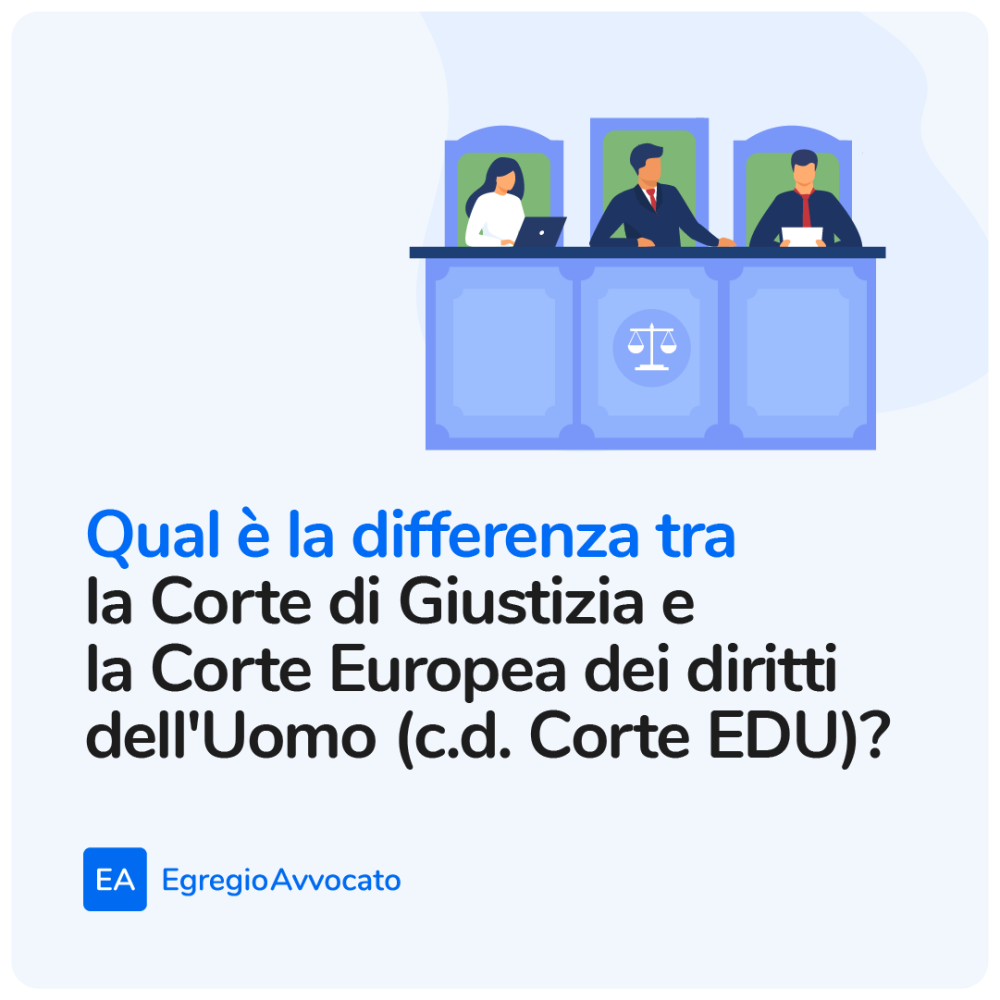
Le due corti, note anche come Corte di Lussemburgo e di Strasburgo in virtù della rispettiva sede, sono due organi differenti e del tutto autonomi.
La Corte di Giustizia è l’istituzione che svolge funzioni di natura giurisdizionale nel sistema dell’Unione Europea, esercitando competenze di tipo contenzioso rispetto ai ricorsi per infrazione, di annullamento, in carenza e per risarcimento, nonché pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati e sulla validità e l’interpretazione degli atti delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione.
Anche le singole persone fisiche o giuridiche possono adire in alcuni casi la Corte, ad esempio esperendo ricorso per annullamento contro gli atti (legislativi o comunque di una istituzione dell’UE) adottati nei loro confronti o loro riguardanti direttamente e individualmente, ancorché a tal fine debbano essere soddisfatte peculiari condizioni (sono in tal senso considerati ricorrenti “non privilegiati”).
La Corte svolge anche funzioni consultive, quando deve rendere pareri (ad es. in caso di accordi internazionali dell’UE).
La Corte EDU, invece, è stata istituita dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (la CEDU), firmata a Roma nel 1950 e promossa dal Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale fondata sul metodo della cooperazione intergovernativa. Quest’ultima, a sua volta, deve essere tenuta distinta dal Consiglio Europeo e dal Consiglio dell’Unione, organi ricompresi nel quadro delle istituzioni dell’Unione Europea.
La Corte EDU si occupa di garantire il rispetto della Convenzione da parte degli Stati contraenti. Essa può essere adita anche dalle persone fisiche per l’accertamento delle violazioni dei diritti tutelati dalla CEDU o dei suoi protocolli da parte dello Stato aderente alla Convenzione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CEDU stessa.
Condividi:
Qual è la differenza tra la Corte di Giustizia e la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (c.d. Corte EDU)?
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Differenza tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza d’interesse
26 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito da cui ne deriva la integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento emesso spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale. La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa che soddisfa pienamente l’interesse azionato. È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi a pieno ed in modo non più retrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, in modo da non far residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice. La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo si caratterizza per il contenuto che si accerta, ossia si indaga il merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione. Decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Acquisti online: il diritto di recesso
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Quando si compra qualcosa online, si tratta di un acquisto “a distanza” e il Codice del Consumo prevede che è sempre possibile esercitare il diritto di recesso, cioè cambiare idea, senza fornire alcuna spiegazione.Soltanto in alcuni casi tassativi previsti dalla legge tale diritto è escluso (di solito per le particolarità del bene, magari personalizzato), e il venditore è obbligato a comunicarlo al momento dell’acquisto.Tale diritto deve essere esercitato entro 14 giorni dal ricevimento del bene. Nel conteggio dei giorni è escluso quello della consegna.Se il venditore non informa il consumatore del diritto di recesso, il termine si considera di 12 mesi.Occorrerà: comunicare il recesso al venditore, che dovrà restituire il prezzo pagato entro 14 giorni, (comprese le spese di spedizione se “standard”); poi restituire i beni ricevuti entro 14 giorni, a proprie le spese dell’invio (salvo il venditore si offra di pagarle).
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Qual'è la differenza tra patteggiamento tradizionale e allargato?
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Con «patteggiamento» si identifica il procedimento penale speciale, indicato nel codice di procedura penale come “applicazione della pena su richiesta delle parti”. È un rito semplificato che consente di eliminare il dibattimento e, in tutto o in parte, l’udienza preliminare. La decisione viene assunta allo stato degli atti, sulla base del fascicolo delle indagini preliminari.Il suo esperimento è incentivato dalla legge, che assicura una riduzione della pena fino a un terzo.Fino al 2003, le parti potevano concordare esclusivamente pene detentive fino a due anni, al netto della riduzione fino a un terzo, sole o congiunti a pena pecuniaria.La legge n. 134 del 2003 ha invece ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto, al punto che oggi si distingue un patteggiamento tradizionale, cioè quello che segue le regole originarie, e uno “allargato”.Il patteggiamento allargato permette all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi su una pena detentiva da due anni e un giorno fino a cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. Si apre quindi alla possibilità di esperire tale procedimento ad un numero maggiore di casi, puniti più severamente.Per questo tipo di patteggiamento, però, il legislatore ha posto all’art. 444 co 1 bis c.p.p. dei limiti, escludendolo al ricorrere di determinate cause oggettive, cioè in relazione ad alcune categorie di delitti (associazione mafiosa e assimilati, terrorismo e violenza sessuale e assimilati), e cause soggettive, riguardanti alcuni tipi di imputati (cioè coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza e i recidivi reiterati di cui all’art 99 co. 4 cp, per i quali il patteggiamento allargato resta parimenti precluso).
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Il consiglio superiore della magistratura (CSM)
14 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è un organo di rilievo costituzionale, cui gli artt. 104, 105, 106 e 107 della Carta fondamentale fanno espressamente riferimento.La principale funzione del CSM è quella di autogoverno della magistratura. Invero, al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza del potere giurisdizionale dagli altri poteri dello Stato, si è reso necessario istituire un organo che fosse del tutto indipendente dagli altri. Ciò si pone in linea con quanto previsto dall’art. 101, comma 2, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Al CSM spettano le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari penali e civili (i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno invece propri organi di governo).Anche la composizione del Consiglio superiore della magistratura è finalizzato a garantire l’indipendenza e l’autonomia dello stesso. L’art. 104 della Costituzione prevede infatti che il Consiglio sia presieduto dal Presidente della Repubblica, e che ne facciano parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune a scelta tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. È tra questi soggetti eletti dal Parlamento in seduta comune che il CSM deve eleggere un Vicepresidente.La durata del CSM è pari a 4 anni e i membri non sono immediatamente rieleggibili.Sempre al fine di garantire l’imparzialità del Consiglio, e di conseguenza l’autonomia e indipendenza del potere giurisdizionale, i soggetti che siano stati eletti come membri del Consiglio non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.Si evidenzia che il CSM è stato nominato per la prima volta all'art. 4 della legge n. 511 del 1907, quindi prima che venisse promulgata la Carta costituzionale. Tuttavia, solo con l’avvento della Carta fondamentale il CSM ha acquisito la sua attuale funzione di organo di autogoverno. Originariamente, invece, ricopriva il ruolo di organo consultivo-amministrativo presso un ministero.Un fatto particolare, e oggetto anche di un’analisi sociologica, è quello che riguarda la componente femminile all’interno dell’organo in esame: le prime donne a diventare componenti del Consiglio Superiore della Magistratura furono nel 1981 la professoressa Ombretta Fumagalli Carulli e la professoressa Cecilia Assanti, entrambe elette dal Parlamento. Soltanto nel 1986 fu eletta dagli stessi magistrati Elena Paciotti. Tuttavia ancora oggi, dopo più di cinquant’anni dall'ingresso in magistratura delle donne, la componente femminile all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura non ha acquisito un ruolo numericamente rilevante.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti


