La ritrattazione nei reati contro l'amministrazione della giustizia

Egregio Avvocato
Pubblicato il 9 mag. 2022 · tempo di lettura 4 minuti
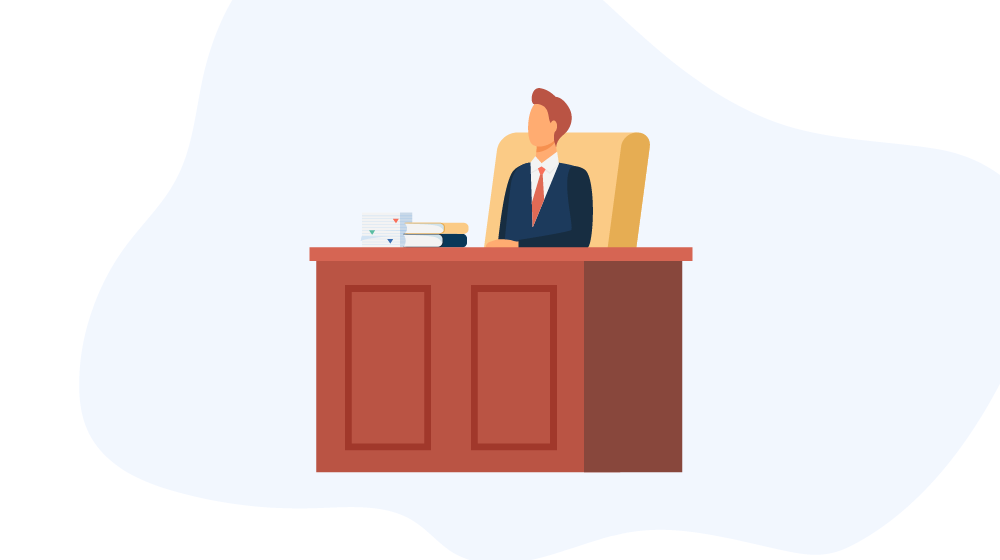
Alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia, fra cui la falsa testimonianza e il favoreggiamento personale, non sono punibili se il colpevole, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero.
- Ambito di applicazione della ritrattazione
- Termine entro il quale è ammessa la ritrattazione
- Ratio e natura giuridica della ritrattazione
1 - Ambito di applicazione della ritrattazione
Come anticipato, l’art. 376 c.p., sotto la rubrica “Ritrattazione”, prevede che non è punibile il colpevole di alcuni reati contro l’Amministrazione della giustizia se il colpevole, nel termine che appresso vedremo, ritratta il falso e manifesta il vero.
I reati che possono essere non punibili sono precisati dallo stesso art. 376 c.p.:
- false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (art. 371-bis c.p.): questo reato punisce chiunque, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false o tace, in tutto o in parte, ciò che sa;
- false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.): punisce chiunque rende dichiarazioni false al difensore nell’ambito delle investigazioni difensive;
- falsa testimonianza (art. 372 c.p.): punisce il testimone che afferma il falso, che nega il vero o che tace, in tutto o in parte, ciò che sa;
- falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.): punisce il perito o l’interprete che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero;
- frode in processo penale e depistaggio (art. 375 co. 1 lett. b) c.p.): punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale, richiesto dall’Autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero o tace, tutto in parte, ciò che sa;
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): punisce il soggetto che, dopo la commissione di un delitto punito con l’ergastolo o la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate da quest’ultima effettuate.
Per andare esente da pena, il colpevole di uno di questi reati deve riconoscere, nell’ambito dello stesso procedimento in cui lo ha commesso, la falsità del proprio operato o delle proprie dichiarazioni e, in piena coscienza e consapevolezza, esteriorizzare di aver reso mendacio e rettificare con il vero. La ritrattazione, in altri termini, deve essere non equivoca, idonea a riconoscere il mendacio e confutarlo nel vero.
Deve trattarsi di un ravvedimento volontario; può però non essere spontaneo, potendo essere determinato dal mero interesse del soggetto attivo di evitare conseguenze sanzionatorie.
Infine, la ritrattazione deve essere completa: non è ammessa in forma parziale.
2 - Termine entro il quale è ammessa la ritrattazione
Nell’ambito del processo penale, la ritrattazione è ammessa non oltre la chiusura del dibattimento, che è il momento immediatamente precedente le conclusioni delle parti.
Nell’ambito del processo civile, invece, la ritrattazione è ammessa fino a che la sentenza civile non è diventata definitiva.
3 - Ratio e natura giuridica della ritrattazione
Ma perché il legislatore dovrebbe volere mandare esente da pena chi è colpevole di aver, a vario titolo, sviato il corretto evolversi della giustizia? Il motivo è che si vuole incentivare l’autore della menzogna a dire il vero, consentendo l’accertamento dei fatti: per spingerlo quindi a ritrattare, gli viene assicurato che non sarà punito.
Dietro la non punibilità per l’autore di un reato che ritratta, quindi, c’è un bilanciamento di interessi: da un lato, l’interesse ad accertare la verità in sede processuale; dall’altro lato, l’interesse a punire la falsità. Fra questi due interessi, prevale quello ad accertare la verità: ormai la falsità è stata posta in essere e si vuole evitare che la stessa possa altresì pregiudicare l’esito del processo.
Se questa è la ratio sottesa, la ritrattazione non può che essere qualificata come causa di non punibilità in senso stretto. Questa categoria comprende dei fatti che sono tipici, antigiuridici e colpevoli ma che, per ragioni di opportunità, non vengono puniti. Come abbiamo visto, l’opportunità sta nel ricercare il corretto svolgimento del processo, accettando di non punire una condotta illecita.
Da ultimo deve rilevarsi la natura soggettiva e personale della causa di non punibilità in esame: di conseguenza, è escluso che la ritrattazione possa operare anche nei confronti dell’istigatore, tranne nel caso in cui il soggetto che abbia istigato a commettere le fattispecie delittuose abbia, poi, convinto l’istigato a ritrattare.
Editor: dott.ssa Elena Pullano
Condividi:
La ritrattazione nei reati contro l'amministrazione della giustizia
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
DIFFAMAZIONE
15 mag. 2023 • tempo di lettura 6 minuti
Diffamazione: una minaccia per la reputazione e la libertà di espressioneIntroduzione: La diffamazione è un argomento di grande rilevanza nella società odierna, in cui le informazioni si diffondono rapidamente attraverso i mezzi di comunicazione e i social media. Con la crescente dipendenza dalla tecnologia e l'accesso quasi istantaneo alle informazioni, il rischio di diffamazione e danni alla reputazione è diventato sempre più significativo. Questo articolo esplorerà la diffamazione, le sue implicazioni legali e le sfide che si pongono nella gestione di questa forma di abuso della libertà di espressione.Definizione di diffamazione: La diffamazione può essere definita come l'azione di comunicare a terzi una dichiarazione falsa che danneggia la reputazione di una persona. Può essere espressa oralmente, per iscritto o attraverso gesti diffamatori. La diffamazione può causare danni significativi alla reputazione di un individuo, influenzando le opportunità lavorative, le relazioni personali e persino la salute mentale dell'individuo coinvolto.Le implicazioni legali: La diffamazione è una questione legale che coinvolge il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla reputazione. Molti paesi hanno leggi specifiche che proteggono i cittadini dalla diffamazione, stabilendo norme per stabilire quando una dichiarazione può essere considerata diffamatoria e quali rimedi legali possono essere intrapresi.Le sfide della diffamazione online: L'avvento dei social media e delle piattaforme di condivisione online ha amplificato il problema della diffamazione. La possibilità di diffondere rapidamente informazioni, spesso senza verifica accurata dei fatti, ha creato un terreno fertile per la diffamazione online. Inoltre, l'anonimato relativo che tali piattaforme possono offrire può incoraggiare comportamenti diffamatori, poiché gli autori delle dichiarazioni possono nascondersi dietro un profilo falso o pseudonimo.Impatto sulla libertà di espressione: La diffamazione solleva anche questioni riguardanti la libertà di espressione. Mentre è fondamentale proteggere la reputazione delle persone da false affermazioni dannose, è altrettanto importante preservare la libertà di espressione e il diritto di esprimere opinioni legittime e critiche. Tuttavia, trovare un equilibrio tra questi due diritti può essere complicato, poiché le norme e le leggi variano da paese a paese e possono comportare un certo grado di soggettività nella valutazione delle affermazioni diffamatorie.Soluzioni possibili: Per affrontare la diffamazione, è essenziale che le piattaforme online adottino politiche e procedure chiare per segnalare e rimuovere contenuti diffamatori. Allo stesso tempo, è importante educare le persone sui rischi associati alla diffamazione e sulla necessità di una comunicazione responsabile. Inoltre, i tribunali devono essere in grado di affrontare in modo tempestivo e imparziale i casi di diffamazione, garantendo una giustizia equilibrata tra la protezione della reputazione e la tutela della libertà di espressione. È importante promuovere la responsabilità individuale nell'uso delle piattaforme di comunicazione online e incoraggiare la verifica dei fatti prima di condividere informazioni potenzialmente dannose.Educazione e sensibilizzazione: Una strategia efficace per combattere la diffamazione è l'educazione e la sensibilizzazione. È necessario promuovere la consapevolezza su cosa costituisce la diffamazione, i suoi effetti dannosi sulla reputazione delle persone e le implicazioni legali ad essa associate. I programmi educativi dovrebbero anche insegnare l'importanza di una comunicazione rispettosa, etica e basata sui fatti.Media responsabile: I media, sia tradizionali che digitali, svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione della diffamazione. È fondamentale che i giornalisti e gli editori adottino standard etici elevati, verifichino accuratamente le fonti e riportino notizie in modo accurato e oggettivo. Inoltre, le piattaforme di social media dovrebbero assumersi la responsabilità di promuovere la condivisione di informazioni affidabili e di prevenire la diffusione di contenuti diffamatori.Leggi aggiornate: Le leggi sulla diffamazione devono essere aggiornate per tener conto dei cambiamenti tecnologici e delle sfide associate alla diffamazione online. È necessario trovare un equilibrio tra la protezione della reputazione e la libertà di espressione, garantendo che le leggi siano chiare, giuste e applicate in modo coerente. Le autorità devono anche essere pronte a rispondere in modo tempestivo ed efficace alle segnalazioni di diffamazione, fornendo un sistema giudiziario accessibile ed equo.Conclusioni: La diffamazione rappresenta una minaccia reale per la reputazione delle persone e per la libertà di espressione. La diffusione delle informazioni attraverso le piattaforme digitali ha amplificato il problema, rendendo urgente l'adozione di misure preventive. Educare le persone, promuovere la responsabilità individuale, incoraggiare un giornalismo etico e aggiornare le leggi sono tutti passi cruciali per affrontare la diffamazione in modo efficace. Solo attraverso un approccio olistico e collaborativo potremo proteggere la reputazione delle persone e preservare la libertà di espressione nella nostra società sempre più interconnessa e digitale.La diffamazione attraverso i mezzi di stampa: responsabilità e conseguenzeIntroduzione: I mezzi di stampa, come giornali, riviste e altre pubblicazioni, hanno un ruolo importante nella società come fonti di informazione e mezzi di espressione. Tuttavia, con questo ruolo di potere e influenza, sorge la responsabilità di fornire notizie accurate e di evitare la diffamazione. In questo articolo, esploreremo il problema della diffamazione attraverso i mezzi di stampa, le implicazioni legali e le conseguenze che possono derivarne per tutte le parti coinvolte.La diffamazione e la sua definizione: La diffamazione può essere definita come la divulgazione di affermazioni false o fuorvianti che danneggiano la reputazione di un individuo o di un'organizzazione. Nel contesto dei mezzi di stampa, questo può includere la pubblicazione di notizie, articoli o opinioni che contengono informazioni non verificate o distorte che possono ledere l'onorabilità di una persona o influenzare negativamente la percezione pubblica su di essa.La responsabilità dei mezzi di stampa: I mezzi di stampa svolgono un ruolo cruciale nel garantire l'accuratezza delle informazioni e la protezione della reputazione delle persone. Essi devono adottare standard etici elevati, verificare accuratamente le fonti, condurre ricerche approfondite e correggere eventuali errori o imprecisioni tempestivamente. La responsabilità giuridica può essere applicata se i mezzi di stampa pubblicano contenuti diffamatori, anche se talvolta possono beneficiare di alcune protezioni legali come la "difesa della verità" o il "privilegio giornalistico".Implicazioni legali e conseguenze: La diffamazione attraverso i mezzi di stampa può avere conseguenze legali significative per entrambe le parti coinvolte. La persona diffamata può intraprendere azioni legali contro il mezzo di stampa per il danno subito alla propria reputazione. I tribunali valuteranno se la diffamazione è avvenuta sulla base di elementi come l'accuratezza delle informazioni, l'intenzione di danneggiare la reputazione e l'effetto sulla persona diffamata. Le conseguenze possono includere richieste di risarcimento danni, rettifiche pubbliche o persino sanzioni penali in casi gravi di diffamazione deliberata.L'importanza dell'etica giornalistica: Per evitare la diffamazione attraverso i mezzi di stampa, è fondamentale promuovere l'etica giornalistica. I giornalisti devono seguire principi di verità, imparzialità, correttezza e responsabilità. Dovrebbero condurre approfondite verifiche dei fatti, cercare il commento di tutte le parti coinvolte e garantire la presentazione equilibrata delle informazioni. Inoltre, è essenziale adottare procedure solide per la verifica delle notizie, la correzione degli errori e la gestione delle denunce di diffamazione. Conclusioni: La diffamazione attraverso i mezzi di stampa rappresenta una minaccia seria per la reputazione delle persone e per l'integrità del giornalismo. È essenziale che i mezzi di stampa adottino standard etici rigorosi, condurre ricerche approfondite e verificare accuratamente le informazioni prima di pubblicarle. La responsabilità giuridica può essere applicata se si diffondono notizie false o dannose. L'etica giornalistica, basata sulla verità, imparzialità e responsabilità, è fondamentale per evitare la diffamazione e preservare l'integrità della professione. È fondamentale promuovere la consapevolezza sui danni causati dalla diffamazione e incoraggiare una comunicazione responsabile e rispettosa. Solo attraverso un impegno collettivo dei mezzi di stampa, dei giornalisti e della società nel suo complesso, possiamo mitigare gli effetti dannosi della diffamazione e preservare la libertà di espressione in modo responsabile.
Continua a leggere
Scritto da:
Dichiarazioni false nell’autocertificazione: è configurabile un reato?
25 feb. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Ormai, da quasi un anno, il nostro Paese, così come il mondo intero, si trova a dover affrontare una emergenza epidemiologica a fronte della quale tantissime libertà fondamentali hanno subìto una forte limitazione. Invero, al fine di impedire una incontrollata diffusione del virus Covid-19, il legislatore ha previsto delle misure di contenimento, tra le quali non è permesso al cittadino di muoversi liberamente nel territorio italiano. Sono previste delle deroghe solo per motivi espressamente indicati (motivi di necessità, lavoro e salute), che devono essere attestati dal privato mediante lo strumento appositamente previsto: l’autocertificazione. Ma quali sono le conseguenze a fronte di una falsità dichiarata in tale autocertificazione?Cosa è l’autocertificazione e quando deve essere utilizzataI diversi tipi di falso in atto pubblico integrabili dal privatoQuando non è integrato il reato di cui all’art. 483 c.p.1 - Cosa è l’autocertificazione e quando deve essere utilizzataNel corso dell’ultimo anno, sarà capitato a chiunque di dover ricorrere all’utilizzo dello strumento predisposto dal legislatore per giustificare un proprio spostamento: l’autocertificazione. Com’è noto, sono state previste forti misure di contenimento, in modo da limitare la diffusione del virus Covid-19, alla luce delle quali è stata particolarmente incisa la libertà di circolazione (sia all’interno della propria Regione, o addirittura della singola città, nei momenti più difficili dell’epidemia; sia all’interno del territorio nazionale, e quindi tra diverse Regioni). In ogni caso, il legislatore ha sempre previsto delle deroghe espresse, permettendo gli spostamenti che fossero motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero gli spostamenti per motivi di salute. È stato quindi inserito sul sito web del Ministero dell’Interno un modello di “autodichiarazione” ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, scaricabile e utilizzabile da qualsiasi cittadino che avesse la necessità di spostarsi, trovandosi in una delle situazioni di deroga espressamente previste.L’autocertificazione, quindi, è quell’atto mediante il quale un soggetto, a seguito del controllo delle Forze dell’Ordine, attesta che il mancato rispetto delle disposizioni in tema di limitazione della libertà di movimento è dovuto ad una delle ragioni previste dal potere esecutivo. Nello specifico, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ciascun individuo è chiamato a dichiarare: le proprie generalità (tra cui, la propria utenza telefonica); di essere consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci al Pubblico ufficiale; di non essere sottoposto alla misura della quarantena; di non essere risultato positivo al virus Covid-19; di essersi spostato dal luogo A con destinazione B; di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio adottate; di essere a conoscenza delle limitazioni ulteriori adottate dal Presidente della propria Regione di appartenenza; di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 D.L. 16 maggio 2020, n. 332 - I diversi tipi di falso in atto pubblico integrabili dal privatoPacificamente, le falsità inerenti il primo punto richiesto dall’autocertificazione, e quindi le proprie generalità, integrano il reato di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” previsto dall’art. 495 c.p., che punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona.Peraltro, nel concetto di “altre qualità” rientrano anche quelle informazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuare il soggetto e consentire la sua identificazione; e quindi, vi rientrano dati come la residenza e il domicilio, la professione, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, le eventuali precedenti condanne e ogni altro attributo che serva ad integrare la individualità della persona.Quindi, il privato può incorrere nel reato di cui all’art. 495 c.p. solo nel caso in cui la falsità attiene ad uno degli elementi sopracitati, e non anche se ad essere falsa è la motivazione della propria presenza in strada. In questo diverso caso, potrebbe essere integrato il diverso reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” previsto all’art. 483 c.p., secondo cui chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.Tale delitto si configura solo nel momento in cui il privato sia obbligato a dire il vero da una norma giuridica (anche extra-penale), in quanto vengono ricollegati specifici effetti probatori all’atto-documento nel quale la dichiarazione viene inserita. Peraltro, non è necessario che l’obbligo di dire la verità sia esplicito, ma può trovare anche un aggancio “implicito” in una norma di legge. È, inoltre, richiesta la sussistenza di un atto pubblico, e non è sufficiente una mera scrittura privata: il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico riguarda solo quelle attestazioni del privato che il pubblico ufficiale ha il dovere di documentare. L’autocertificazione rientra nell’ambito dell’art. 47 D.P.R. 445/00, il quale consente di sostituire l’atto di notorietà con una dichiarazione che abbia ad oggetto, tra gli altri, fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato. In questo modo, l’autocertificazione acquista il potere di comprovare i fatti di cui si è a conoscenza, assumendo efficacia probatoria e natura di atto pubblico. Per quanto concerne l’obbligo di verità imposto al privato, questo si desume dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/00 secondo il quale “le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”, richiamando il precetto di cui all’art. 483 c.p.Pertanto, chi inserisce affermazioni non veritiere nell’autocertificazione, considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è considerato al pari di chi rende dichiarazioni false al Pubblico ufficiale, le quali verranno inserite da quest’ultimo in un atto che è destinato a costituire prova della verità del fatto recepito. Sussistono conseguentemente tutti i requisiti strutturali dell’art. 483 c.p.: obbligo di verità, efficacia probatoria dell’atto, equivalenza tra autodichiarazione e dichiarazioni rese al Pubblico ufficiale.3 - Quando non è integrato il reato di cui all’art. 483 c.p.Si evidenzia che vi sono dei casi in cui il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico potrebbe non sussistere.Ai sensi dell’art. 483 c.p., l’oggetto della falsa attestazione deve essere un “fatto”, e quindi un evento della vita o una circostanza che sono prospettati come già realizzati e/o materializzati nella realtà esteriore, e il cui accertamento è già possibile in rerum natura. Si tratta di quei casi in cui il privato dichiari di essere in strada per “aver già compiuto” una certa azione che venga giustificata dai motivi di deroga del DPCM (es. “sono stato a lavoro presso la sede sita in ...”; “sto tornando a casa dopo aver portato generi alimentari e medicinali a mia madre anziana”, etc.). Nel caso in cui la falsità attenga ad un fatto già compiuto, ben potrà essere integrato il reato di cui all’art. 483 c.p.Diverso è il caso in cui nell’autocertificazione venga esplicitata l’intenzione di compiere un fatto, che però non sia ancora realizzato nella sua completezza. Invero, la dichiarazione, in questi casi, ha per oggetto una mera intenzione (es. “sto andando a fare la spesa”; “sto andando a lavoro”; “sto andando in farmacia per acquistare il medicinale x”), per il quale l’accertamento, e la conformità alla realtà è possibile solo in un momento successivo. Il fatto in sé non è ancora materializzato nella realtà esteriore, e quindi si ritiene non possa essere configurata la fattispecie delittuosa ex art. 483 c.p. In questo caso ad essere attestato è un mero intento, un proposito che sfugge all’oggetto della falsità penalmente rilevante.Ciò appare conforme alla impostazione dell’ordinamento giuridico italiano, secondo cui non si può essere puniti per una mera intenzione o per un’idea, ma richiede invece la sussistenza di una condotta materiale ed esistente in rerum natura. Diversamente, verrebbe violato il principio di offensività e di materialità, tutelato a livello costituzionale dall’art. 25 Cost.In conclusione, sarà necessario distinguere tra diverse condotte:le dichiarazioni mendaci rese in ordine agli elementi identificativi della persona, che assumono rilevanza ai sensi dell’art. 495 c.p.; le dichiarazioni rese in ordine ai fatti già compiuti, rilevanti con riguardo all’art. 483 c.p.;ed infine, le dichiarazioni false riguardanti le intenzioni (e, quindi, tutte quelle che concernono le “destinazioni” dei propri spostamenti) che, in quanto future ed incompiute, non possono rappresentare “fatti” su cui fondare la sanzione penale per il reato di falso da ultimo esaminato.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Cosa è lo stalking organizzato e il controllo mentale
21 lug. 2023 • tempo di lettura 5 minuti
Lo stalking organizzato è un sistema di “guerra non convenzionale/psicologica“, di persecuzione e di tortura che ha come scopo l’eliminazione di un obbiettivo, di solito attivisti politici non controllati, ricercatori delle cospirazioni, gente che si oppone all’immigrazione e al globalismo, spie, gente che tenta di denunciare gravi crimini e abusi perpetrati da parte di grandi aziende o organizzazioni statali eccetera. Lo stalking organizzato è secondo me un metodo per portare avanti la dittatura del nuovo ordine mondiale.Lo stalking organizzato è un programma simile al programma COINTELPRO dell’FBI in cui l’FBI prendeva di mira, sabotava, screditava ed eliminava attivisti politici in diversi modi e si infiltrava in organizzazioni politiche. È anche simile – una combinazione tra i due programmi – al progetto MKULTRA della CIA, visto che alcune vittime prese di mira (Targeted Individuals) vengono attaccate con armi elettroniche (armi ad energia diretta e controllo mentale) e usate come cavie umane per testarle.Lo stalking organizzato si potrebbe definire anche come un nuovo “Phoenix Program” su scala globale, un programma in cui la CIA in Vietnam selezionava obbiettivi civili che venivano messi in delle liste per poi venire neutralizzati/eliminati.Lo stalking organizzato è anche molto simile alla tecnica “Zersetzung” che veniva usata dalla STASI, la polizia segreta della Germania dell’est durante il comunismo, in cui 1 cittadino su 6 lavorava come collaboratore non ufficiale per i servizi segreti.“Una guerra silenziosa si sta verificando nelle città di tutto il mondo. Viene coperta dai media, dalla psichiatria, dalle organizzazioni non governative (ONG) e dai politici. Ora che l’élite finanziaria ha finito di usare le forze armate americane e i loro alleati per conquistare nazioni con l’obbiettivo del totale dominio mondiale, stanno neutralizzando individui e gruppi di individui che vivono tra le popolazioni civili che ancora resistono. Per lo scopo hanno reclutato gran parte della popolazione civile per perseguitare coloro che sono stati identificati come nemici. Le “forze di sicurezza” stanno conducendo operazioni psicologiche (PsyOps) contro civili e torturandoli con armi ad energia diretta. L’intera operazione è al servizio di un gruppo di ricchi psicopatici che governano la nostra società, come parte di una rivoluzione mondiale creata per portare avanti una dittatura mondiale conosciuta come il Nuovo Ordine Mondiale.” – New world War: Revolutionary Methods for Political Control by Mark M. RichLo stalking organizzato è un operazione civile-militare (CMO) illegale/criminale (mettiamo che abbiano una qualche legge o ordine esecutivo che li permette di portare avanti queste operazioni, questa gente hanno truffato in massa e mentito per ottenere tali leggi anticostituzionali/criminali e quindi sono illegali sotto ogni aspetto come l’operazione stessa) portata avanti da una coalizione internazionale formata da lavoratori, aziende, civili, militari, agenti segreti, forze di polizia, organizzazioni non governative (NGO) e organizzazioni intergovernative (IGO). I metodi e le tattiche principali usate da questa forza multinazionale per neutralizzare/distruggere obbiettivi civili sono le “operazioni psicologiche” (PsyOps) e le “armi non letali“.“C’è un protocollo di base usato in ogni nazione della NATO con il quale cominciano le operazioni di stalking organizzato.Iniziano con la sorveglianza illegale degli obiettivi, il monitoraggio della loro vita privata e violando il loro domicilio. Questo viene fatto in modo da profilare i tratti della loro personalità.‘C’è un protocollo di base con il quale gli stalkers iniziano’, afferma McKinney, ‘ma l’individuo bersaglio (Targeted Individual) contribuisce alla modifica.’Dr. Munzert parla fondamentalmente dello stesso modello che descrive come una “strategia a doppio taglio”.‘Una parte consiste nell’attaccare le vittime con armi a microonde (armi ad energia diretta)’ e l’altra parte della strategia, dice, ‘è quella di cercare di fare passare gli individui bersaglio come pazzi.’” – The Hidden Evil Mark M. Rich“Lo stalking organizzato è una forma di terrorismo utilizzato nei confronti di un individuo in cui si tenta di ridurre la qualità della vita di una persona e fare in modo che: abbia un esaurimento nervoso, venga incarcerata, istituzionalizzata, subisca costantemente dolore mentale, emotivo o fisico, diventi un senza tetto e finisca con il suicidarsi. Il tutto viene fatto usando accuse ben orchestrate, bugie, diffamazioni, false indagini, intimidazioni, minacce dirette o subliminali, vandalismo, furti, sabotaggi, torture, umiliazioni, terrorismo psicologico e molestie in generale. È un sistema in cui molti agiscono contro un individuo nella comunità venendo coordinati da un organizzatore che recluta gente per partecipare nella sistematica persecuzione di un individuo e per terrorizzarlo.”La maggior parte degli “stalkers” – dipende dai livelli – non sanno di cosa si tratti veramente, pensano che sia una forma di mobbing organizzato al di fuori del posto di lavoro e vengono usati per sensibilizzare la vittima a nuovi inneschi e torturarla. O viene detto loro che l’obbiettivo preso di mira (Targeted Individual) è un individuo pericoloso o potenzialmente pericoloso e che deve per un qualche motivo essere controllato. No, al contrario di quello che molti pensano lo stalking organizzato non ha niente a che fare con il mobbing, punire/controllare criminali o con il “normale” stalking in cui un uomo – o donna – molesta e perseguita la sua ex. Nello stalking organizzato è l’intero stato, l’imprenditoria privata eccetera che ti fa stalking non degli individui che agiscono di propria iniziativa.Alcune delle tattiche più usate nello stalking organizzato sono: le campagne diffamatore, campagne di rumore, campagne di sensibilizzazione (PNL), mirroring, operazioni psicologiche (PsyOps), Gaslighting, Street Theater e altro.Tattica di stalking organizzato – Campagne di rumoreQuesta tattica consiste nel molestare costantemente la vittima con rumori, generare rumori con trapani e altri macchinari, sbattere intenzionalmente porte e tutto il resto. Serve chiaramente per tenere la vittima in uno stato di stanchezza e confusionale e per sensibilizzare la vittima a dei suoni per la tortura e le persecuzioni.Tattica di stalking organizzato – Campagne di sensibilizzazione PNLQuesta tattica consiste nel sensibilizzare – con la ripetizione – la vittima a gesti, oggetti, parole, suoni, simboli per torturarla e perseguitarla. Serve per fare sapere alla vittima che viene seguita ovunque mostrando il simbolo, la parola eccetera a cui è stata sensibilizzata. Gli stalkers cercano di sensibilizzare la vittima a più parole, oggetti, scene eccetera possibile così da torturarla molto di più ma senza dare nell’occhio perché una volta è un numero, una volta è un gesto e così via. Questi oggetti, gesti, suoni eccetera vengono poi associati a emozioni di tipo negativo come la rabbia, l’impotenza e la paura diventando così degli inneschi PNL (NLP Triggers) che evocano appunto emozioni di tipo negativo. Gli stalkers usano eventi che occorrono anche normalmente e ne aumentano la frequenza.Gli stalkers nascondono gran parte delle loro molestie usando una semplice formula.Da quello che ho potuto constatare le formule base sono:La frequenza: descrive quanto spesso un evento accada. Riguarda anche il numero di atti durante un singolo evento.Durata: riguarda la lunghezza di un singolo evento. Riguarda anche la natura delle molestie che sono continue e non finiscono mai.Intensità: l’amplificazione degli atti come fare rumore, la vista, l’affollamento, eccetera all’interno di un evento.
Continua a leggere
Se il ladro fugge con l’auto risponde del delitto di furto o rapina?
11 nov. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Prima di rispondere al quesito odierno è necessario preliminarmente tracciare una linea di confine tra il delitto di rapina di cui all’art. 628 c.p. ed il delitto di furto di cui all’art. 624 c.p..Ebbene, si tratta di due fattispecie caratterizzate dai medesimi elementi costitutivi, ovvero “sottrazione della res ed impossessamento”, il cui discrimen va individuato nelle modalità della condotta, essendo necessario, ai fini dell’integrazione del delitto di rapina, che la stessa si realizzi mediante violenza o minaccia.In particolare, l’art. 629 c.p. disciplina due ipotesi di rapina: la rapina propria, se la violenza e la minaccia sono poste in essere prima della sottrazione della res, allo scopo di coartare la volontà della persona offesa; e la rapina impropria, quando la condotta violenta o minacciosa viene realizzata successivamente alla sottrazione della res, al fine di scoraggiare la reazione del soggetto passivo ed assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità.Tornando al quesito odierno, una questione molto dibattuta nelle aule giudiziarie è se la fuga con l’auto da parte del ladro, che tenta di sottrarsi alle forze di polizia, possa integrare gli estremi della violenza impropria e quindi giustificare un mutamento in pejus della fattispecie contestata, ovvero dal reato di furto a quello di rapina impropria.Orbene, secondo la Corte di Cassazione, costituendo la mera fuga una forma di resistenza passiva, affinché possa assumere rilievo penale è necessario che si realizzi attraverso manovre tali da creare una situazione di generale e oggettivo pericolo (Cass 2019/44860).Alla luce di un tale orientamento, molti giuristi e non si sono chiesti se anche la mera violazione del Codice della Strada possa ritenersi sufficiente ad integrare una situazione di oggettivo pericolo. A fugare ogni dubbio è un risalente orientamento giurisprudenziale della Cassazione che, pronunciandosi su un caso di resistenza a p.u., ha chiarito che “il fuggitivo che passa con il rosso, sia pur a forte velocità, non commette il reato di resistenza a p.u,, non essendo sufficiente la mera violazione di una o più norme del codice della strada (Cass. 2002/35448).In definitiva, sarà sempre necessario accertare in concreto se la condotta posta in essere dal reo abbia determinato un effettivo pericolo per l’incolumità di terzi o della persona offesa. In assenza di un tale presupposto, potrà dirsi integrato il meno grave delitto di furto, ex art. 624 c.p..
Continua a leggere
Scritto da:
Commenti
Non ci sono commenti




