La clausola penale

Egregio Avvocato
Pubblicato il 1 apr. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
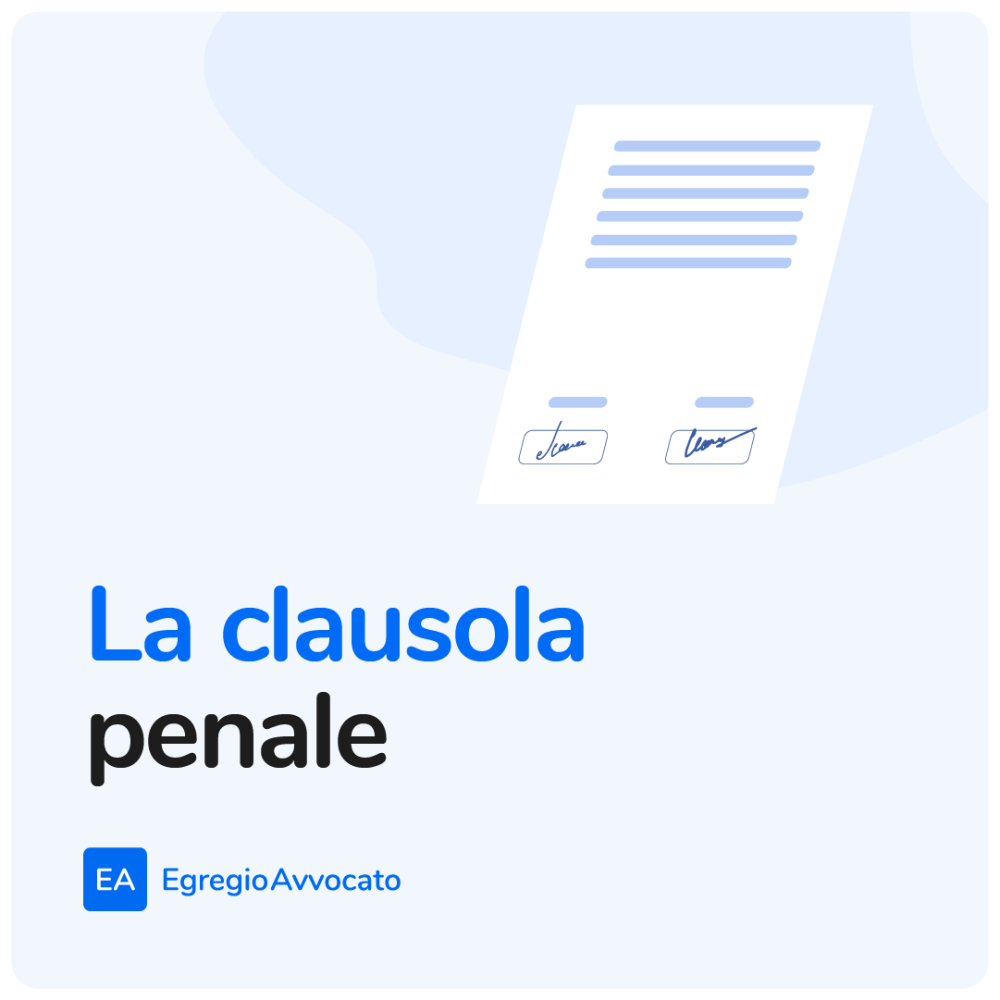
Un istituto che viene spesso assimilato a quello della caparra confirmatoria (già visto nei post precedenti) è quello della clausola penale, che trova la sua disciplina nell’art. 1382 c.c.
In particolare, la clausola penale prevede che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, la quale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, fatta salva la possibilità di prevedere la risarcibilità del danno ulteriore.
Tuttavia, è opportuno evidenziare le differenze tra le due fattispecie.
Da un punto di vista strutturale, la clausola penale è solo promessa; mentre la caparra confirmatoria è una clausola reale, e quindi si perfeziona con la consegna della res.
Inoltre, mentre normalmente la clausola penale grava solo su una parte, la caparra confirmatoria è bilaterale, è un vincolo per entrambe le parti.
Poi ancora, non è prevista la possibilità di rinunciare alla clausola penale e al massimo si può avere il risarcimento del danno ulteriore; mentre la caparra è rinunciabile e si può decidere di operare con i rimedi generali.
Infine, per la clausola penale è espressamente prevista la riduzione ad equità se manifestamente eccessiva; mentre è fortemente controverso se questo potere sia estensibile anche alla caparra confirmatoria.
Condividi:
La clausola penale
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Cosa è la ricognizione?
17 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
La ricognizione è un mezzo di prova mediante il quale, ad una persona che abbia percepito con i propri sensi una persona o una cosa, si chiede di riconoscerla individuandola tra altre simili. Momento fondamentale nello svolgimento della ricognizione, soprattutto di persone, è la cd. predisposizione della scena. In assenza di colui che è chiamato ad effettuare il riconoscimento, il giudice dispone che siano presenti almeno altre due persone (definite come distrattori), che siano il più possibile somiglianti “anche nell’abbigliamento” a quella sottoposta a ricognizione. Quest’ultima è invitata a scegliere il proprio posto rispetto alle altre persone, curando che si presenti, ove possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata ad operare il riconoscimento. Solo quando la scena è pronta, potrà entrare colui che deve effettuare il riconoscimento, il quale dovrà quindi indicare il soggetto che ritiene essere la persona alla quale il reato è attribuito. Molto spesso la ricognizione avviene in giudizio mediante degli album fotografici predisposti dalla Polizia di Stato, i quali riportano una serie di foto di soggetti tendenzialmente simili tra loro e a ognuno dei quali è riconosciuto un numero. Solo alla fine dell’album sarà indicata anche la cd. legenda, ove ogni numero corrisponde al nome del soggetto in foto. Il soggetto chiamato ad effettuare la ricognizione dovrà quindi indicare il numero che corrisponde alla foto della persona che ritiene autore del reato, e sarà poi il giudice ad associare quel numero al nome. Può accadere anche che, nel corso della deposizione dibattimentale, al testimone sia chiesto se riconosce tra i presenti in aula la persona alla quale il reato è attribuito. In questo caso, sembrerebbe che la testimonianza fornisca lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto mediante una ricognizione vera e propria, senza però avere le formalità che invece sono richieste per la ricognizione. La giurisprudenza sostiene che si tratti di una cd ricognizione informale, che si possa considerare come prova atipica e come tale utilizzabile. La dottrina obietta, però, che le formalità della ricognizione sono poste a tutela dell’attendibilità del risultato e che un riconoscimento effettuato in dibattimento, nel corso dell’esame incrociato e senza la presenza di distrattori, sia una prova che aggira le garanzie richieste dal c.p.p. e che fornisce un risultato non attendibile.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Qual'è la differenza tra difensore d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato?
29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La difesa d’ufficio è un istituto previsto dall’ordinamento per garantire che vi sia sempre la difesa tecnica dell’imputato, in ogni fase del procedimento in cui serva il suo intervento, qualora l’imputato non abbia ancora nominato un difensore o nel caso in cui ne sia rimasto privo per qualsiasi motivo. A tal fine, è previsto che quando il giudice, il P.M. o la polizia giudiziaria devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore, devono chiedere il nominativo di un difensore d’ufficio ad un apposito ufficio presso l’ordine forense di ciascun capoluogo di corte d’appello, attinto da un elenco di avvocati a tal fine predisposto, composto da soggetti che hanno fatto richiesta di iscrizione. Successivamente, viene dato avviso dell’atto che sta per essere compiuto al difensore, il quale ha obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.Il patrocinio a spese dello Stato consente, invece, di porre a carico dello Stato le spese di assistenza, difesa e rappresentanza delle parti processuali che abbiano un reddito annuo (calcolato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) non superiore a 11.493,82 euro.Di recente, il patrocinio a spese dello Stato è stato utilizzato anche per provvedere alla difesa di persone ritenute meritevoli di una particolare tutela, quali:le persone offese dai reati di violenza familiare o di genere, in deroga ai limiti di reddito;parimenti, per gli orfani di crimini domestici;la persona prosciolta, anche con archiviazione, dall’imputazione di omicidio verificatosi in presenza di legittima difesa domiciliare.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Differenze: diritto soggettivo e interesse legittimo
16 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Nel diritto amministrativo odierno la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo ha assunto una rilevanza fondamentale: nel nostro ordinamento vi è un cd. doppio binario di giurisdizione, cioè si ha una giurisdizione ordinaria o una giurisdizione amministrativa a seconda che il privato richieda la tutela dell’uno o dell’altra situazione giuridica soggettiva.In particolare, a differenza di quanto avveniva in precedenza, oggi sia il diritto soggettivo sia l’interesse legittimo sono delle situazioni giuridiche meritevoli di essere tutelate, e l’interesse legittimo non deve essere considerato un quid minus rispetto al diritto soggettivo, ma invece una situazione giuridica soggettiva avente pari dignità. Questo è l’esito di una lunga evoluzione giurisprudenziale, che trova fondamento anche nel fatto che l’art. 24 della Costituzione ponga le due situazioni sullo stesso piano. Tuttavia, qualche differenza comunque permane. Il diritto soggettivo, infatti, gode di una tutela assoluta e incondizionata, che non può essere in alcun modo sacrificata in favore dell’interesse pubblico. La giurisdizione preordinata alla sua tutela è quella ordinaria, e il giudice ordinario possiede il solo potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo lesivo (artt. 4 e 5 Laac). L’interesse legittimo, invece, gode di una tutela relativa e condizionata: la Pubblica amministrazione ha il potere di sacrificare l’interesse del privato in favore di un interesse pubblico, e quindi legittimamente di non soddisfare la pretesa del privato. A fronte di un interesse legittimo, la giurisdizione si incardina dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha dei poteri più incisivi rispetto al giudice ordinario, prima di tutti quello di annullamento del provvedimento.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
È obbligatorio denunciare un reato?
13 gen. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
La denuncia di un reato è, come regola generale, facoltativa: la scelta se denunciare o meno un reato di cui si abbia conoscenza è, infatti, rimessa al senso civico di ciascuno, salvi alcuni casi tassativamente indicati dalla legge.Premessa: caratteri generali della denunciaLa denuncia da parte dei privatiLa denuncia da parte di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e agenti di polizia giudiziariaLa denuncia da parte del difensore1 - Premessa: caratteri generali della denunciaLa denuncia è una notizia di reato: è, cioè, un’informazione che permette alle autorità giudiziarie (in particolare al Pubblico Ministero) di venire a conoscenza di un illecito penale.A differenza della querela (per un approfondimento sulla differenza fra denuncia e querela vi rimandiamo qui), la denuncia può essere presentata da qualsiasi persona abbia avuto notizia di un reato procedibile d’ufficio. I reati procedibili d’ufficio sono quelli in cui lo Stato procede nei confronti dell’autore reato a prescindere dalla volontà della persona offesa, cioè anche se quest’ultima non sporge querela o se addirittura non vuole che il colpevole sia processato. La maggior parte dei reati è procedibile d’ufficio: ricordiamo, a titolo di esempio, il furto in abitazione, la rapina nonché i più gravi reati contro la persona, come l’omicidio. La denuncia deve contenere, ai sensi dell’art. 332 c.p.p., l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, l’indicazione della data in cui viene presentata, le fonti di prova già note nonché, se conosciute, le generalità della persona cui il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire sui fatti.La denuncia può essere scritta o orale e può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente al Pubblico Ministero.La denuncia, infine, deve essere sottoscritta dal denunciante: se è anonima non può essere utilizzata. 2 - La denuncia da parte dei privatiL’art. 333 c.p.p. pone la regola generale secondo cui “Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia”. Il nostro codice di rito, quindi, lascia decidere discrezionalmente a ciascuno se presentare denuncia per un reato di cui abbia notizia.Vi sono, però, cinque ipotesi in cui il privato è obbligato a denunciare:quando sia un cittadino italiano e abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato punito con la pena dell’ergastolo (si tratta, ad esempio, del delitto di attentato contro il Presidente della Repubblica): se non lo fa, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa;quando abbia ricevuto cose provenienti da delitto: l’omessa denuncia è punita con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda;quando abbia notizia di materie esplodenti situate nel luogo in cui vive, pena l’arresto da 3 a 12 mesi o l’ammenda;quando abbia subito un furto di armi o esplosivi: in caso di violazione, è prevista un’ammenda;quando abbia avuto conoscenza del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione: se non lo fa, è punibile con la reclusione fino a 3 anni.3 - La denuncia da parte di pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e agenti di polizia giudiziariaI pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio dei quali vengano a conoscenza sia nell’esercizio delle funzioni – cioè durante l’orario di lavoro – sia a causa della funzione o servizio (artt. 361 e 362 c.p.p.). Sono ritenuti incaricati di pubblico servizio, ad esempio, gli insegnanti pubblici: questi, ad esempio, se viene a conoscenza che una sua allieva subisce maltrattamenti in famiglia deve denunciarli, anche se lo apprende fuori dall’orario di lavoro. Anche i medici dipendenti pubblici sono considerati incaricati di un pubblico servizio: ne consegue che hanno l’obbligo di denuncia di tutti i reati procedibili d’ufficio di cui abbiano avuto conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni. Il medico privato, invece, ha l’obbligo di referto di cui all’art. 365 c.p.p.: si tratta di una particolare forma di denuncia cui è tenuto l’esercente la professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza o operi in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. Il referto deve essere trasmesso alle autorità inquirenti entro 48 ore, a meno che il referto possa esporre la persona assistita a procedimento penale: in questo caso l’obbligo viene meno.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, invece, hanno l’obbligo di denunciare tutti i reati procedibili d’ufficio di cui siano venuti a conoscenza, anche fuori dal servizio svolto (art. 361 co. 2 c.p.p.). 4 - La denuncia da parte del difensoreAi sensi dell’art. 344-bis c.p.p., il difensore e i suoi ausiliari non hanno un obbligo di denuncia neppure in relazione ai reati di cui abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte: questi soggetti sono in ogni caso vincolati al segreto professionale. Editor: dott.ssa Elena Pullano
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti


