Violazione del codice della strada: impugnazione ed altri rimedi

Egregio Avvocato
Pubblicato il 10 mag. 2021 · tempo di lettura 5 minuti
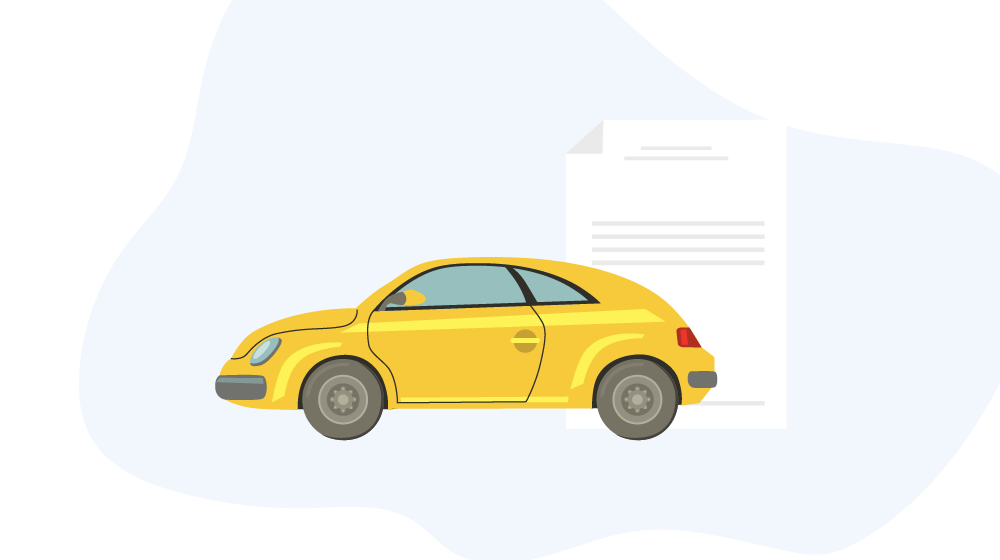
Il cosiddetto “Nuovo Codice della Strada” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, venendo più volte integrato, aggiornato e modificato.
La violazione di una norma del Codice della Strada comporta, come ovvio, la comminazione di una sanzione amministrativa: la più comunemente nota “multa”.
Ma quali sono le alternative per chi dovesse ricevere la contestazione immediata o la notifica differita di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada?
- Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
- Il ricorso al Prefetto
- Il ricorso al Giudice di Pace
- Quali sono i possibili vizi del provvedimento sanzionatorio?
1 - Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
Una prima possibilità concessa all’utente della strada destinatario di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada è fornita dall’art. 202 dello stesso codice, laddove si prevede il c.d. pagamento in forma ridotta.
Difatti, per tutte le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il Codice della Strada stabilisce che il trasgressore sia ammesso a pagare, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme che abbia violato.
Con l’ulteriore specificazione che tale somma si riduce del 30% nel caso in cui il pagamento dovesse essere effettuato entro cinque giorni dalla detta contestazione o notifica.
Tuttavia, questa possibilità non è sempre concessa. Infatti, lo stesso articolo 202 prevede che il pagamento in forma ridotta non sia possibile nei casi di violazioni più gravi, quali ad esempio quelle che prevedono la confisca del veicolo o la sospensione della patente.
2 - Il ricorso al Prefetto
Altra via percorribile è quella di presentare ricorso al Prefetto competente per territorio al fine di contestare la fondatezza del verbale di accertamento oppure far valere eventuali vizi di legittimità.
Il ricorso al Prefetto – disciplinato dagli articoli 203 e 204 del Codice della Strada – deve essere presentato, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del verbale, al Prefetto del luogo della violazione contestata.
Il Prefetto dovrà esaminare il ricorso e l’eventuale materiale probatorio acquisito insieme alle controdeduzioni dell’organo che ha accertato la violazione e, al termine dell’istruttoria – comunque non oltre 120 giorni, pena il silenzio – accoglimento del ricorso – adotta il proprio provvedimento.
In particolare, il Prefetto potrà adottare, in caso di accoglimento del ricorso, un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti oppure, in caso di rigetto, un’ordinanza – ingiunzione con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione accertata.
3 - Il ricorso al Giudice di Pace
Avverso l’ordinanza di rigetto del Prefetto o, anche, direttamente avverso il verbale di accertamento della violazione, a pena di inammissibilità entro il termine di trenta giorni è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace competente per territorio.
In questi giudizi il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza rivolgersi, quindi, ad un avvocato.
L’atto introduttivo del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è il ricorso che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla legge: indicazione dell’autorità giudiziaria competente, indicazione delle generalità del ricorrente, individuazione della pubblica amministrazione convenuta, indicazione degli estremi dell’atto da impugnare, esposizione dei fatti e dei motivi su cui si fonda il ricorso, nonché indicazione di mezzi di prova e documenti che si offrono in comunicazione.
Ovviamente sono previsti dei costi, consistenti nel pagamento del contributo unificato in base al valore della controversia.
Il relativo giudizio si concluderà con una sentenza emessa dal Giudice di Pace, la quale potrà essere di accoglimento, con conseguente annullamento, in tutto o in parte della sanzione amministrativa opposta, ovvero di rigetto, con condanna al pagamento della sanzione della quale procede egli stesso a determinare l’importo.
In caso di condanna, il pagamento dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza.
Avverso tale sentenza, il ricorrente opponente potrà proporre appello dinanzi al Tribunale competente e, eventualmente, ricorso per Cassazione rispetto alla sentenza del Tribunale stesso, ma in entrambi i casi necessariamente dovrà avvalersi della difesa tecnica a mezzo di un avvocato.
4 - Quali sono i possibili vizi del provvedimento sanzionatorio?
Tra i possibili motivi di ricorso – sia esso davanti al Prefetto o al Giudice di Pace – certamente va menzionato l’accertamento della sussistenza di vizi che rendano nullo il provvedimento amministrativo di constatazione della violazione a norme del Codice della Strada.
Tali vizi sono molteplici, ma è possibile esaminare i principali.
In primo luogo, è opportuno ricordare che un verbale affinché si possa reputare legittimo deve essere notificato tempestivamente nel termine massimo di novanta giorni dall’illecito contestato. Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la contravvenzione è da reputarsi nulla.
Il Codice della Strada, inoltre, prevede che il verbale debba contenere, obbligatoriamente, tutta una serie di elementi che, mancando, lo viziano da un punto di vista formale. Ad esempio, sono vizi di forma l’omessa indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione contestata oppure l’omessa o l’errata indicazione delle norme violate.
Va, comunque, precisato che un vizio di forma non sempre rende nullo un verbale. Difatti, tale effetto si ha solamente nell’ipotesi in cui l’errore comporti una compromissione dei diritti di difesa, garantiti dalla Costituzione, del contravventore. Ne consegue che gli errori non comporteranno nullità se compensati da altri elementi contenuti nel medesimo verbale.
Caso particolare e certamente discusso è rappresentato dalla mancata o non corretta indicazione della norma violata.
Come detto questo elemento è certamente essenziale ma, come ha anche specificato la Corte di Cassazione (sul punto si veda Cass. Sent. n. 11421/2009), la sua omissione o errata indicazione non comporterà nullità della contestazione laddove il verbalizzante abbia in ogni caso descritto in maniera completa ed esauriente il fatto contestato, informando della possibilità del pagamento in misura ridotta o dei ricorsi esperibili dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace e, in sostanza, non ledendo il diritto di difesa del contravventore.
Editor: avv. Marco Mezzi
Condividi:
Violazione del codice della strada: impugnazione ed altri rimedi
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Mio padre mi ha diseredato: può farlo? - La diseredazione.
29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La diseredazione è la disposizione mediante la quale il testatore esclude dalla successione un proprio successibile ex lege.Oggi la diseredazione nell’ordinamento giuridico italiano è ammessa, anche nel caso in cui sia l’unica disposizione contenuta nel testamento. L’autonomia testamentaria, infatti, è espressione dell’autonomia dei privati ed è particolarmente ampia.Tuttavia, il problema si pone nel caso in cui si voglia diseredare un cd. legittimario, ovvero, un soggetto che ha sempre diritto ad una quota del patrimonio (cd. quota di legittima), che viene individuato dalla legge nel coniuge, nei figli, e negli ascendenti nel caso in cui non vi siano figli. La tesi che prevale in giurisprudenza è quella che considera inammissibile la diseredazione del legittimario, che si porrebbe in contrasto con l’art. 549 c.c., il quale prevede la nullità di pesi e condizioni poste sulla quota di legittima; e con l’art. 457 c.c., che prevede che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti dei legittimari. Alla luce di questa interpretazione, se si viene diseredati dal proprio padre non solo si avrà la possibilità di agire con l’azione di riduzione a tutela della propria quota di legittima, ma anche di far valere la invalidità della stessa disposizione testamentaria.Si evidenzia, tuttavia, che nel 2012 è stato inserito un nuovo articolo, il 448 bis c.c., il quale prevede espressamente la possibilità per il figlio di diseredare il proprio padre, e, quindi, contempla la possibilità di diseredare un legittimario. Secondo una prima tesi l’art. 448 bis è norma eccezionale, come tale non estendibile analogicamente, a conferma che di regola non è mai possibile diseredare un legittimario; secondo una diversa tesi, invece, è sempre possibile una diseredazione del legittimario, e la norma è si eccezionale, ma per il solo fatto che il legittimario non potrebbe neanche esperire l’azione di riduzione in questi casi.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
La reputazione online dei minori e il ruolo dei genitori nella tutela della privacy digitale
23 feb. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
L’uso diffuso di strumenti digitali e social network ha trasformato profondamente la gestione della vita privata, anche per i soggetti più giovani. Ciò che viene pubblicato online o condiviso tramite applicazioni di messaggistica rischia di sfuggire al controllo dei genitori e, soprattutto, può essere riutilizzato per scopi impropri o illeciti. Tale rischio è amplificato nel caso dei minori, la cui identità digitale può essere definita e condizionata già dai primi anni di vita attraverso la diffusione di immagini o informazioni personali.Quali sono i rischi connessi allo “sharenting”, ovverosia alla condivisione e pubblicazione di materiale video-fotografico dei propri figli sui social network? Secondo il Garante per la protezione dei dati personali e studi recenti:Perdita di controllo dei dati: le immagini pubblicate sui social possono essere salvate e depositate su dispositivi personali di pedofili o di chi commercia materiale illecito sul dark web. È estremamente difficile stimare il numero di immagini di bambini presenti sul dark web dopo essere state pubblicate sulle piattaforme social.Rischi per la reputazione futura: la diffusione di immagini contribuisce alla costruzione dell’identità digitale del minore, che in futuro potrebbe non approvare l’immagine pubblicata.Esposizione a sistemi di intelligenza artificiale: pubblicare foto dei figli su piattaforme pubbliche espone i dati biometrici e le immagini dei minori a un uso improprio da parte di sistemi di riconoscimento facciale sempre più sofisticati. Ciò potrebbe tradursi in contenziosi legali futuri, con richieste risarcitorie da parte dei figli verso i genitori.Violazioni della privacy e sicurezza digitale: le immagini condivise contengono spesso informazioni aggiuntive, come i dati di geolocalizzazione, e la condivisione pubblica può esporre i minori a rischi di pedopornografia.Diffusione involontaria: anche contenuti condivisi in chat private possono uscire dal contesto riservato, compromettendo la riservatezza del minore.Secondo uno studio europeo, ogni anno i genitori condividono online in media 300 foto dei propri figli, e prima del quinto compleanno ne hanno già condivise quasi 1.000. Le piattaforme più utilizzate sono Facebook (54%), Instagram (16%) e Twitter (12%). Foto del primo giorno di scuola, mentre mangiano, dormono o svolgono attività domestiche diventano facilmente parte di un “dossier digitale” costruito senza il consenso del bambino.Analisi condotte in Svizzera evidenziano che i pedofili reperiscono materiale non solo sui social network, ma anche tramite scambi con altri criminali o producendo autonomamente le immagini. Le piattaforme social diventano così terreno fertile, poiché molti genitori condividono inconsapevolmente le foto dei propri figli, facilitando l’accesso a utenti malintenzionati.Il Garante ha elaborato una serie di raccomandazioni volte a limitare i rischi legati allo sharenting: rendere irriconoscibile il volto del minore mediante strumenti grafici o emoticon;limitare le impostazioni di visibilità dei contenuti sui social network;evitare la creazione di account social dedicati ai minori;leggere e comprendere le informative sulla privacy delle piattaforme utilizzate;prestare attenzione anche ai contenuti condivisi tramite chat private, che possono facilmente uscire dal contesto riservato.In Italia, lo sharenting è regolato dal Garante per la protezione dei dati personali, che con la campagna “La sua privacy vale più di un like” ha sottolineato come ogni immagine contribuisca a definire l’identità digitale del minore. Il provvedimento del 13 novembre 2024 ha stabilito che per pubblicare foto di minori di 14 anni è necessario il consenso di entrambi i genitori; superata questa soglia, il minore può esprimere autonomamente la propria volontà. La violazione di tali disposizioni può comportare sanzioni civili, come la rimozione dei contenuti e il risarcimento dei danni, o penali, quali la reclusione fino a quattro anni per trattamento illecito di dati, diffamazione o interferenze nella vita privata.Gli esperti indicano alcune pratiche preventive per i genitori:evitare la condivisione pubblica di immagini o video dei figli;preferire la condivisione tramite messaggistica privata sicura, limitata a familiari o amici stretti;chiedere sempre il consenso del figlio (dai 14 anni in su) e dell’altro genitore;essere selettivi nella pubblicazione, evitando contenuti che possano compromettere la privacy, come foto in costume o in momenti intimi;monitorare le impostazioni di privacy dei social network e limitare la visibilità dei post;chiedere a familiari e amici di non condividere immagini dei minori senza permesso;attivare notifiche che informino della comparsa del nome del minore nei motori di ricerca. L’uso consapevole degli strumenti digitali in ambito familiare è fondamentale per garantire la tutela dell’interesse superiore del minore anche nella sua dimensione digitale. La responsabilità genitoriale si estende oggi alla gestione dell’identità online dei figli, richiedendo attenzione ai rischi, rispetto delle normative vigenti e adozione di pratiche prudenziali per salvaguardare la reputazione, la sicurezza e la privacy dei minori.
Continua a leggere
Scritto da:
La riforma Cartabia nel diritto di famiglia
24 mag. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
La riforma Cartabia ha introdotto numerose interessanti novità nel processo di famiglia ma, ciononostante, presenta anche delle criticità che sicuramente vedremo nel tempo. In ogni caso, i punti salienti riformati sono i seguenti:PROCEDIMENTO: domande di separazione giudiziale e divorzio contenzioso in unico attoatti introduttivi completi con l'allegazione di tutti i fatti e i mezzi di provaabrogata la struttura bifasica del procedimento ( davanti al Presidente prima e al Giudice istruttore poi)competenza territoriale del tribunale di residenza del minore ( o quella del convenuto in mancanza di figli minori)udienza di comparizione entro novanta giorni dal deposito del ricorso FIGLI: obbligo ascolto dei figlionere di completa descrizione delle attività quotidiane dei figliprovvedimenti provvisori sul mantenimento e sull'affidamento dei figli fin dalla prima udienzasanzioni al genitore che non rispetta tempi e modalità del piano genitoriale precedentemente accettato RAPPORTI PATRIMONIALI: le richieste relative ai rapporti patrimoniali fra i coniugi dovranno essere depositate nell'atto introduttivo. Per quanto riguarda il diritto di famiglia, ictu oculi possiamo affermare che vi sono spunti interessanti, che tentano di risolvere situazioni ad oggi problematiche. In ogni caso, e senza voler entrare ulteriormente nel merito, questi miglioramenti saranno valutabili solo col tempo, allorquando la riforma entrerà pienamente in vigore.In ogni caso, una riforma senza un incremento dell'organico dei Magistrati è destinata a non produrre gli effetti desiderati. Tali magistrati da inserire in organico dovrebbero, inoltre, essere altamente specializzati - ancor di più in una materia come la nostra - e insensibili agli stereotipi e alle "influenze esterne". Sicuramente è un obiettivo alla nostra portata, ma la domanda è un'altra: esiste la volontà di rendere il sistema giudiziario in materia di famiglia efficiente e veloce? Ai posteri l'ardua sentenza ....
Continua a leggere
Scritto da:
Il regolamento condominiale
20 gen. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
L’articolo 1138 del codice civile disciplina il regolamento condominiale, pur non fornendo una definizione univoca dello stesso.Pertanto, cosa s’intende per regolamento condominiale? In quali casi è obbligatorio? Quali sono i tipi di regolamento condominiale?1. Cos’è il regolamento condominiale? In quali casi è obbligatorio?2. Approvazione e modifica del regolamento condominiale3. Le diverse tipologie di regolamento condominiale1 - Cos’è il regolamento condominiale? In quali casi è obbligatorio?Come accennato in premessa, il legislatore non ha inteso fornire una definizione univoca del regolamento condominiale. Tuttavia, è possibile affermare che il regolamento condominiale sia lo strumento mediante il quale si disciplina l’uso della cosa comune, la ripartizione delle spese ed ogni altro aspetto relativo alla gestione e all’amministrazione di un condominio.Quando è obbligatorio dotarsi di un regolamento condominiale?Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare l’articolo 1138 del codice civile, il cui primo comma sancisce che quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.2 - Approvazione e modifica del regolamento condominialeAppurato che il regolamento condominiale è obbligatorio nell’ipotesi in cui un edificio sia formato da più di dieci condomini, va compreso come lo stesso venga approvato.Sempre l’articolo 1138 del codice civile stabilisce che l’iniziativa per la formazione del regolamento – o per la revisione di quello già adottato – può essere presa da ciascun condomino. Per essere approvato, ovviamente, occorre ottenere la maggioranza richiesta dalla legge. In questo caso, la norma di riferimento è l’articolo 1136 del codice civile, in base al quale sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.Come si esaminerà a breve, i regolamenti condominiali si distinguono in assembleare e contrattuale. La differenza assume rilevanza anche per quel che riguarda la modifica del regolamento. Difatti, nel caso di regolamento assembleare la legge dispone che ogni condomino possa assumere l’iniziativa per la modifica del regolamento e l’assemblea provvederà con le stesse maggioranze previste per l’approvazione.In caso di regolamento contrattuale, invece, va detto che la Corte di cassazione con sentenza n. 17694/2007 ha stabilito che il regolamento ha natura contrattuale ed è modificabile solamente all’unanimità dei condomini in due ipotesi: 1. quando le disposizioni del regolamento limitano i diritti dei condomini; 2. quando contiene clausole in forza delle quali alcuni condomini hanno maggiori diritti rispetto ad altri.3 - Le diverse tipologie di regolamento condominiale Con riferimento alla natura, il regolamento condominiale è distinguibile in: regolamento ordinario o assembleare, regolamento contrattuale o negoziale, regolamento giudiziale.Il regolamento si definisce di natura assembleare quando, per l’appunto, è approvato dall’assemblea dei condomini. L’articolo 71 delle disposizioni attuative del codice civile prevede che il regolamento assembleare sia trascritto in un apposito registro tenuto presso l’associazione professionale dei proprietari di fabbricati, sebbene tale norma non sia mai stata applicata.Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, i regolamenti ordinari non possono importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà.Diversamente può, invece, disporre il regolamento contrattuale. Esso è definito tale perché è accettato da tutti i condomini ed ha valenza contrattuale. Solitamente è lo stesso proprietario originario a predisporre il regolamento che va, di volta in volta, allegato ai singoli atti di acquisto. Con questo tipo di regolamento è possibile limitare l’uso delle parti comuni, limitare i diritti dei singoli condomini sulle rispettive proprietà o ampliare i poteri di uno o più condomini rispetto agli altri.La terza tipologia, infine, è quella dei regolamenti giudiziali, i quali si hanno qualora non si riesca a formare un regolamento in sede assembleare ed è necessario ricorrere all’autorità giudiziaria affinché sia la stessa a provvedere.
Continua a leggere
Scritto da:
Commenti
Non ci sono commenti




