Dichiarazione di successione: chi, cosa, dove, quando e perché!

Egregio Avvocato
Pubblicato il 21 gen. 2021 · tempo di lettura 4 minuti
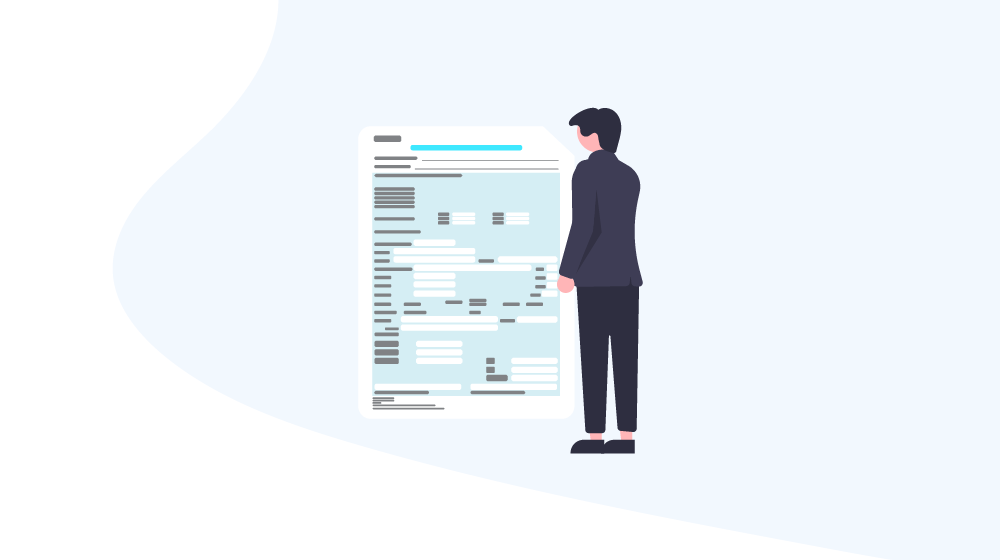
Alla morte di una persona i suoi beni passano agli eredi, testamentari o legittimi. Il trasferimento di ricchezza a causa di morte è tassato dallo Stato ed è per questo che i chiamati all'eredità, o coloro che nel frattempo l’amministrano, devono presentare la Dichiarazione di Successione presso l’Agenzia dell’Entrate. Ma cos’è la dichiarazione e chi, di preciso, la deve presentare?
- Cos’è la Dichiarazione di successione
- Chi deve presentarla ed entro quanto tempo
- Dove e come presentarla
- Perché è importante
1 - Cos’è la Dichiarazione di Successione
Quasi tutti i trasferimenti di ricchezza sono sottoposti al pagamento di un’imposta a favore dello Stato, tra questi rientrano i trasferimenti che si generano in forza di una successione a causa di morte: cioè i beni che alla morte del defunto passano a favore dei suoi eredi, legittimi o testamentari.
Infatti, il D.P.R. n. 637/1972, che regola l’imposta sulle successioni e donazioni, all’art. 1 stabilisce che l'imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte. Ciò giustifica la ragione per cui, alla morte di un soggetto, deve essere presentata presso l’Agenzia delle Entrate la cd. Dichiarazione di Successione.
La dichiarazione contiene la descrizione analitica di tutti i beni e diritti che si trovano nell’asse ereditario ed il relativo valore, proprio al fine di permettere all’Agenzia l’individuazione della base imponibile e la determinazione dell’eventuale imposta da liquidare.
L’imposta di successione non è sempre dovuta! In caso di eredità a favore del coniuge o di parenti in linea retta si paga soltanto se l’asse ereditario supera la franchigia di 1 milione di euro e per un’aliquota del 4% (per le altre franchigie e aliquote guarda qui).
2 - Chi deve presentarla ed entro quanto tempo
Entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che ai sensi dell’art. 456 codice civile coincide con il momento della morte, sono obbligati a presentare la dichiarazione:
- i chiamati all’eredità (cioè coloro che per legge o per testamento ricevono l’eredità, ancorché non l’abbiano ancora accettata);
- i legatari;
- i rappresentanti legali, quando i chiamati e legatari sono soggetti incapaci (es. in caso di minore sono i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale);
- coloro che siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
- gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacente;
- gli esecutori testamentari.
Se vi sono più persone obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che ne venga presentata una sola: ad esempio, se alla morte sono chiamati all’eredità più figli, basta che uno solo di questi presenti la dichiarazione.
Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione il coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (cioè i figli, discendenti o genitori) ai quali sia stata devoluta un’eredità con valore dell’attivo non superiore a 100.000 euro e nell’asse ereditario non ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari.
In caso di dichiarazione tardiva si può sempre procedere ad un ravvedimento operoso: ossia si produrrà la dichiarazione e si pagheranno gli interessi di mora. Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate ha già operato l’accertamento d’ufficio il ravvedimento operoso non sarà più possibile e si dovranno pagare le sanzioni amministrative in aggiunta a quanto dovuto e agli interessi di mora.
3 - Dove e come presentarla
Dal 2018 la dichiarazione può essere presentata solo online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal contribuente o da un professionista incaricato.
L’Agenzia delle Entrate fornisce sul proprio sito il Modello di Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, accompagnato da due fascicoli che forniscono le istruzioni per l’inserimento corretto di tutti i dati.
Ad esempio, nella dichiarazione dovranno essere indicati, oltre ai dati degli eredi e del defunto:
- i beni immobili e i diritti reali su beni immobili;
- le rendite, le pensioni e i crediti;
- le aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
- le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili che non fanno parte di aziende;
- le passività deducibili.
Se nel compendio ereditario ci sono beni immobili (terreni o fabbricati) occorre versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione anche le imposte ipotecaria e catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali.
Attenzione! chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione IMU: sono gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate che trasmettono la copia della dichiarazione al Comune.
4 - Perché è importante
Oltre a comunicare il trasferimento dei beni agli eredi a fini fiscali, la dichiarazione di successione è importante perché nessun bene ricevuto in eredità può essere venduto se non sono state pagate le relative imposte. Inoltre, la prova della presentazione della dichiarazione viene richiesta sempre dalle banche prima di poter mettere a disposizione degli eredi il conto corrente del defunto.
È importante precisare che la dichiarazione di successione è ben diversa dall’accettazione dell’eredità. Abbiamo visto, infatti, che la dichiarazione ha una mera valenza fiscale, volta a individuare la consistenza dell’asse ereditario e verificare se è dovuta l’imposta di successione e il suo quantum: pertanto, la dichiarazione non sostituisce l’accettazione dell’eredità, cioè l’atto con cui gli eredi accettano di subentrare in ogni rapporto giuridico attivo e passivo del de cuius.
Condividi:
Dichiarazione di successione: chi, cosa, dove, quando e perché!
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Crisi della relazione coniugale e rapporto con i figli
28 ago. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Un tema da sempre dibattuto e controverso riguarda il diritto/dovere in capo ai genitori di garantire ai figli un buon rapporto con l'ex coniuge, facendo in modo che gli stessi mantengano un'immagine positiva dell'altro genitore.Spesso, purtroppo, ciò non succede. Quid iuris se si verifica una tale situazione? Esemplare è, al riguardo, la decisione del Tribunale di Roma (Tribunale di Roma n. 18799/2016), con la quale una madre è stata condannata a risarcire all’ex marito la somma considerevole di € 30.000,00 per non avere garantito il recupero del rapporto di questi con il figlio, avendo la stessa screditato continuamente il padre agli occhi del minore. Ed invero, come precedentemente sottolineato, ogni genitore, dopo la separazione o il divorzio, deve consentire che i figli mantengano con l’altro un buon rapporto e ne conservino una immagine positiva, per garantirne la crescita equilibrata. In caso contrario, chi non ottempera può essere condannato al risarcimento dei danni ex art. 709-ter c.p.c. in favore dell’altro genitore alienato. Tale somma, da decidersi sempre nel caso concreto, tenendo conto della gravità dei fatti e delle capacità economiche delle parti in causa, ha soprattutto una funzione di monito e di deterrente al tempo stesso, in quanto l’obiettivo del giudice è, nel caso di specie, quello di garantire "la cessazione del protrarsi dell’inadempimento degli obblighi familiari, poiché gli stessi per la loro natura personale sono di per sé incoercibili e non sono suscettibili di esecuzione diretta".Nel caso concreto sottoposto all’esame del Tribunale di Roma, la madre avrebbe dovuto agire in maniera tale da consentire al figlio di recuperare il ruolo del padre, al fine di garantire la tutela della bigenitorialità, mentre la donna non aveva fatto altro che ostacolare agli incontri programmati tra padre e figlio ed impedire il funzionamento dell’affido condiviso con comportamenti di discredito della figura paterna.La decisione dei Giudici Romani appare pienamente condivisibile, soprattutto in relazione alla funzione di monito e di deterrente assegnata alla condanna in questione.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
Continua a leggere
Scritto da:
Innovazione e modificazioni nella disciplina condominiale
3 mag. 2023 • tempo di lettura 6 minuti
TRACCIA ESAME FORENSE ORALE I Tizio, proprietario di un appartamento sito al terzo piano di uno stabile condominiale, realizza una canna fumaria ed una tubazione per il ricircolo dell’aria in appoggio al muro comune perimetrale di proprietà condominiale. L’amministratore Caio invito il condomino alla rimozione dell’opera realizzata a sue esclusive spese, ma Tizio rifiuta di adempiervi. Il condominio, allora, in persona dell’’amministratore, previa delibera adottata all’unanimità, cita in giudizio il condomino Tizio per ottenere la condanna alla rimozione dell’opera illegittima, oltre al risarcimento dei danni. Tizio si rivolge ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga parere motivato, indicando altresì l’atto più opportuno per tutelare il proprio assistito. SVOLGIMENTO La traccia sottoposta all’attenzione dello scrivente impone preliminarmente di esaminare la quaestio iuris ad essa sottesa, compendiabile nella problematica circa l’esatta configurazione delle innovazioni, all’interno della disciplina del condominio degli edifici, rispetto al regime ordinario sull’uso della cosa comune di cui al’art. 1102 c.c. E’ opportuno in ogni caso esaminare gli istituti generali intercettati dal caso in esame, in particolare con riferimento alla comunione ordinaria ed al condominio degli edifici, inteso quale species di comunione. La comunione ordinaria, di cui agli artt. 1100 e ss. c.c., individua la condizione di contitolarità del diritto di proprietà in capo a plurimi soggetti su una medesima cosa, mobile od immobile, la cui caratteristica consiste nel conferimento della titolarità del diritto reale sul bene pro quota tra tutti i comunisti. Tale considerazione è utile a segnare il dato discretivo rispetto ad altre fattispecie di comunione riscontrabili dalla disciplina civilistica, quale la c.d. comunione legale dei beni, intesa come regime patrimoniale legale della famiglia legittima di cui all’art. 177 c.c., che infatti si caratterizza come comunione di stampo germanico sine quota e dunque pro indiviso, per la quale appunto ciascun coniuge è proprietario per intero dei beni facenti parte della comunione diretta, beni che entrano a far parte della comunione legale anche qualora il loro acquisto venga perfezionato da ciascun coniuge separatamente, con effetto derogatorio rispetto al principio di relatività degli effetti contrattuali ex art. 1372 c.c. All’interno della disciplina ordinaria in tema di comunione, il principio fondante si rinviene nel c.d. uso promiscuo che ciascun comunista può parimenti esercitare sulla medesima res, nonostante qualsiasi atto di disposizione della cosa venga limitata o circoscritta all’interno della quota ideale di titolarità di ciascun partecipante alla comunione medesima. Sotto questo profilo, è utile rammentare, all’interno della comunione ereditaria, quale species del più ampio genus di comunione, la prelazione legale in capo a ciascun coerede rispetto ad una quota di titolarità del singolo partecipante che intenda alienare la quota di sua spettanza. Il diritto di prelazione infatti non può essere leso per qualsivoglia ragione, tanto che l’ordinamento appresta un apposito rimedio coattivo, denominato retratto successorio, che consente ai coeredi lesi nel diritto di prelazione loro spettante rispetto alla quota di un coerede alienata a terzi, di subentrare nell’acquisto, riscattando la quota oggetto di trasferimento. Calandoci nel caso di specie, il condominio degli edifici individua una forma speciale di comunione caratterizzata dalla compresenza di parti comuni ed unità di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Le prime sono individuate dall’art. 1117 c.c. con un’elencazione che la maggior parte degli interpreti considera non tassativa, secondo un criterio generale rinvenibile nel nesso di strumentalità della parte comune rispetto al miglior godimento ed uso delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva. Seguendo il criterio anzidetto, si individuano quali parti comuni il portone d’ingresso, le scale, gli ascensori, il lastrico solare, le aree parcheggio e via discorrendo. Seguendo l’orientamento maggioritario invalso nella giurisprudenza di legittimità, il condominio è da intendersi quale ente di gestione, sfornito di una personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei singoli condomini che lo compongono e che agisce per il tramite dell’organo rappresentativo comune individuato nella persona dell’amministratore pro-tempore. Questi infatti è l’organo esecutivo, deputato a dare esecuzione alle delibere adottate dall’assemblea, cui hanno di diritto di partecipare tutti i condomini, cui è altresì conferito diritto di impugnazione delle delibere medesime entro trenta giorni dalla loro adozione, per i condomini dissenzienti o astenuti, ovvero dalla loro comunicazione per i condomini assenti. In tema di impugnativa, l’art. 1137 c.c., oltre a tracciare il principio maggioritario e l’obbligatorietà della delibera rispetto a tutti i condomini, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, fa riferimento al ricorso, quale strumento di annullamento della delibera stessa, in senso atecnico, dunque da intendere come atto di citazione, con tutte le conseguenze che ne derivano per il calcolo della pendenza della lite. Secondo l’art. 1120 c.c. sono soggette ad approvazione assembleare le innovazioni dirette miglioramento o all’uso più comodo della cosa comune ovvero al suo miglior rendimento. Se si considera l’opera costruita dal Sig. Tizio nei termini anzidetti, dovrebbe essere assoggetta alla disciplina sulle innovazioni di matrice condominiale. Ciononostante, assumendo come punto di riferimento l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può far uso della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di farne parimenti uso, è possibile giungere a conclusioni completamente diverse, specie se si considera la giurisprudenza granitica sul punto. Infatti, la Corte di Cassazione nel delineare la differenza tra innovazione e mera modificazione ha specificato (Cass. 35957/2021) che per innovazioni bisogna intendere non qualsiasi mutamento della cosa comune ma solo quella modifica materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria. Da queste premesse, dunque, si può pervenire alla conclusione che, in tema di condominio degli edifici, le innovazioni di cui è menzione all’art. 1120 c.c. si distinguono dalle mere modificazioni, disciplinate dall’art. 1102 c.c. sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista soggettivo, poiché le prime consistono in opere di trasformazione che incidono sull’essenza della res commune, alterandone la originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, sia pure entro i limiti scolpiti dall0art. 1102 c.c., per ottenere la migliore e più comoda, nonché razionale, utilizzazione della cosa comune. Ad abundantiam, sotto il profilo soggettivo, le innovazioni sottendono ad un interesse di portata collettiva espresso da una maggioranza qualificata, formatasi in sede assembleare, elemento che manca nelle mere modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale ma con quello dei singoli condomini. Da quanto detto, seguendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per un caso analogo a quello oggetto di cognizione, l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale del condominio sostanzia una modifica della res commune conforme alla sua destinazione e che ciascun condomino, pertanto, può apportare a sue cure e spese, a condizione che ciò non impedisca l’uso paritario conferito a tutti i condomini, secondo i principi generali desumibili dall’art. 1102 c.c. e purchè non rechi altresì pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, ovvero non ne alteri il decoro architettonico, ipotesi questa che, secondo la Cass. 30462/20158, sarebbe rinvenibile qualora l’opera de qua si rifletta negativamente sull’insieme dell’aspetto armonico dello stabile condominiale e non quando si mutino le originali linee architettoniche. Alla luce di quanto detto, sarà possibile nell’interesse del Sig. Tizio redigere una comparsa di costituzione e risposta ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. allo scopo di costituirsi nel giudizio promosso dal condominio in persona dell’amministratore pro-tempore Caio, impugnando e contestando le avverse deduzioni poiché l’opera di fatto realizzata dal condomino convenuto non rientra nella disciplina delle innovazioni, assoggettabile appunto al regime di cui all’art. 1120 c.c., bensì integra gli estremi di una mera modificazione, consentita ai singoli condomini sia pure nel rispetto dei canoni generali sull’uso delle cose comune ex art. 1102 c.c. Si insisterà per il rigetto della domanda, rilevando in ogni caso, in via preliminare, che, trattandosi di controversia in materia condominiale, è subordinata al previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1bis del d.lgs. 28/2010.
Continua a leggere
Scritto da:
La negoziazione assistita: il procedimento stragiudiziale per la risoluzione della crisi coniugale
25 nov. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Con il DL 132/2014 conv. in L. 162/2014 è stato introdotto lo strumento della convenzione assistita davanti gli avvocati come strumento facoltativo per la risoluzione della crisi coniugale senza la necessità di ricorrere al giudice.I coniugi con tale strumento possono separarsi consensualmente o chiedere un divorzio congiunto, possono anche modificare le condizioni di separazione o divorzio anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o non autosufficienti economicamente.Lo scopo della negoziazione assistita è quello di ridurre il contenzioso giudiziario sottraendo una parte dei procedimenti relativi alla crisi della famiglia e da ultimo, tale procedura si applica anche allo scioglimento dell’unione civile.Come e quando si può chiedere la negoziazione assistita?Invio alla procedura di negoziazione: adesione o rifiuto all’invitoSvolgimento della negoziazione: mancato accordo o accordo tra le parti Trasmissione dell’accordo al P.M e all’Ufficiale di Stato di civile ed effetti dell’accordo1 – Come e quando si può chiedere la negoziazione assistita?I coniugi (o ex coniugi) con la negoziazione assistita possono raggiungere una soluzione consensuale nelle seguenti materie: a) separazione personale consensuale; b)divorzio congiunto; c) modifica delle condizioni di separazione o divorzio; d) scioglimento dell’unione civile; e) modifica delle condizioni dello scioglimento dell’unione civile. La procedura può essere svolta in qualunque momento e non è condizione di procedibilità della domanda per la risoluzione della crisi familiare dinanzi al giudice. Ciascuno dei coniugi deve farsi assistere almeno da un avvocato durante tutta la procedura ed il requisito della presenza di due avvocati (uno per parte) non è soddisfatto se i due avvocati fanno parte dello stesso studio.Gli avvocati durate la procedura devono svolgere le seguenti attività: a) tentare una conciliazione dei coniugi, tale incombenza nelle procedure giudiziali è affidata al Presidente del tribunale; b) informare le parti dell’importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore. L’avvocato ha diritto al compenso per la prestazione resa durante la procedura, anche in assenza di accordi, sulla base dei parametri forensi, il compenso è dovuto anche se l’assistito possiede i requisiti di accesso al gratuito patrocinio.2 – Invio alla procedura di negoziazione: adesione o rifiuto all’invitoUno dei due coniugi, tramite il proprio avvocato, invita l’altro a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ossia un accordo con cui le parti, entro un lasso temporale predeterminato, vanno a ricercare una soluzione concordata relativa alla loro separazione, divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.L’avvocato deve comunicare l’invito mediante raccomandata a/r anche se la legge non detta modalità precise pertanto, pertanto, l’invito può avvenire anche tramite manifestazioni reciproche di disponibilità verbali.L’invito, sottoscritto dal coniuge, deve contenere: a) la descrizione dell’oggetto della controversia; b) l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice per decidere sulle spese di giustizia.Entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito, l’altro coniuge può: aderire, rifiutare o non rispondere, dove la mancata risposta equivale a rifiuto.Nel momento in cui l’altro coniuge aderisce all’invito, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, le parti con la convenzione assistita si obbligano a cooperare in buona fede per raggiungere un accordo sulla separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni. 3 - Svolgimento della negoziazione: mancato accordo o accordo tra le parti La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve contenere: a) l’oggetto della controversia; b) il termine per svolgere la procedura non inferiore ad un mese e non superiore a 3 mesi, salvo proroga concordata tra le parti di ulteriori trenta giorni.A questo punto gli avvocati iniziano la negoziazione per il periodo di tempo massimo indicato nella convenzione e devono cooperare secondo criteri di lealtà e buona fede.Tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la negoziazione non possono essere utilizzare nel successivo giudizio che abbia, anche in parte, lo stesso oggetto. Se i coniugi non raggiungono un accordo, gli avvocati vanno a redigere e certificare una dichiarazione di mancato accordo e la parte interessata, se lo ritiene, può agire in giudizio.Se, invece, viene raggiunto l’accordo gli avvocati vanno a redigere un apposito verbale con il seguente contenuto: a) danno atto di aver tentato la conciliazione; b) danno atto di aver informato i coniugi con figli minorenni dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori; c) i coniugi manifestano il loro consenso a separarsi o divorziare; d) nel momento in cui ci sono figli minori o incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, i coniugi devono definire devo disciplinare e definire i relativi rapporti personali e patrimoniali al fine di consentire al P.M. un adeguato controllo di tali disposizioni; e) può prevedere un assegno di mantenimento o di divorzio a favore del coniuge economicamente più debole oltre a quello per i figli.L’accordo dev’essere datato e deve contenere la sottoscrizione delle parti e degli avvocati che vanno a certificare sia la data che la firma dei rispetti assistiti oltre che la conformità del contenuto dell’accordo all’ordine pubblico e norme imperative.4 - Trasmissione dell’accordo al P.M e all’Ufficiale di Stato di civile Gli avvocati devono trasmettere l’accordo di negoziazione assistita e la documentazione richiesta al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.In assenza di criteri di competenza dettati dalla legge, si applicano nella pratica le regole generali in materia di competenza territoriale dettate in materia di separazione e divorzio.Quanto alle modalità di trasmissione dell’accordo è consentito il deposito cartaceo a mani o con raccomandata a/r ma è possibile anche l’invio tramite casella Pec.La trasmissione dell’accordo deve avvenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione soprattutto se i coniugi hanno figli minori o maggiorenni da tutelare.Il P.M. effettua le opportune verifiche ed emette: a) un nullaosta nel momento in cui i coniugi non hanno figli minori o se i figli non hanno bisogno di tutela; b) un’autorizzazione quando i coniugi hanno figli minori o figli bisogni di tutela da parte del P.M. Ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione del P.M. almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l’atto devono trasmettere una copia autentica dell’accordo all’Ufficiale di Stato civile del comune devo il matrimonio è stato iscritto o trascritto, entro il termine di 10 giorni.L’Ufficiale di Stato civile esegue le seguenti operazioni: a) trascrive l’accordo nei registri degli atti di matrimonio o negli archivi informatici; b) annota l’accordi nell’atto di matrimonio; c) annota l’accordo sull’atto di nascita di ciascun coniuge.Editor: Avv. Elisa Calviello
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
L’amministrazione di sostegno
29 mar. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
L’ordinamento giuridico italiano ha vissuto una profonda evoluzione del proprio sistema in merito alla “incapacità delle persone” mediante l’introduzione di un nuovo istituto, quale l’amministrazione di sostegno. Il legislatore ha cercato di superare l’eccessiva rigidità che connotava il sistema previgente, volendo permettere una maggiore libertà e flessibilità nella disciplina del singolo soggetto incapace. Vediamo, quindi, i principali caratteri di questo nuovo istituto e in che modo si rapporta con gli istituti previgenti.L’origine della legge n. 6 del 2004I presupposti dell’amministrazione di sostegnoChi è l’amministratore di sostegnoI rapporti con interdizione e inabilitazione1 - L’origine della legge n. 6 del 2004L’intervento legislativo in esame assume una rilevanza fondamentale per il sistema delle “incapacità delle persone” previsto nell’ordinamento giuridico italiano, avendo introdotto l’istituto della amministrazione di sostegno nel codice civile, e in particolare nel Capo I del Titolo XII, intitolato “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”.L’esigenza di dare un nuovo assetto al sistema nasce dopo il superamento dei manicomi (mediante la legge Basaglia n. 180 del 1978), quando si è posto il grande problema della riorganizzazione della vita dei “manicomializzati” al di fuori delle mura degli istituti. Il sistema previgente, infatti, prevedeva solo la inabilitazione e la incapacità di agire, che non consentivano una flessibilità della disciplina: il soggetto o era totalmente capace di agire e autodeterminarsi, o non lo era affatto; non si consentiva una via di mezzo. Non vi era un sistema di incapacità che guardava al singolo incapace, venivano tutti considerati uguali tra loro. Rispetto a questa realtà gli ex manicomializzati si trovavano spesso in una sorta di zona grigia, tra chi stava bene e chi stava male, e la disciplina del codice del ’42 risultava del tutto inadeguata, per questo, si è sentita la necessità di prevedere una misura ad hoc. Già dall’art. 1 della legge in esame è esplicitata la finalità cui il legislatore aspira: “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. Quindi, la logica è quella della minima privazione (l’intento è quello di promuovere la persona). L’art. 409 co. 1 c.c. prevede espressamente che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Ciò che l’incapace non può fare deve essere espressamente previsto dal decreto di nomina disposto dal giudice tutelare. L’istituto è di ausilio alla persona, e non ai familiari.2 - I presupposti dell’amministrazione di sostegnoIl protagonista di questa disciplina è il beneficiario: l’amministrazione di sostegno, infatti, può essere aperta anche su ricorso dello stesso beneficiario, che deve essere sentito dal giudice tutelare. Così, il beneficiario non viene escluso dal traffico giuridico, ma anzi viene promossa la sua attività. Il giudice gradua il decreto proprio tenendo conto delle peculiari necessità dell’interessato.Il primo presupposto richiesto è che vi sia una “infermità ovvero una menomazione fisica o psichica”. È un’indicazione molto ampia, e fa riferimento a qualsiasi menomazione che possa pregiudicare la possibilità di compiere atti giuridici (si va dai disabili agli alcolisti).Il secondo presupposto, invece, è quello della “impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. Occorre verificare anche se il potenziale beneficiario abbia un corredo familiare e sociale di riferimento che gli consenta comunque di provvedere ai propri interessi. Il giudice non deve considerare solo la persona isolatamente considerata in astratto, ma deve verificare se anche all’interno della formazione sociale e della comunità di riferimento, è in grado di farlo (es. se il soggetto è inserito all’interno di una comunità che lo aiuti). Quindi, ruolo fondamentale è svolto dal giudice tutelare, il quale deve redigere il decreto di nomina nel quale indica cosa l’incapace non può fare autonomamente, e può anche intervenire autonomamente per modificarlo e integrarlo. Si vuole cercare di non aggravare la giustizia in tutti quei casi in cui il soggetto, anche se menomato, è comunque in grado di soddisfare i propri interessi grazie al corredo familiare o sociale di riferimento.3 - Chi è l’amministratore di sostegno? Il legislatore prevede che il beneficiario stesso possa designare l’amministratore per il caso di una futura incapacità, e di regola il giudice si attiene a questa assegnazione (salvi gravi motivi); altrimenti il giudice farà riferimento ai soggetti della cerchia familiare del soggetto. L’art. 408 c.c. prevede un ordine di scelta, anche se il giudice può scegliere sulla base di un diverso ordine tra soggetti diversi – per esempio può indicare anche il convivente stabile del beneficiario.Di regola l’incarico è gratuito, ma il giudice può prevedere una indennità a favore dell’amministratore di sostegno. Quest’ultimo risponde nei confronti del beneficiario per i danni causati nel corso dell’amministrazione, ma non è indicato a che titolo. Per la tesi preferibile si tratterebbe di inadempimento di obbligazione ex lege (quindi si tratta di una responsabilità ex art. 1218 c.c.); per altre tesi invece si tratterebbe di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.)Il beneficiario risponde sicuramente senza alcuna deroga nei confronti dei terzi: si tratterà di responsabilità extracontrattuale ex artt. 2047 e 2048 c.c. nel caso in cui l’amministratore abbia un dovere di sorveglianza del soggetto incapace che cagioni un danno ai terzi.L’art. 405 c.c. prevede due tipi di modelli di amministrazione di sostegnoil modello di rappresentanza esclusiva, ove l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti indicati dal giudice tutelare nel decreto di nomina;il modello di rappresentanza assistenziale, ove il beneficiario può compiere quei determinati atti solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.4 - I rapporti con interdizione e inabilitazioneStrutturalmente, sono istituti diversi: la interdizione e la inabilitazione sono di regola più rigide, anche se dopo la riforma tale rigidità si è attenuata (art. 427 co.1 c.c.), mentre l’amministrazione di sostegno trova la sua peculiarità proprio nella flessibilità. Dalla riforma posta in essere mediante la legge n. 6 del 2004 vi è una predilezione per l’amministrazione di sostegno: consente di plasmare le misure della incapacità sulle esigenze dello specifico beneficiario.È lo stesso legislatore a preferire l’amministrazione di sostegno; e ciò si desume dal fatto che il legislatore la prevede al Capo I del Titolo dedicato a tali istituti. A tal proposito, è stata criticata quella giurisprudenza che, pur potendo in astratto optare per l’amministrazione di sostegno, abbia in concreto disposto un’altra misura. In conclusione, bisogna preferire sempre l’istituto dell’amministrazione di sostegno ove possibile, a meno che l’incapacità del singolo sia talmente grave che tale scelta darebbe luogo a vuoti di tutela, e quindi sarebbe pregiudizievole per l’incapace stesso. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti




