Il testimone nel processo penale: obblighi e responsabilità

Egregio Avvocato
Pubblicato il 28 gen. 2021 · tempo di lettura 7 minuti
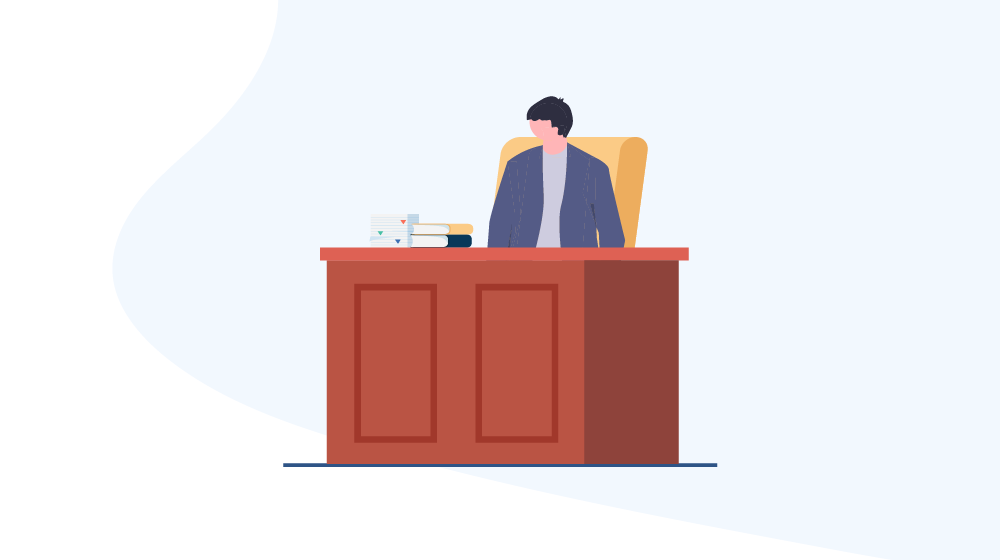
Nel processo penale italiano grande rilevanza probatoria viene data alle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del dibattimento, in quanto reale espressione del principio del contraddittorio, dell’oralità e dell’immediatezza. Ma quali sono gli obblighi cui è soggetto il cittadino chiamato a testimoniare? Quali sono le responsabilità e le conseguenze cui può andare incontro? Sono previste delle ipotesi di non punibilità?
- Chi è il testimone?
- Quali sono gli obblighi del testimone?
- Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi?
- In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?
1 - Chi è il testimone?
Il testimone è un soggetto avente un ruolo fondamentale nel processo penale italiano, ed in particolare nella fase del dibattimento. Il principio cardine del processo penale, infatti, è il principio del contraddittorio, con i corollari principi dell’oralità e dell’immediatezza, alla luce dei quali il giudice penale deve formare il proprio convincimento (di assoluzione o di condanna) mediante delle prove che si formino nel processo stesso, e non mediante delle prove cd. precostituite.
La testimonianza, e quindi il ruolo del testimone, rispecchia pienamente questa esigenza di oralità ed immediatezza, in quanto le dichiarazioni vengono rese non solo davanti al giudice che sarà poi chiamato a decidere, ma dinanzi alle parti processuali, cioè il PM, l’imputato e il difensore di quest’ultimo, i quali potranno rivolgere delle domande al dichiarante. L’esame del testimone, invero, avviene nel contesto del cd. “esame incrociato”, ove le domande verranno poste prima dalla parte che ha chiesto la presenza di quel soggetto come testimone (esame), poi dall’altra parte (controesame), a fronte del quale la prima parte potrà nuovamente porre altre domande (riesame), ed infine eventualmente anche dal giudice.
Il testimone, dunque, è un soggetto informato dei fatti, che viene chiamato nel corso del dibattimento per rendere delle dichiarazioni inerenti al fatto di reato, oggetto del processo.
2 - Quali sono gli obblighi del testimone?
Il cittadino chiamato a testimoniare in un processo penale riceve un atto denominato “citazione testi”, di regola notificato con raccomandata se citato dai difensori dell’imputato o mediante ufficiale giudiziario se citato dal PM. In tale atto vengono indicati l’ora, il giorno e il luogo nel quale presentarsi, oltre che l’indicazione del procedimento penale per il quale è richiesta la dichiarazione testimoniale.
L’art. 198 c.p.p. sancisce che il testimone ha l’obbligo
- di presentarsi dinanzi al giudice;
- di attenersi alle prescrizioni date dal giudice stesso per le esigenze processuali;
- di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Il cittadino, dunque, non ha la mera facoltà di presentarsi a testimoniare, ma – se chiamato – ha l’obbligo di presentarsi e rendere testimonianza, anche nel caso in cui precedentemente abbia già reso delle dichiarazioni sui medesimi fatti dinanzi ad altre autorità, come le Forze di Polizia. Il giudice, infatti, non è a conoscenza delle precedenti dichiarazioni eventualmente rese.
Una volta presente in udienza, il cittadino verrà chiamato a sedersi al banco dei testimoni, dovrà qualificarsi fornendo le proprie generalità e dovrà impegnarsi nell’assunzione del proprio ruolo mediante la lettura a voce alta di una formula sacramentale, che verrà indicata dal giudice. Appare opportuno evidenziare che nell’ordinamento italiano questo impegno solenne non viene assunto mediante giuramento sulla Bibbia, alla luce della laicità dello Stato italiano, ma viene assunto invece mediante la lettura di una precisa formula volta a rendere consapevole il cittadino dell’importanza del ruolo assunto.
Solo dopo la lettura di tale formula, e l’avvertimento da parte del giudice delle eventuali conseguenze cui il testimone può andare incontro, avranno inizio le domande, alle quali il testimone sarà obbligato a rispondere secondo verità.
3 - Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi?
Il legislatore penale italiano, proprio alla luce del ruolo rilevante giocato dal testimone all’interno del processo, ha previsto delle conseguenze particolarmente incidenti per il soggetto che violi gli obblighi previsti dall’art. 198 c.p.p.
In primo luogo, nel caso in cui il cittadino regolarmente chiamato a testimoniare non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l'impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il giudice potrà disporre il cd. accompagnamento coattivo: viene disposta un’ulteriore udienza alla quale il testimone dovrà essere accompagnato coattivamente dalle Forze dell’Ordine. Il giudice potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da €51 a €516 a favore della cassa delle ammende, nonché al pagamento delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.
In secondo luogo, una conseguenza ancor più grave è prevista nel caso di violazione dell’ulteriore obbligo: se il testimone nel corso del proprio esame non rispetta e viola l’obbligo di dire la verità commette un fatto penalmente rilevante, quale il reato di falsa testimonianza.
L’art. 372 c.p. prevede, invero, la pena della reclusione dai due ai sei anni per chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, realizzi una delle seguenti condotte:
- affermare il falso
- negare il vero
- tacere, in tutto o in parte, in merito a ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato.
In particolare, il reato di falsa testimonianza è un cd. reato proprio, in quanto – nonostante la disposizione legislativa faccia riferimento a “chiunque” – il reato può essere commesso solo da quel soggetto che abbia assunto la qualità di testimone; qualità che si assume nel momento in cui viene disposta la citazione dei testimoni.
Il reato di falsa testimonianza si pone a tutela del bene giuridico dell’Amministrazione della giustizia ed è procedibile d’ufficio: non è richiesta la presentazione della querela, ma il giudice al termine del dibattimento potrà automaticamente trasmettere gli atti al PM affinché si proceda per l’accertamento della falsa testimonianza.
Ulteriore caratteristica del reato di falsa testimonianza è quella di essere un cd. reato di pericolo. Affinché vi sia la condotta penalmente rilevante, è sufficiente che la dichiarazione sia pertinente all’oggetto del giudizio e suscettibile di incidere, seppur in astratto, sulla decisione giudiziaria; non è richiesto che in concreto il giudice sia stato influenzato o che in concreto abbia preso una decisione ingiusta.
4 - In quali casi il testimone che dichiara il falso potrebbe andare esente da pena?
Una prima ipotesi si verifica nel caso in cui il testimone rilasci delle dichiarazioni false o reticenti, che però siano manifestamente inverosimili o riguardino circostanze del tutto irrilevanti ai fini del giudizio. Pur essendo un reato di pericolo, è necessario che vi sia compatibilità con il principio di offensività: la giurisprudenza ritiene che se la dichiarazione non ha nemmeno creato il pericolo della induzione in errore del giudice, e quindi non si è creato neanche un pericolo per l’amministrazione della giustizia, allora il soggetto non sarà punibile per assenza di offesa in concreto.
L’art. 384 c.p. prevede due ulteriori ipotesi di non punibilità. Al primo comma dispone che non è punibile chi abbia commesso una falsa testimonianza al fine di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore. Secondo tale disposizione, quindi, il soggetto che si trovi costretto ad affermare il falso, negare il vero o tacere quanto sa in merito ai fatti di reato, al fine di evitare una lesione della propria libertà o dell’onore, non può essere punito per falsa testimonianza. Ciò risponde al principio secondo cui nessuno può essere obbligato ad auto-accusarsi ed a rilasciare dichiarazioni sulla propria responsabilità.
L’art. 384 c.p., inoltre, prevede che il soggetto vada esente da pena non solo quando voglia salvare sé stesso, ma anche un prossimo congiunto. Ci si è chiesti se tale locuzione ricomprenda anche il convivente more uxorio: il legislatore penale, invero, ha preso una posizione precisa in merito alle parti di un’unione civile, inserendoli nella definizione di “prossimi congiunti” ai sensi dell’art. 307 c.p. (e per i quali è quindi senza dubbio applicabile l’art. 384 c.p.), non prendendo invece in considerazione il convivente di fatto. Se una lettura estensiva della disposizione sembra doverosa alla luce di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, una diversa ricostruzione ritiene non potersi interpretare estensivamente la disposizione, avendo il legislatore implicitamente preso una decisione negativa in merito. Una diversa scelta legislativa è stata fatta in merito al reato di maltrattamenti, sul quale puoi leggere qui.
Si evidenzia, infine, che l’art. 384 co. 1 c.p. non potrà essere applicato a quel prossimo congiunto che sia stato avvisato della facoltà di astenersi, e abbia deciso di rinunciare a tale facoltà così da rendere testimonianza.
Invero, al prossimo congiunto è generalmente riconosciuta la facoltà di astenersi in un processo a carico di un proprio familiare, facoltà della quale deve essere ritualmente informato. Ma se il soggetto, una volta informato, decide comunque di rendere testimonianza, e di non avvalersi della facoltà di astensione, allora dovrà rispettare tutti gli obblighi previsti per il testimone dall’art. 198 c.p.p., non potendo invocare l’art. 384 c.p. nel caso in cui violi l’obbligo di dire la verità.
Solo se il prossimo congiunto non venga ritualmente avvisato della facoltà di astenersi, e durante la testimonianza dichiari il falso, non potrà essere punito, ma ai sensi del comma 2 dell’art. 384 c.p., e quindi per violazione di una legge processuale.
Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
Condividi:
Il testimone nel processo penale: obblighi e responsabilità
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
La prescrizione penale del reato: cos’è e come funziona?
11 feb. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
La disciplina della prescrizione è da tempo al centro del dibattito pubblico e politico, oltre che giuridico. Nell’arco di pochi anni è stata infatti oggetto di due importanti riforme (rispettivamente riforma Orlando nel 2017 e riforma Bonafede nel 2019), che ne hanno radicalmente cambiato i connotati. Ciò non esclude, peraltro, che nel prossimo periodo il decisore politico possa intervenire nuovamente sulla materia. Cerchiamo dunque di comprendere più da vicino le finalità dell’istituto e di analizzare i tratti principali della disciplina prevista dal codice penale.1. Cos’è la prescrizione del reato?2. Come funziona la prescrizione?3. Vi sono dei casi di interruzione o sospensione del termine prescrizionale?4. L’imputato può rinunciare alla prescrizione?1 - Cos’è la prescrizione del reato?La prescrizione integra una causa di estinzione del reato: ciò vuol dire che, decorso un determinato periodo di tempo prestabilito ex legge dalla consumazione del fatto criminoso, senza che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva, il giudice dovrà prosciogliere l’imputato per l’intervenuta prescrizione del delitto. La persona, dunque, non verrà sanzionata penalmente. La prescrizione, in particolare, declina in termini temporali l’interesse dello Stato a irrogare una sanzione in relazione a un determinato illecito penale: spirato il termine prescrizionale viene meno la pretesa punitiva dello Stato, in quanto si ritiene che sia trascorso troppo tempo per considerare una persona ancora meritevole di pena. La Corte costituzionale, a tal riguardo, ha parlato di un vero e proprio “diritto all’oblio in capo all’autore [del reato]” (Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24).Chiarita in questi termini la finalità di fondo dell’istituto, deve fugarsi ogni dubbio in merito a un fraintendimento che spesso caratterizza il dibattito pubblico e, alle volte, anche quello politico: la prescrizione è cosa diversa dalla (ragionevole) durata dei processi, sebbene chiaramente le tematiche presentino dei forti punti di connessione. La prima riguarda l’interesse dello Stato a punire e, specularmente, quello dell’imputato a non ricevere una pena qualora sia trascorso troppo tempo dalla commissione del fatto; la seconda, invece, si sostanzia nel diritto della persona – e del relativo dovere dello Stato – a che un processo venga celebrato in tempi rapidi. Intervenire sulla disciplina della prescrizione, quindi, non significa affatto risolvere la problematica della irragionevole durata dei processi. Affinché ciò possa avvenire sarebbe necessario un articolato catalogo di interventi legislativi, a partire da una riforma che provveda a riorganizzare l’assetto degli uffici giudiziari.2 - Come funziona la prescrizione?La durata del termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 157 c.p., è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, in ogni caso, non inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni. La norma prevede inoltre dei termini speciali per talune fattispecie di reato considerate più gravi: per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ad esempio, si applica un termine prescrizionale raddoppiato (se vuoi saperne di più sul reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., clicca qui)I reati puniti con la pena dell’ergastolo – così l’omicidio aggravato di cui all’art. 576 c.p. – sono invece imprescrittibili. La ragione di questa scelta politico-criminale si fonda sulla gravità del reato: a voler riprendere il suddetto esempio, il legislatore ha ritenuto che l’interesse a punire dello Stato non debba mai svanire nel caso di omicidio aggravato, venendo in rilievo il bene giuridico della vita. Quanto al momento di decorrenza della prescrizione, si noti che per il reato consumato il termine decorre dal momento della sua consumazione e per quello tentato, invece, da quando è cessata l’attività delittuosa. Per i reati permanenti e continuati, infine, da quando è cessata la permanenza o la continuazione.3 - Vi sono dei casi di interruzione o sospensione del termine prescrizionale?Si, il codice penale disciplina i casi di sospensione, interruzione e dei relativi effetti agli artt. 159, 160 e 161 c.p.La sospensione della prescrizione – che differentemente dall’interruzione produce i propri effetti nei confronti delle sole persone a processo e non di tutti coloro i quali hanno commesso il reato – determina l’arresto del decorso della prescrizione, che riprende il suo corso dal giorno in cui cessa la causa sospensiva. L’ipotesi sospensiva di maggior interesse – introdotta con la legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge ‘spazza-corrotti’, anche nota come riforma Bonafede) – riguarda la sospensione della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado sino a che questa non sia divenuta irrevocabile. In altre parole, il termine non decorre più dall’emissione della sentenza di primo grado – indipendentemente che la decisione sia di assoluzione o di condanna – sino alla conclusione del processo. L’innovazione normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e potrà applicarsi esclusivamente con riferimento ai fatti di reato commessi successivamente a questa data. In ragione della rilevanza della riforma, è necessario effettuare un cenno alla normativa previgente risalente alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. riforma Orlando). L’art. 159 c.p. prevedeva la sospensione della prescrizione – per un termine comunque non superiore a un anno e sei mesi – dal giorno indicato per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della decisione del grado di appello (il medesimo meccanismo regolamentava altresì il rapporto tra secondo grado e giudizio di Cassazione). Peraltro, a differenza della norma attualmente vigente, ai fini della sospensione veniva in rilievo esclusivamente la sentenza di condanna. In caso di assoluzione, dunque, il termine prescrizionale continuava a decorrere. Inoltre, qualora all’esito di un grado di giudizio successivo al primo fosse intervenuta una decisione di assoluzione, il periodo di sospensione veniva ‘recuperato’ ai fini del conteggio totale. Quanto all’interruzione della prescrizione, quest’ultima, per via del compimento di alcuni atti giudiziari, determina il prolungamento del termine prescrizionale, che comincia nuovamente a decorrere dal giorno stesso in cui si è verificata la causa interruttiva. In ogni caso, ai sensi dell’art. 161, co. 2 c.p. l’aumento non può essere superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere, salvi i casi di alcuni reati specificamente indicati dalla norma per cui è previsto un aumento maggiore. In concreto: se il reato si prescrive in sei anni e si verifica una causa interruttiva, il nuovo termine prescrizionale sarà di sette anni e sei mesi. Le cause di interruzione della prescrizione sono tassativamente indicate dall’art. 160 c.p.: fra queste, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto che dispone il giudizio e non invece, non essendo espressamente previsto, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. 4 - L’imputato può rinunciare alla prescrizione?Si, ai sensi dell’art. 157, co. 7 c.p., l’imputato può rinunciare alla prescrizione: potrebbe avvenire, ad esempio, nei casi in cui la persona – convinta della propria innocenza – miri a ottenere una pronuncia di piena assoluzione. In tali casi, dunque, il giudice non dichiarerà l’estinzione del reato – sebbene il termine prescrizionale sia già maturato – ma dovrà esprimersi nel merito della vicenda. Il codice penale prevede che la dichiarazione di rinuncia avvenga in modo espresso. Ciò vuol dire che la volontà dell’imputato deve essere estrinsecata in maniera esplicita, non potendosi desumere implicitamente. Si consideri, inoltre, che la rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo e, pertanto, la relativa dichiarazione deve essere effettuata personalmente dall’imputato o dal difensore munito di apposita procura speciale. Secondo l’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, la dichiarazione di rinuncia può essere altresì revocata, a condizione però che non sia già intervenuta la decisione del giudice (a titolo esemplificativo Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2012, n. 30104). Deve tuttavia segnalarsi una pronuncia di segno contrario, ad avviso della quale la rinuncia alla prescrizione è irrevocabile (Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2008, n. 33344). Editor: avv. Davide Attanasio
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Aveva solo 25 anni
17 gen. 2026 • tempo di lettura 1 minuti
Aveva solo 25 anni - (A Beniamino Zuncheddu vittima di un grave errore giudiziario)In una giornata di Novembre del 1991 , il sole della sua Vita, tutto d'un tratto, veniva oscurato.La sua giovinezza veniva spezzata.Aveva solo 25 anni.In una cella tredda veniva rinchiusosenza un perché...Aveva solo 25 anni.Le lacrime gli rigavano il volto, la disperazione, la solitudine, la paura...tormentavano la sua mente.Aveva solo 25 anni.Pregava Dioaffinché gli desse Speranza, Conforto in questo incubo,mentre gridava a gran voce la sua innocenza.Aveva solo 25 anni.La sua giovinezza era spezzata.Un giorno un Uomo dalla toga nera gli tese la mano e gli disse: " Abbi fiducia in me, ti restituirò la Giustizia negata"Il 26 Gennaio 2024Gli fu restituita la tanto implorata Libertà!Avv. Luisa Camboni
Continua a leggere
Scritto da:
La rilevanza penale del bacio
23 mag. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
Ai sensi dell’art. 609-bis c.p., è punito chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Ma cosa si intende per “atti sessuali”?Cenni sul delitto di violenza sessualeLa nozione di “atti sessuali”La rilevanza del bacio nelle pronunce della Corte di Cassazione1 - Cenni sul delitto di violenza sessualeL’art. 609-bis c.p. tutela la libertà sessuale, cioè la libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono.Le condotte prese in considerazione sono essenzialmente due: violenza sessuale per costrizione (co. 1), realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità;violenza sessuale per induzione (co. 2), attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.Il consenso al rapporto sessuale deve perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale, non solo all'inizio: il delitto è integrato quando il consenso originariamente prestato venga meno a causa di un ripensamento o a causa della non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto.Il consenso, inoltre, deve essere prestato validamente e coscientemente.L’art. 609-bis u. co. c.p. prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale ed indefinita, qualora la compressione della libertà sessuale sia minima avuto riguardo al fatto concreto e delle circostanze.La violenza sessuale è punita con la reclusione da sei a dodici anni ed è procedibile a querela di parte: la querela deve essere proposta entro dodici mesi dal fatto ed è irrevocabile.2 - La nozione di “atti sessuali”Il concetto di “atti sessuali” è poco determinato e ha causato, per questo motivo, un dibattito. In particolare, tradizionalmente sono state proposte due tesi volte a perimetrare la nozione di atto sessuale penalmente rilevante.Per la tesi oggettivo-anatomica, gli atti penalmente rilevanti vengono selezionati mediante il parametro della zona del corpo attinta dagli atti sessuali: è centrale il concetto di zona erogena, per come è intesa dalla scienza medica e dalle scienze psicologica, antropologica e sociologica.A questa tesi si contrappone quella oggettivo-contestuale, secondo la quale si dovrebbero invece considerare il contesto e le varie circostanze nelle quali l'atto viene commesso, al fine di determinarne la natura sessuale (ad es. viene spesso citata la “pacca” sui glutei di una conoscente o la natura di saluto dei baci sulla bocca in talune culture, quale quella russa).La giurisprudenza accoglie prevalentemente la seconda tesi: per stabilire ciò che può considerarsi atto sessuale non è sufficiente fare riferimento alle parti anatomiche aggredite, ma occorre tenere conto dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva. Di conseguenza, nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente. In quest’ottica, anche un bacio, un abbraccio o un palpeggiamento sono idonei a compromettere la libertà sessuale dell'individuo, qualora, tenendo conto di tutti gli elementi del caso concreto, emerga una indebita compromissione della sessualità del soggetto passivo.Ne consegue che ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, il giudice di merito deve accertare la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci: in particolare, il giudicante deve fare una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente fra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante. Con particolare riferimento al bacio sulla bocca, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che esso integra il reato di violenza sessuale, se dato senza il consenso, anche se limitato al semplice contatto delle labbra: il bacio sulla bocca perde il suo connotato sessuale solo se è dato in particolari contesti sociali o culturali, dove è solo un segno di affetto.3 - La rilevanza del bacio nelle pronunce della Corte di CassazioneLa Cassazione ha, quindi, in molte occasioni, qualificato il bacio come atto sessuale. Di recente ha affermato che nel reato di violenza sessuale, l’elemento della violenza può estrinsecarsi, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel “compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare a sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi” (Cass. Pen., 19 gennaio 2018, n. 47265). Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un dentista che aveva baciato sulla bocca, in modo repentino, una minore, dopo averla fatta accomodare sulla poltrona e averle controllato l’apparecchio ortodontico: nella pronuncia si legge che l’estemporanea iniziativa del dentista aveva colto di sorpresa la minore e l’aveva posta in una condizione di impossibilità di reagire e di esprimere il suo dissenso. In un diverso caso, la Suprema Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di un medico di guardia presso una casa di riposo che, dopo essersi avvicinato velocemente ad un’operatrice sanitaria alla quale non era legato da alcun particolare rapporto confidenziale, l’aveva baciata sulla bocca con una forte pressione (Cass. Pen., 26 novembre 2014, n. 964). Ancora, la Cassazione ha affermato che è idonea a offendere la libertà di autodeterminazione sessuale “la condotta rapida e insidiosa di chi stringe con forza una donna fra le braccia baciandola sul collo, nella piena consapevolezza di un rifiuto inequivocabilmente e reiteratamente palesato” (Cass. Pen., 9 giugno 2006, n. 19808). In definitiva, il bacio sulla bocca dato in assenza di consenso – al di fuori dei contesti in cui assume valenza di saluto (come nella tradizione russa) o segno di affetto privo di valenza sessuale (come in alcuni contesti familiari o parentali) – è penalmente rilevante, indipendentemente dalla sua profondità, anche se limitato al semplice contatto delle labbra, in quanto attinge una zona generalmente considerata erogena.Editor: dott.ssa Elena Pullano
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Interesse superiore dei minori: Italia nuovamente condannata dalla Corte di Strasburgo
16 ago. 2023 • tempo di lettura 5 minuti
La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 10 novembre 2022, ha condannato all’unanimità l’Italia per una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il caso ha riguardato la presunta violazione da parte dello Stato italiano del suo dovere di proteggere e assistere la ricorrente e i suoi due figli durante gli incontri organizzati con il padre di questi ultimi – tossicodipendente e alcolista – accusato di maltrattamenti e minacce contro la donna, nonché la decisione dei tribunali nazionali di sospendere la responsabilità genitoriale della stessa, considerata un genitore “ostile agli incontri con il padre”. La madre dei bambini aveva adotto quale motivazione per non partecipare a tali incontri i precedenti fatti di violenza subiti e la mancanza di sicurezza degli stessi. In particolare, i ricorrenti hanno sottolineato che gli incontri non si sono svolti nelle condizioni di “protezione rigorosa” prescritta dalle autorità competenti, circostanza che li ha esposti a ulteriori violenze. Inoltre, la donna ha lamentato di aver subito una vittimizzazione secondaria in violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione, essendo stata ritenuta un genitore non cooperativo e privata della sua potestà genitoriale.La Corte Europea - tenuto conto della giurisprudenza in materia (cfr. Remetin c. Croazia (n. 2), n. 7446/12, §67, 24 luglio 2014) e della natura delle censure sollevate dai ricorrenti - ha ritenuto che il caso di specie dovesse essere esaminato dal solo punto di vista dell’art. 8 della Convenzione, nella misura in cui stabilisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare […]”. Preliminarmente, i giudici di Strasburgo hanno ricordato che la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente ha interferito con il suo diritto al rispetto della vita familiare (mutatis mutandis R.M. c. Lettonia, n. 53487/13, § 102, 9 dicembre 2021). Tale ingerenza viola l’art. 8 della Convenzione, a meno che non sia “a norma di legge”, persegua uno o più scopi legittimi di cui al comma 2, e non possa essere considerata un provvedimento “necessario” in una società democratica. Per quanto riguarda la vita familiare di un bambino, vi è attualmente un ampio consenso – anche nel diritto internazionale – sull'idea che in tutte le decisioni riguardanti i bambini, il loro interesse superiore deve avere la preminenza (Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC], n. 37283/13, § 207, 10 settembre 2019, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 135, CEDU 2010, e X c. Lettonia [GC], n. 27853/09, § 96, CEDU 2013). Nei casi in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori sono in conflitto, l'art. 8 richiede alle autorità nazionali di trovare un giusto equilibrio tra tutti gli interessi, attribuendo particolare importanza all'interesse superiore del figlio, che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori (cfr., ad esempio, Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, § 64, CEDU 2003-VIII, nonché i riferimenti ivi citati). Nel caso di specie, per quanto riguarda i due bambini, la Corte ha osservato che, nonostante le ripetute segnalazioni ricevute sin dal 2015, il Tribunale per i Minorenni non ha sospeso i contatti fino a novembre 2018. In tale lasso temporale, i minori hanno dovuto incontrare il padre in un ambiente instabile che non ha favorito il loro sviluppo pacifico, nonostante le autorità competenti sapessero che l’uomo non seguiva più il suo programma di disintossicazione dalla droga e che il procedimento penale a suo carico per maltrattamenti era pendente. La Corte, dunque, non ha compreso perché il Tribunale per i Minorenni, abbia deciso di proseguire con le sessioni di contatto anche se il benessere psicologico, l’equilibrio emotivo e l'incolumità dei bambini non erano garantiti: in nessuna fase è stato valutato il rischio a cui sono stati esposti e nelle decisioni dei giudici nazionali non è emersa la dovuta attenzione in merito al loro interesse superiore, prevalente rispetto a quello del padre a continuare con le sessioni di incontro. La Corte ha anche preso atto della constatazione della Corte d'Appello di Roma secondo cui il padre, attraverso il suo comportamento aggressivo, distruttivo e sprezzante durante le sessioni, ha mancato al suo dovere di garantire uno sviluppo sano e sereno dei bambini. Ciò ha comportato una violazione dell'art. 8 della Convenzione nei confronti di entrambi i bambini. Per quanto riguarda la madre dei bambini, la Corte ha ritenuto che le decisioni dei tribunali interni di sospensione della sua responsabilità genitoriale non avessero tenuto conto delle difficoltà connesse alle sessioni di contatto e delle evidenziate condizioni di precarietà. Inoltre, nella sua relazione sull'Italia, il GREVIO (il Gruppo di esperti indipendenti del Consiglio d’Europa incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Convenzione di Istanbul) ha sottolineato che la sicurezza del genitore non violento e dei figli devono essere un fattore centrale quando si decide sull'interesse superiore del minore in relazione all'affidamento e alle modalità di visita. GREVIO ha anche osservato che i tribunali nazionali non hanno tenuto conto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul. La Corte Europea ha condiviso le preoccupazioni del GREVIO circa l'esistenza di una pratica diffusa da parte dei tribunali civili di considerare “non collaborative”, e quindi “madri non idonee” meritevoli di sanzioni, le donne che adducono il problema della violenza domestica quale motivo per non partecipare alle sessioni di contatto tra i propri figli e il loro ex partner, e per non accettare l'affidamento condiviso o il diritto di visita. Alla luce di quanto precede, i giudici europei hanno ritenuto che le autorità giudiziarie italiane non abbiano fornito ragioni pertinenti e sufficienti a giustificare la loro decisione di sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente tra il maggio del 2016 e il maggio del 2019, in quanto basata su un esame non approfondito della reale situazione della donna e sulla sua presunta ostilità nei confronti dell’ex partner. Pertanto, la Corte Europea ha riscontrato una violazione dell’art. 8 della Convenzione anche nei confronti della madre dei bambini.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com
Continua a leggere
Commenti
Non ci sono commenti




