Animali domestici e condominio: regole e limiti

Egregio Avvocato
Pubblicato il 20 apr. 2021 · tempo di lettura 6 minuti
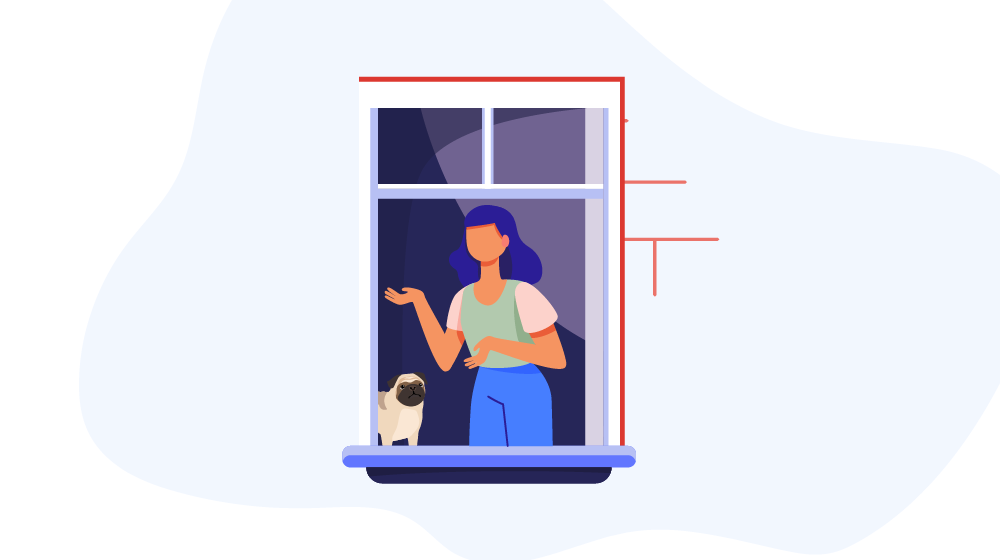
La riforma del Condominio, disciplinata dalla Legge n. 220 del 2012, ha finalmente dato una risposta, forse non del tutto esaustiva, all’annosa questione del possesso (o detenzione) degli animali all’interno degli edifici condominiali.
Infatti, con l’introduzione di un’apposita norma nel codice civile, è stato - in un certo senso - liberalizzato l’ingresso degli animali domestici nei condominii.
Nonostante ciò, diversi sono gli interrogativi che permangono: possono essere previsti dei limiti? Quali sono i comportamenti da tenere? In caso di contratto di locazione, il proprietario può porre dei divieti al conduttore?
- Animali domestici in Condominio: cosa prevede la legge? Quali animali rientrano nella nozione del codice civile?
- Cosa occorre fare se il regolamento condominiale ne vieta il possesso o la detenzione?
- Quali comportamenti è opportuno tenere?
- Animali domestici e locazione: il proprietario locatore può impedirne il possesso?
1 - Animali domestici in Condominio: cosa prevede la legge? Quali animali rientrano nella nozione del codice civile?
Possedere un animale domestico all’interno di un edificio condominiale può causare dissidi tra i singoli condòmini. Non tutti, infatti, nutrono i medesimi sentimenti verso gli animali, oppure, anche in presenza di persone che li apprezzano, possono sorgere problemi di varia natura.
La Legge n. 220 del 2012 di riforma dell’istituto condominiale è intervenuta anche su tale argomento, con l’introduzione del comma 5 all’articolo 1138 del codice civile, il quale recita testualmente: «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Questa definizione, tuttavia, non è stata esente da critiche. Difatti, se da un lato, è ovviamente positivo aver, finalmente, sdoganato la possibilità di possedere o detenere animali all’interno degli appartamenti condominiali, dall’altro lato la terminologia utilizzata è considerata da molti – anche da alcune associazioni di medici veterinari – troppo stringente e non in linea con la realtà.
Invero, aver adoperato il termine animale domestico anziché animale da compagnia è stato, in un certo senso, giustificato dall’intento di evitare di acconsentire alla presenza dei cosiddetti animali non convenzionali o esotici, che dir si voglia.
Le critiche mosse da associazioni di medici veterinari – primi fra tutti la Società Italiana Veterinari Animali Esotici e l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani – sono dettate dal fatto che il legislatore abbia attribuito all’aggettivo domestico un significato ambiguo e più vicino al “senso comune” che alla scienza.
In altri termini, la definizione si ritiene errata poiché non considera come d’affezione tutti quegli animali non convenzionali o esotici, quali conigli, cincillà, piccoli roditori, volatili, contrastando, tra l’altro, con la Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia – ratificata anche dallo Stato Italiano – volta proprio a tutelare «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia».
2 - Cosa occorre fare se il regolamento condominiale ne vieta il possesso o la detenzione?
Come detto, è il codice civile che impone il divieto di impedire, all’interno dei regolamenti condominiali, la detenzione o il possesso di animali domestici.
Ne consegue che un’eventuale disposizione contraria a quanto disposto dall’articolo 1138 del codice civile, renda nullo qualsiasi regolamento condominiale.
Inoltre, il singolo condòmino a cui dovesse essere vietato di tenere nella propria abitazione un animale in virtù di una delibera assembleare, può ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data in cui è stata emessa tale delibera o da quella in cui il soggetto abbia ricevuto il verbale suddetto.
3 - Quali comportamenti è opportuno tenere?
Aver consentito per legge il possesso o la detenzione di animali domestici all’interno di edifici condominiali non fa sì che il proprietario dell’animale in questione possa non rispettare i diritti altrui.
Innanzitutto, il proprietario di un animale domestico è, per ovvie ragioni, passibile di reclamo da parte degli altri condòmini qualora le immissioni – rumori molesti e odori sgradevoli – provenienti dal suo appartamento provochino insofferenze che, ovviamente, vanno provate.
Nell’ipotesi in cui, come prevede il codice civile, le immissioni diventino intollerabili, il Condominio potrà chiedere la cessazione della turbativa approvando una specifica delibera assembleare ovvero rivolgendosi al Giudice di Pace.
Particolare attenzione deve avere il proprietario dell’animale relativamente al rumore. Infatti, la tutela contro le immissioni rumorose è prevista anche dal nostro codice penale come specifica ipotesi di reato: il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
Va anche segnalato che gli animali non possono essere lasciati per lungo tempo senza vigilanza, poiché potrebbe ipotizzarsi il reato di omessa custodia.
Altro tema relativo ai doveri del proprietario di un animale domestico è l’accesso di quest’ultimo nelle parti comuni del Condominio, in merito, il codice civile dispone che ogni condòmino ha il diritto di usufruire delle parti comuni nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano.
Va da sé, quindi, che non può essere negato l’accesso alle parti comuni all’animale domestico ma, al tempo stesso, il proprietario deve adottare tutte quelle accortezze al fine di non ledere il diritto altrui al godimento delle stesse. In particolare, il cane che circola negli spazi comuni deve sempre indossare il cosiddetto guinzaglio corto – non più lungo di 1,50 metri – mentre per quel che riguarda la museruola, il padrone deve portarla con sé e farla indossare solo in caso di necessità (ad esempio, stando a un’ordinanza del Ministero della Salute, in ascensore la museruola va sempre fatta indossare).
4 - Animali domestici e locazione: il proprietario locatore può impedirne il possesso?
Se, per legge, il regolamento condominiale non può vietare il possesso o la detenzione di un animale domestico, lo stesso non si può dire nel caso in cui si tratti di immobile concesso in locazione.
Nessuna norma, infatti, vieta al locatore di prevedere nel contratto di locazione un divieto di detenere animali domestici. Tra il proprietario locatore e l’inquilino conduttore vige l’autonomia negoziale e ne consegue che le parti sono del tutto libere di determinare il contenuto del contratto, pur nel rispetto della legge.
Pertanto, è del tutto lecita un’eventuale clausola che vieti al conduttore di detenere animali domestici. Nell’ipotesi in cui, al contrario, il contratto non preveda alcun divieto, ciò non significa che il conduttore possa non rispettare gli obblighi o norme di comportamento a suo carico.
Difatti, pur potendo possedere un animale domestico, occorrerà comunque fare riferimento alle regole generali dettate in materia di locazione. Ad esempio, il codice civile impone al conduttore di conservare l’immobile concessogli in locazione in buone condizioni, osservando la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto.
Nonostante ciò, una parte della giurisprudenza sta, lentamente, iniziando a considerare gli animali quali esseri senzienti, applicando il principio di inviolabilità di cui all’articolo 2 della Costituzione anche ad essi.
In virtù di questa interpretazione, parte della giurisprudenza ritiene che la ratio dell’articolo 1138 del codice civile non sia incentrata sul diritto di proprietà dell’immobile, bensì sul “diritto all’animale d’affezione”. Ne consegue che sarebbero nulle le clausole che, nei contratti di locazione, vietino la detenzione di animali domestici poiché la libertà negoziale sarebbe limitata dal principio costituzionale di inviolabilità.
Va, in ogni caso, precisato che, al momento della redazione di questo articolo, sul punto la giurisprudenza non è ancora consolidata e che, stante anche il silenzio della legge, è certamente consigliabile confrontarsi con il proprietario locatore, per evitare possibili futuri problemi.
Editor: Avv. Marco Mezzi
Condividi:
Animali domestici e condominio: regole e limiti
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Le decisioni relative alla prole: affidamento, collocamento e responsabilità genitoriale
9 ago. 2021 • tempo di lettura 3 minuti
Il diritto di famiglia pone la sua attenzione sulla tutela dei figli, trattandosi di una materia non riservata al potere delle parti, ma nella quale sussiste il superiore interesse del minore tutelato dallo Stato e della collettività.I provvedimenti che il Tribunale deve assumere relativamente ai figli sono, soprattutto, quelli inerenti l’affidamento, il collocamento o la residenza privilegiata e la responsabilità genitoriale.Sempre a tutela del minore, inoltre, vi sono i provvedimenti che riguardano i diritti del coniuge non collocatario, ad esempio il diritto di visita ed i provvedimenti di natura economica.Qualsiasi decisione che venga assunta dal Tribunale dev’essere ispirata alla tutela della prole, tenendo in considerazione l’effettivo e reale interesse dei figli ai quali dev’essere garantito il benessere psicofisico finalizzato alla più attenta e favorevole crescita e maturazione, in un contesto sano ed equilibrato. Cosa si intende per affidamento, collocamento e responsabilità genitoriale?Come si individua il collocamento del minore?Come si determina il diritto al mantenimento?1 – Cosa si intende per affidamento, collocamento e responsabilità genitoriale?La materia della tutela dei figli è stata profondamente innovata, prima con l’introduzione dell’affidamento condiviso, mediante la legge n. 54/06, poi da una serie di normative promulgate in favore dei figli, fino ad arrivare al d.lgs 28 dicembre 2013 n. 154 che racchiude nel titolo IX del codice civile la materia della responsabilità genitoriale.La norma cardine è l’articolo 337 ter c.c., la cui novità più rilevante, introdotta con legge n.54/2006, è la presenza al suo interno di tre istituti: a) l’affidamento (custodia del minore) che non coincide più con la responsabilità genitoriale; b) il collocamento o residenza privilegiata, ovvero la determinazione del luogo dove rimane a vivere la prole, dei tempi, della modalità, della presenza dei figli presso ciascun genitore; c) la responsabilità (ex potestà genitoriale) che viene esercitata di norma da entrambi gli affidatari o separatamente in base alle statuizioni del giudice. Quanto all’affidamento, con ciò si intende sostanzialmente la “custodia dei figli”, e cioè il compito per ciascun genitore di provvedere a tutti gli incombenti utili e necessari ad un’esistenza serena dei figli. L’affidamento, di norma, è condiviso ciò significa che i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, restando l’affidamento univoco una eccezione limitata a casi particolari, laddove la custodia ad entrambi i genitori non appaia corrispondente agli interessi della prole.2 - Come si individua il collocamento del minore?Una volta stabilito l’affidamento, il giudice deve individuare il genitore presso il quale andranno a stabilirsi i figli (c.d. genitore collocatario), determinando i tempi e le modalità della loro permanenza presso il genitore prescelto e quella non collocatario e fissando la misura ed il modo della contribuzione nel mantenimento dei minori da parte del genitore non collocatario.Ipotesi frequente è quella in cui i genitori, dinanzi al magistrato per la tutela dei figli minori nati fuori dal matrimonio o in una separazione/divorzio giudiziale, concordano sul collocamento dei figli minori presso la madre alla quale verrà, di conseguenza, assegnata la casa coniugale. È pacifico che in caso di contrasto tra i coniugi circa l’individuazione del genitore collocatario tale compito spetterà al giudice tenendo conto dell’interesse della prole.Il giudice, dunque, nel disporre il collocamento dei figli minori deve prescindere anche dalle colpe e dalle responsabilità dell’uno o dell’altro coniuge del fallimento dell’unione matrimoniale, e dovrà tener conto soltanto della maggiore idoneità da un punto di vista materiale, psicologico ed affettivo dell’uno o dell’altro genitore.3 – Come si determina il diritto al mantenimento?Il dovere di mantenere i figli consiste nell’assicurare loro i mezzi necessari per la salute e il benessere, compatibilmente con il tenore di vita e con le condizioni economiche della famiglia.Tale dovere impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, riconducibili non al solo obbligo alimentare ma estese anche all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale.L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma cesserà soltanto nel momento in cui sarà data prova del raggiungimento dell’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso. Editor: Avv. Elisa Calviello
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
I parcheggi condominiali
30 mag. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
La riforma del Condominio del 2012 ha avuto il merito di inserire i posti auto tra le parti comuni del condominio. Difatti, il nuovo articolo 1117, numero 2, del codice civile include espressamente le aree destinate a parcheggio tra le parti comuni del condominio, recependo l’orientamento giurisprudenziale che, in mancanza di un espresso riferimento ai parcheggi, era concorde nell’estendere anche a tali aree la presunzione di condominialità di cui al già citato articolo 1117. I parcheggi condominiali: evoluzione normativaÈ possibile destinare un’area comune a parcheggio?Cosa consigliare in caso di parcheggi non sufficienti per tutti i condomini?1 - I parcheggi condominiali: evoluzione normativaNel corso degli anni la materia dei parcheggi condominiali è stata interessata da numerosi interventi normativi.In primo luogo, va citata la cosiddetta Legge ponte – Legge 765/1967 – la quale ha integrato la Legge Urbanista numero 1150/1942 prevedendo, all’articolo 41 sexies che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione. In altri termini, come ha inteso specificare anche la Corte di cassazione, questa norma ha posto un vincolo pubblicistico di destinazione nelle aree riservate ai parcheggi condominiali, inderogabile da parte di atti dei privati.La successiva Legge numero 47/1985 ha precisato ulteriormente che gli spazi già menzionati dalla precedente Legge 765 costituissero pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice civile. È intervenuta, quattro anni più tardi, la Legge Tognoli – Legge 122/1989 – con la quale si è elevato il rapporto tra le aree di pertinenza delle costruzioni e la volumetria del fabbricato a un metro quadro per ogni dieci metri cubi di costruzione, rispetto ai venti previsti nel 1967. Inoltre, la Legge Tognoli, all’articolo 9, ha ulteriormente previsto che: 1) i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti; 2) l’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività; 3) le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprietà non condominiale dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2, codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, comma 2 e 1121, comma 3, codice civile; 4) i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.La Legge n. 246/2005 ha, poi, ulteriormente integrato la Legge ponte aggiungendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, prevedendo che gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. Viene così meno il vincolo di pertinenzialità automatico per gli spazi riservati a parcheggio dalla cosiddetta Legge ponte.L’ultimo provvedimento in materia è il cosiddetto Decreto del Fare, convertito dalla Legge n. 35/2012, con cui si stabilisce che la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 dell’articolo 41 sexies già citato può essere trasferita anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestaule destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune.2- È possibile destinare un’area comune a parcheggio?La risposta è certamente affermativa. È comunque opportuno fare un breve focus sul punto.La trasformazione di un’area comune a parcheggio condominiale importa la scelta di soluzioni che rendano compatibili i concetti di innovazione, di cui all’articolo 1120 del codice civile, e di pari uso e/o di godimento paritario, di cui all’articolo 1102 dello stesso codice civile.La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la delibera assembleare di destinazione di aree condominiali scoperte a parcheggio debba essere approvata a maggioranza, aggiungendo che non è necessaria l’unanimità o il quorum come richiesto dall’articolo 1120 del codice civile prima della riforma del 2012. In altri termini, è stato ritenuta legittima la delibera condominiale presa con la maggioranza di cui all’articolo 1136, comma 2 del codice civile, di disporre la destinazione a parcheggio del cortile condominiale.Il nuovo articolo 1120 del codice civile, per come modificato dalla legge di riforma del condominio, ha sostanzialmente recepito l’impostazione giurisprudenziale e, sebbene definisce innovazioni le opere necessarie per realizzare i parcheggi condominiali, prevede la possibilità di deliberare questi interventi con i quorum deliberativi ordinari. Si prevede, infatti, che i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto opere per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio.3 - Cosa consigliare in caso di parcheggi non sufficienti per tutti i condomini? La Corte di cassazione ha stabilito che l’assemblea del condominio può stabilire di razionalizzare lo sfruttamento dell’area destinata a parcheggio mediante apposizione di strisce delimitative per ciascun posto auto, eventualmente numerato, assegnandoli al dominio esclusivo di ogni condomino o usufruitore (sul punto si veda Cass. civ., sent. 5997/2008).In questi casi l’assegnazione dei posti auto deve seguire criteri predefiniti, quali la facilità di accesso, e laddove non si dovesse trovare un accordo sulle modalità di assegnazione, sarebbe preferibile procedere a sorteggio.Tuttavia, non sempre l’area destinata a parcheggio è in grado di garantire la copertura integrale degli stalli rispetto al numero degli utenti – condomini richiedenti. Quale criterio, quindi, è consigliabile attuare?Certamente sbagliato sarebbe disporne l’attribuzione in base al valore millesimale di ciascuna unità immobiliare. Anzi, a dire il vero, la giurisprudenza ha costantemente considerato queste deliberazioni illegittime atteso che la quota di proprietà di cui all’articolo 1118 del codice civile, quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione, ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti (Cass. civ., sent. 26226/2006). Nel disaccordo tra i condomini, ai fini dell’utilizzazione dell’area comune, l’unico principio applicabile al caso di specie è quello del “pari uso”, sancito dall’articolo 1102 del codice civile, a norma del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In altri termini, in queste ipotesi, la soluzione certamente migliore è quella della turnazione all’uso del parcheggio.
Continua a leggere
Scritto da:
L'avvocato familiarista, definito anche avvocato matrimonialista o divorzista, è un Professionista specializzato in diritto di famiglia, tra i cui temi rientrano, tra gli altri, matrimonio, unioni civili, coppie di fatto, separazioni e divorzi, nonché i diritti della persona, dei minori e delle successioni. Oggi, desideriamo far luce sulle principali questioni che riguardano i figli nati al di fuori del matrimonio, oggetto di domanda o discussione poste da moltissime coppie non coniugate Riconoscimento del figlio nato da coppia non sposata: Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dai genitori (purchè più grandi di 16 anni), anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento, tanto congiuntamente quanto separatamente. In caso di genitori con età inferiore ai 16 anni, è necessario che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio. Qualora il minore abbia compiuto 14 anni il riconoscimento è subordinato al suo assenso, in quanto si presuppone che a 14 anni l'individuo abbia raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli di decidere sul suo interesse ad acquistare un nuovo status. Invece, il riconoscimento del figlio che non ha compiuto 14 anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore se questo ha già effettuato il riconoscimento. Tuttavia, il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio. Per opporvisi, chi vi abbia già provveduto deve provare l’esistenza di circostanze eccezionali tali da comportare, ove il secondo riconoscimento venga effettuato, un serio pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore. In proposito, non rilevano valutazioni comparative dei due genitori, né apprezzamenti negativi circa la personalità o la condotta di chi intende effettuare il secondo riconoscimento, se non nei limiti in cui possano evidenziare che l’acquisto di quei diritti sia foriero, per il minore stesso, più di nocumento che di vantaggio. Che succede se un genitore non vuol far riconoscere il figlio all’altro. La conflittualità tra i genitori, come pure la mancanza di affetto, la diversità culturale, di origini, di etnia e di religione e una condotta morale non esente da censure (a meno che questi sia parte di un'organizzazione criminale o sia detenuto per gravi motivi) non sono una valida ragione per negare il proprio consenso al riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore. Soltanto il fanatismo religioso può assumere rilievo dirimente, qualora esso si traduca in un’indebita compressione dei diritti di libertà del minore o in un pericolo per la sua crescita. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, se il consenso dell’altro genitore è rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se entro trenta giorni dalla notifica non viene proposta opposizione, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante. Se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto quattordici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di istaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente infondata. Come si fa il riconoscimento del figlio di una coppia non sposata? Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato. L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Cosa succede con il riconoscimento del figlio? Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli. In capo al genitore che procede al riconoscimento, dunque, sorgono gli obblighi di educazione, di istruzione, di assistenza morale e di mantenimento fino all’indipendenza economica. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. L’obbligo di mantenere il figlio decorre dal momento della nascita, anche nel caso in cui il riconoscimento avvenga a distanza di vari anni dalla nascita, pertanto il genitore che ha effettuato successivamente il riconoscimento deve rimborsare pro quota l’altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio medesimo, tenuto conto di quanto l’obbligato avrebbe dovuto corrispondere qualora il riconoscimento avesse avuto luogo fin dalla nascita del figlio, Il figlio nato da coppia non sposata è erede? I figli nati fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti sull’eredità dei genitori rispetto ai figli nati all’interno del matrimonio. Quale cognome prende il figlio di una coppia non sposata? Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome sia del padre che della madre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Che cosa si può fare quanto uno dei genitori non riconosce il figlio? In tal caso, l’altro può trascinarlo in tribunale affinché sia il giudice ad accettare il rapporto di filiazione. La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.La paternità viene di solito dimostrata tramite il test del Dna. Il padre non può esimersi senza giustificato motivo al prelievo del sangue. L’eventuale rifiuto comporta l’automatico riconoscimento del figlio da parte del giudice. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale. Non assume carattere di prova assoluta e certa neanche la dimostrazione dell’esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento. Ciò, tuttavia, non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito. Questi è infatti dotato di ampio potere discrezionale e può legittimamente basare il proprio apprezzamento in ordine all’esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie indiziarie, previa indicazione degli elementi su cui intende fondare la pronuncia. L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa: dal figlio; dai discendenti se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione; dal genitore esercente la responsabilità genitoriale se il figlio è minore; dal tutore per l’interdetto. . Se il figlio ha compiuto l’età di 14 anni occorre il suo consenso quale presupposto necessario per promuovere o per proseguire l’azione. L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità, se condotta dal figlio, non cade mai in prescrizione. La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.
23 set. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Il coniuge che lascia la propria abitazione è, nell'immaginario collettivo, l'origine scatenante la crisi del rapporto matrimoniale. Ad un'attenta analisi, però, non può sfuggire che, invece, la crisi matrimoniale affonda le sue ragioni in un momento antecedente, pertanto l'andarsene via di casa rappresenta solo la plateale esplosione di un malessere che già da tempo covava nella coppia.La ragione per una tale drastica decisione può avere diverse spiegazioni logiche, che esulano dagli scopi di questo intervento. Quello che dobbiamo precisare è la rilevanza giuridica di un tale atto.Oggi, non vi è più il reato di abbandono del tetto coniugale, ma questo gesto può avere delle importanti conseguenze sul piano civilistico in sede di separazione e divorzio. Un tale gesto, infatti, può avere conseguenze importanti ai fini dell'addebito, ragion per cui - qualora ci si dovesse decidere di farlo - è opportuno pianificare le proprie azioni con il proprio legale, onde evitare spiacevoli conseguenze. Pertanto, riteniamo opportuno suggerire di non abbandonare mai la casa coniugale, cercando di resistere - laddove possibile - fino all'udienza presidenziale. Ovviamente, laddove dovessero presentarsi situazioni gravemente conflittuali o il pericolo di strumentalizzazioni o false denunce di violenza, è meglio depositare un ricorso e andare via da casa. In ogni caso, tali decisioni debbono essere attentamente valutate comunemente con il proprio difensore, in quanto, in via astrattamente teorica, esistono delle situazioni in cui l’abbandono immediato della casa coniugale è la soluzione migliore per tutelarsi; difatti, è considerata prevalente la tutela del coniuge eventualmente vittima di episodi di violenza psicologica o fisica. In questi casi, diventa fondamentale far prevalere il diritto del soggetto ad allontanarsi dalla fonte della violenza, rappresentata dall’altro coniuge.Recentemente, la Suprema Corte (Cass. N. 20228/2022) si è interessata all'argomento, asserendo che "l’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non costituisce presupposto per l’addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo quindi alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale". Sulla stessa scia, gli Ermellini si erano già espressi precedentemente (Cass. Sez. I, 16.04.2018, n. 9384), sottolineando che “l’abbandono del tetto coniugale è giustificato dalla violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet. Ciò costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.In conclusione, appare opportuno valutare attentamente, insieme al proprio procuratore, tutte i fattori presenti e decidere, sempre di comune accordo, sul da farsi. In ogni caso, sono da evitare i colpi di testa insensati e non opportunamente ponderati.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
Continua a leggere
Scritto da:
Dichiarazione di successione: chi, cosa, dove, quando e perché!
21 gen. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Alla morte di una persona i suoi beni passano agli eredi, testamentari o legittimi. Il trasferimento di ricchezza a causa di morte è tassato dallo Stato ed è per questo che i chiamati all'eredità, o coloro che nel frattempo l’amministrano, devono presentare la Dichiarazione di Successione presso l’Agenzia dell’Entrate. Ma cos’è la dichiarazione e chi, di preciso, la deve presentare?Cos’è la Dichiarazione di successione Chi deve presentarla ed entro quanto tempoDove e come presentarla Perché è importante 1 - Cos’è la Dichiarazione di Successione Quasi tutti i trasferimenti di ricchezza sono sottoposti al pagamento di un’imposta a favore dello Stato, tra questi rientrano i trasferimenti che si generano in forza di una successione a causa di morte: cioè i beni che alla morte del defunto passano a favore dei suoi eredi, legittimi o testamentari.Infatti, il D.P.R. n. 637/1972, che regola l’imposta sulle successioni e donazioni, all’art. 1 stabilisce che l'imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte. Ciò giustifica la ragione per cui, alla morte di un soggetto, deve essere presentata presso l’Agenzia delle Entrate la cd. Dichiarazione di Successione. La dichiarazione contiene la descrizione analitica di tutti i beni e diritti che si trovano nell’asse ereditario ed il relativo valore, proprio al fine di permettere all’Agenzia l’individuazione della base imponibile e la determinazione dell’eventuale imposta da liquidare.L’imposta di successione non è sempre dovuta! In caso di eredità a favore del coniuge o di parenti in linea retta si paga soltanto se l’asse ereditario supera la franchigia di 1 milione di euro e per un’aliquota del 4% (per le altre franchigie e aliquote guarda qui).2 - Chi deve presentarla ed entro quanto tempoEntro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che ai sensi dell’art. 456 codice civile coincide con il momento della morte, sono obbligati a presentare la dichiarazione:i chiamati all’eredità (cioè coloro che per legge o per testamento ricevono l’eredità, ancorché non l’abbiano ancora accettata);i legatari;i rappresentanti legali, quando i chiamati e legatari sono soggetti incapaci (es. in caso di minore sono i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale);coloro che siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacente; gli esecutori testamentari. Se vi sono più persone obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che ne venga presentata una sola: ad esempio, se alla morte sono chiamati all’eredità più figli, basta che uno solo di questi presenti la dichiarazione. Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione il coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (cioè i figli, discendenti o genitori) ai quali sia stata devoluta un’eredità con valore dell’attivo non superiore a 100.000 euro e nell’asse ereditario non ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari.In caso di dichiarazione tardiva si può sempre procedere ad un ravvedimento operoso: ossia si produrrà la dichiarazione e si pagheranno gli interessi di mora. Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate ha già operato l’accertamento d’ufficio il ravvedimento operoso non sarà più possibile e si dovranno pagare le sanzioni amministrative in aggiunta a quanto dovuto e agli interessi di mora. 3 - Dove e come presentarla Dal 2018 la dichiarazione può essere presentata solo online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal contribuente o da un professionista incaricato.L’Agenzia delle Entrate fornisce sul proprio sito il Modello di Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, accompagnato da due fascicoli che forniscono le istruzioni per l’inserimento corretto di tutti i dati.Ad esempio, nella dichiarazione dovranno essere indicati, oltre ai dati degli eredi e del defunto:i beni immobili e i diritti reali su beni immobili; le rendite, le pensioni e i crediti; le aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili che non fanno parte di aziende;le passività deducibili.Se nel compendio ereditario ci sono beni immobili (terreni o fabbricati) occorre versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione anche le imposte ipotecaria e catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali.Attenzione! chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione IMU: sono gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate che trasmettono la copia della dichiarazione al Comune.4 - Perché è importante Oltre a comunicare il trasferimento dei beni agli eredi a fini fiscali, la dichiarazione di successione è importante perché nessun bene ricevuto in eredità può essere venduto se non sono state pagate le relative imposte. Inoltre, la prova della presentazione della dichiarazione viene richiesta sempre dalle banche prima di poter mettere a disposizione degli eredi il conto corrente del defunto.È importante precisare che la dichiarazione di successione è ben diversa dall’accettazione dell’eredità. Abbiamo visto, infatti, che la dichiarazione ha una mera valenza fiscale, volta a individuare la consistenza dell’asse ereditario e verificare se è dovuta l’imposta di successione e il suo quantum: pertanto, la dichiarazione non sostituisce l’accettazione dell’eredità, cioè l’atto con cui gli eredi accettano di subentrare in ogni rapporto giuridico attivo e passivo del de cuius.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti




