Dichiarazione di successione: chi, cosa, dove, quando e perché!

Egregio Avvocato
Pubblicato il 21 gen. 2021 · tempo di lettura 4 minuti
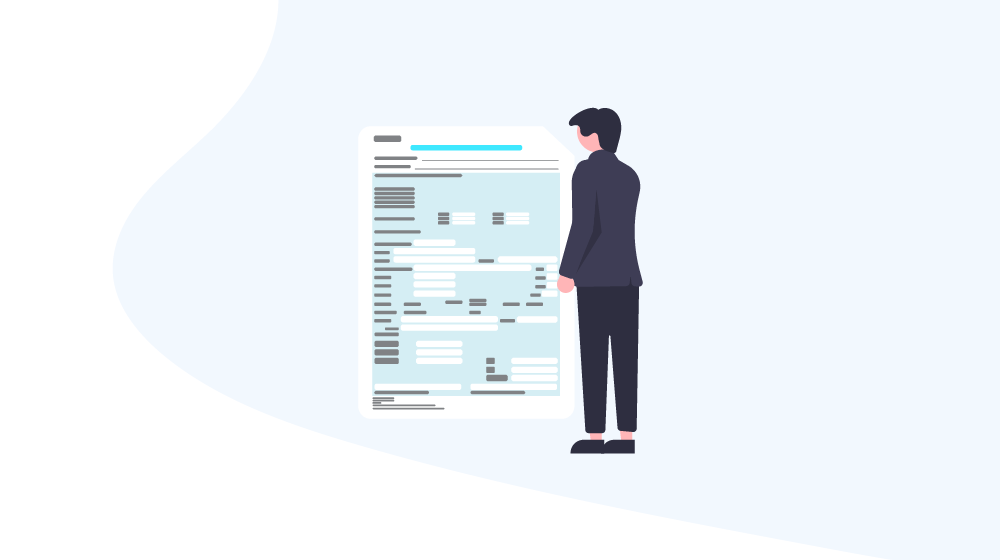
Alla morte di una persona i suoi beni passano agli eredi, testamentari o legittimi. Il trasferimento di ricchezza a causa di morte è tassato dallo Stato ed è per questo che i chiamati all'eredità, o coloro che nel frattempo l’amministrano, devono presentare la Dichiarazione di Successione presso l’Agenzia dell’Entrate. Ma cos’è la dichiarazione e chi, di preciso, la deve presentare?
- Cos’è la Dichiarazione di successione
- Chi deve presentarla ed entro quanto tempo
- Dove e come presentarla
- Perché è importante
1 - Cos’è la Dichiarazione di Successione
Quasi tutti i trasferimenti di ricchezza sono sottoposti al pagamento di un’imposta a favore dello Stato, tra questi rientrano i trasferimenti che si generano in forza di una successione a causa di morte: cioè i beni che alla morte del defunto passano a favore dei suoi eredi, legittimi o testamentari.
Infatti, il D.P.R. n. 637/1972, che regola l’imposta sulle successioni e donazioni, all’art. 1 stabilisce che l'imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte. Ciò giustifica la ragione per cui, alla morte di un soggetto, deve essere presentata presso l’Agenzia delle Entrate la cd. Dichiarazione di Successione.
La dichiarazione contiene la descrizione analitica di tutti i beni e diritti che si trovano nell’asse ereditario ed il relativo valore, proprio al fine di permettere all’Agenzia l’individuazione della base imponibile e la determinazione dell’eventuale imposta da liquidare.
L’imposta di successione non è sempre dovuta! In caso di eredità a favore del coniuge o di parenti in linea retta si paga soltanto se l’asse ereditario supera la franchigia di 1 milione di euro e per un’aliquota del 4% (per le altre franchigie e aliquote guarda qui).
2 - Chi deve presentarla ed entro quanto tempo
Entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che ai sensi dell’art. 456 codice civile coincide con il momento della morte, sono obbligati a presentare la dichiarazione:
- i chiamati all’eredità (cioè coloro che per legge o per testamento ricevono l’eredità, ancorché non l’abbiano ancora accettata);
- i legatari;
- i rappresentanti legali, quando i chiamati e legatari sono soggetti incapaci (es. in caso di minore sono i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale);
- coloro che siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
- gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacente;
- gli esecutori testamentari.
Se vi sono più persone obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che ne venga presentata una sola: ad esempio, se alla morte sono chiamati all’eredità più figli, basta che uno solo di questi presenti la dichiarazione.
Sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione il coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (cioè i figli, discendenti o genitori) ai quali sia stata devoluta un’eredità con valore dell’attivo non superiore a 100.000 euro e nell’asse ereditario non ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari.
In caso di dichiarazione tardiva si può sempre procedere ad un ravvedimento operoso: ossia si produrrà la dichiarazione e si pagheranno gli interessi di mora. Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate ha già operato l’accertamento d’ufficio il ravvedimento operoso non sarà più possibile e si dovranno pagare le sanzioni amministrative in aggiunta a quanto dovuto e agli interessi di mora.
3 - Dove e come presentarla
Dal 2018 la dichiarazione può essere presentata solo online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal contribuente o da un professionista incaricato.
L’Agenzia delle Entrate fornisce sul proprio sito il Modello di Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, accompagnato da due fascicoli che forniscono le istruzioni per l’inserimento corretto di tutti i dati.
Ad esempio, nella dichiarazione dovranno essere indicati, oltre ai dati degli eredi e del defunto:
- i beni immobili e i diritti reali su beni immobili;
- le rendite, le pensioni e i crediti;
- le aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
- le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili che non fanno parte di aziende;
- le passività deducibili.
Se nel compendio ereditario ci sono beni immobili (terreni o fabbricati) occorre versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione anche le imposte ipotecaria e catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali.
Attenzione! chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione IMU: sono gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate che trasmettono la copia della dichiarazione al Comune.
4 - Perché è importante
Oltre a comunicare il trasferimento dei beni agli eredi a fini fiscali, la dichiarazione di successione è importante perché nessun bene ricevuto in eredità può essere venduto se non sono state pagate le relative imposte. Inoltre, la prova della presentazione della dichiarazione viene richiesta sempre dalle banche prima di poter mettere a disposizione degli eredi il conto corrente del defunto.
È importante precisare che la dichiarazione di successione è ben diversa dall’accettazione dell’eredità. Abbiamo visto, infatti, che la dichiarazione ha una mera valenza fiscale, volta a individuare la consistenza dell’asse ereditario e verificare se è dovuta l’imposta di successione e il suo quantum: pertanto, la dichiarazione non sostituisce l’accettazione dell’eredità, cioè l’atto con cui gli eredi accettano di subentrare in ogni rapporto giuridico attivo e passivo del de cuius.
Condividi:
Dichiarazione di successione: chi, cosa, dove, quando e perché!
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Genitori separati e vacanze: regole e buon senso
2 ott. 2025 • tempo di lettura 7 minuti
Ogni anno, in occasione delle vacanze estive, si ripresenta per noi avvocati familiaristi – divorzisti il problema delle coppie separate relativo alle vacanze con i figli.Cercheremo qui di chiarire i punti salienti, sottolineando sempre che in tali casi dovrebbe prevalere il buon senso e non l’egoismo.La legge prevede che i genitori separati debbano comunicare all’altro genitore con congruo avviso (di solito entro maggio) le date in cui vogliono trascorrere le vacanze con i propri figli. Generalmente, i protocolli dei Tribunali italiani garantiscono un periodo di 15 giorni anche non continuativi per le vacanze estive. Inoltre, nei casi di separazione altamente conflittuale, è consigliabile inserire un’apposita clausola negli accordi di separazione o divorzio, che imponga a entrambi i genitori di comunicare reciprocamente dove trascorreranno le vacanze con i figli ed anche la regolamentazione delle chiamate/videochiamate quando i figli sono in vacanza con l'altro genitore.Spesso, però, accade che tali comunicazioni non vengano effettuate per tempo, per i più svariati motivi. Cosa accade in tal caso?Dal punto di vista civilistico la mancata comunicazione del luogo di vacanza può essere considerata una violazione del principio di collaborazione tra genitori. Invero, l’art. 143 c.c. impone ai genitori l’obbligo di collaborare nell’interesse della famiglia. Pertanto, il genitore che omette di comunicare la destinazione delle vacanze potrebbe essere ritenuto responsabile di un illecito endofamiliare, che comporta - in caso di ricorso al Tribunale – l’ammonizione del genitore inadempiente da parte del giudice e la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, in caso di grave pregiudizio per l’altro genitore.Da un punto di vista penale, non si configura alcun reato se un genitore porta in vacanza i figli senza comunicarlo all’altro. Attenta giurisprudenza di merito in materia (Trib. Rieti, Sez. GIP, 15.06.2011) ha chiarito alcuni aspetti:· La condotta de quo è sì una “violazione piuttosto grave”, poiché rende difficile all’altro genitore rintracciare i figli in caso di emergenza, tuttavia, se gli accordi di separazione o divorzio prevedono solo l’obbligo di concordare i periodi di vacanza, ma non il luogo preciso, non si configura alcun reato. In particolare, non si tratta di violazione dell’art. 388, comma 2, c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), né di violazione dell’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare).Pertanto, pur non essendovi gli estremi di reato, ciò non significa che il comportamento di omettere una tale comunicazione sia giusto o men che meno accettabile in quanto si incorre in ogni caso nella violazione del diritto dell’altro coniuge di conoscere il luogo dove i propri figli si trovano e che risulta sanzionabile dal punto di vista civile. Tutto ciò, inoltre, va ad enorme discapito dei bambini per il cui bene i due genitori dovrebbero collaborare e non farsi delle inutili guerre.Altro tema scottante riguarda il mantenimento durante le vacanze estive. L’assegno di mantenimento deve essere pagato anche quando i figli trascorrono le vacanze con chi ne è obbligato? È questa una domanda molto comune tra i genitori separati. Preliminarmente, va osservato come l’assegno di mantenimento è considerato come una rateizzazione di una somma unica annuale, precedentemente stabilita dal giudice della famiglia, che viene appunto rateizzata per permetterne il più comodo e regolare adempimento da parte dell’obbligato. Proprio per tali motivi il genitore non collocatario ed obbligato al versamento dell’assegno non potrà essere sollevato da tale obbligo neppure nel periodo in cui i bambini trascorreranno con lui le vacanze estive. La Corte di Cassazione Sez. I Civile ha infatti sancito come l’obbligo al mantenimento non sia il semplice rimborso mensile delle spese sostenute per i minori, ma si configuri in una rata mensile di un contributo annuo già precedentemente determinato e dunque non influenzato dal fatto che i minori trascorrano le vacanze con l’uno o l’altro genitore. Con la Sentenza dell’8 settembre 2014, n. 18869 la Corte ha infatti dichiarato che: “(…) Non sussiste il vizio motivazionale denunciato. In realtà la denuncia attiene alla contraddittorietà della decisione rapportata all’affermazione del criterio assistenziale dell’assegno. La Corte di merito ha motivato il rigetto della domanda del P. di riduzione dell’assegno per il periodo estivo, in cui le ragazze soggiornavano presso di lui, facendo riferimento al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento (v., in tal senso, Cass., sent. n. 12308 del 2007, n. 566 del 2001).Altra vexata quaestio riguarda, poi, la natura delle spese delle vacanze estive. In particolare, ci si chiede se tali spese siano da considerarsi straordinarie o meno e se dunque vadano divise tra i due coniugi. La Cassazione si è più volte espressa in materia di spese straordinarie, stabilendo che “Le spese ordinarie sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre, quelle straordinarie, sono costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori”. Le “spese straordinarie” sono, dunque, quelle destinate a far fronte a ciò che è imprevedibile ed impronosticabile e, come appare evidente, le vacanze estive non fanno parte di tali eventualità. Sarà quindi onere del genitore con il quale il minore trascorrerà la vacanza sostenere le spese per la stessa. Qualora invece si tratti di vacanze trascorse autonomamente dal bambino, quali campi scuola o campeggi estivi, sarà necessario un preventivo accordo tra i genitori per regolamentarne i pagamenti.Va, infine analizzato il caso – non infrequente ai nostri giorni – di vacanze all’estero. La risposta è da cercarsi, in primis, negli accordi di separazione. Non è inusuale che nel provvedimento giudiziale sia fatta menzione del reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli. In altri casi, invece, i genitori si accordano per consentire viaggi all’estero del minore soltanto al compimento della maggiore età, ovvero soltanto in determinati luoghi ad esclusione di altri, per fare degli esempi. Nel caso in cui, diversamente, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del Tribunale, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere, necessariamente, il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti occorrenti. In caso di rifiuto immotivato, quindi, l’altro genitore potrà rivolgersi al Giudice competente presso il Tribunale ordinario civile che, compiuti gli accertamenti occorrenti per il caso concreto tramite delega alle Forze dell’Ordine interessate (ad esempio i Carabinieri di zona), valutate le ragioni dell’altro, potrà autorizzare il rilascio del documento valido all’espatrio. Tra le motivazioni considerate quali legittime giustificazioni del rifiuto del genitore a consentire il viaggio all’estero del figlio si annoverano, ad esempio, il fondato timore per viaggi in località insalubri o rischiose a causa di situazioni politicamente instabili o guerre, ovvero la sussistenza del fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all’estero portando i bambini con sé.Occorrerà, quindi, depositare un ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per la residenza del minore nel quale allegare il verbale di separazione o la sentenza di divorzio, la documentazione che attesti l’impossibilità ad acquisire il consenso dell’ex coniuge e il proprio stato di famiglia.Letto il ricorso il Giudice fisserà un’udienza per verificare le ragioni del mancato assenso del genitore e per decidere se concedere o meno l’autorizzazione volta ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.L’istanza del rilascio del passaporto sarà rigettata se il Giudice riterrà che il rilascio o il rinnovo del passaporto sia pregiudizievole per il minore; al contrario, accoglierà l’istanza qualora ritenga che non vi siano pregiudizi per il minore oppure che il rifiuto da parte dell’ex coniuge sia ingiustificato. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice emetterà un decreto con cui autorizza l’ex coniuge ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto.Ulteriore vexata quaestio: si possono sentire i figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore? Anche qui è consigliabile inserire tale clausola negli accordi di separazione, ovviamente sì, è possibile sentire i propri figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore, ma senza che telefonate e videochiamate diventino strumento di controllo e intralcino la genitorialità dell'altro genitore. Anche qui, dovrebbe prevalere il buon senso ed il rispetto.Concludendo, vogliamo concludere questa disamina cercando di rispondere alla domanda che, oramai, è comune: “Si possono portare i figli in vacanza con il nuovo partner”? Al riguardo, non esistono regole specifiche dettate dal Legislatore e solo il buon senso dovrebbe regolare questo aspetto. Quindi, il primo consiglio è inserire clausole negli accordi di separazione che regolino tali aspetti, considerando sempre the child’s best interests, e quindi condizionando tale eventualità all’assenza di gravi situazioni che possano essere pregiudizievoli per il minore.Nella speranza che quest’anno prevalga il buon senso, auguriamo a tutti buone vacanze.
Continua a leggere
Scritto da:
La separazione dei coniugi
2 ago. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
Il codice civile agli articoli 150, 151, 154 e 158 disciplina la separazione personale dei coniugi.L’istituto, che si differenzia nettamente rispetto al divorzio, consiste in una situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di reciproco rispetto.In particolare, la separazione è quella situazione temporanea dove il vincolo matrimoniale si allenta ma non si scioglie e costituisce un rimedio al venir meno dell’affectio coniugalis.La funzione dell’istituto è duplice: mantenere vivo il vincolo coniugale, che può sempre tornare alla sua piena efficienza con la riconciliazione (art. 157 c.c.) o predisporre le basi per il successivo scioglimento del vincolo.Quanti tipi di separazione sono disciplinati dal codice civile?Cosa s’intende per separazione di fatto?Quali sono gli effetti della separazione personale dei coniugi?A chi spetta il diritto di chiedere la separazione?1 – Quanti tipi di separazione sono disciplinati dal codice civile?Ai sensi dell’articolo 156, comma II, c.c. la separazione può essere: a) giudiziale, se ha il suo presupposto nell’intollerabilità della convivenza o nel grave pregiudizio per l’educazione dei figli ed è pronunciata dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi (art. 151 c.c.); b) consensuale, se ha il suo presupposto nel consenso dei coniugi ed avviene per accordo delle parti che dovrà essere omologato dal Tribunale (art. 158 c.c.). In entrambe le ipotesi si parla di separazione legale, in quanto lo status di vita separata si instaura tra i coniugi soltanto a seguito di un provvedimento giurisdizionale.Vi sono, inoltre, forme particolari di separazione, che pur trovando la loro disciplina in un provvedimento giurisdizionale non comportano la modificazione dello status coniugale: a) separazione temporanea disposta in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio davanti ai tribunali civili; b) la separazione ordinata dal presidente del Tribunale in sede di provvedimenti temporanei e urgenti durante il giudizio di separazione.2 - Cosa s’intende per separazione di fatto?Lo status di coniuge legalmente separato può nascere solo da una sentenza di separazione giudiziale o dall’omologazione di una sentenza consensuale.Tuttavia, i coniugi possono porre fine alla convivenza dando vita a situazioni che non sono irrilevanti per l’ordinamento e che producono determinati effetti giuridici, in parte diversi rispetto a quelli prodotti dalla separazione legale.La separazione di fatto richiede la cessazione della convivenza dei coniugi. Non costituiscono, pertanto, separazione di fatto le ipotesi (viaggi, ricoveri in ospedale, servizio militare) nelle quali la coabitazione sia temporaneamente interrotta senza che si verifichi alcuna frattura dell’affectio coniugalis. Costituisce separazione di fatto anche la separazione consensuale non omologata, quando i coniugi concordano la cessazione della convivenza senza far ricorso all’autorità giudiziale.La separazione di fatto rileva quale fondamento dell’azione di disconoscimento della paternità, non comporta il venir meno della presunzione di concepimento e non determina lo scioglimento della comunione legale.3 - Quali sono gli effetti della separazione personale dei coniugi?La separazione, come innanzi detto, non scioglie il matrimonio ma sospende soltanto alcuni doveri reciproci dei coniugi, quali quelli legati alla vita in comune.In particolare, il dovere di fedeltà si riduce al mero dovere di rispetto dell’onorabilità del coniuge, vengono meno gli obblighi di convivenza e di collaborazione, ma la moglie conserva il cognome del marito. Quanto ai rapporti patrimoniali, si scioglie la comunione legale ma permangono il fondo patrimoniale e l’impresa familiare.A fronte della separazione, sorge l’obbligo in capo al coniuge di fornire all’altro coniuge, se privo di adeguate risorse economiche, i mezzi necessari per le ordinarie esigenze di vita. Il mantenimento in favore dei figli, invece, grava su entrambi i genitori in misura proporzionale al reddito di ciascuno.4 - A chi spetta il diritto di chiedere la separazione?La separazione può essere chiesta da uno o da entrambi i coniugi, compreso il coniuge che con il suo comportamento abbia cagionato l’intollerabilità della convivenza o la situazione pregiudizievole ai figli. Nel giudizio di separazione la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può essere riconosciuta ai parenti di questi, neppure al fine di tutelare più efficacemente gli interessi dei figli minori.Il diritto di chiedere la separazione è: a) personalissimo, né deriva l’intrasmissibilità agli eredi, poiché il diritto cessa con la morte del suo titolare e non è ammissibile la prosecuzione in giudizio da parte degli eredi; b) indisponibile, ciò comporta che la separazione non può essere oggetto di compromesso per arbitrato; c) imprescrittibile. È consentita la rappresentanza volontaria dei coniugi da parte di procuratori speciali delimitando l’ambito che la parte rappresentata intende far valere a mezzo del rappresentante.Per l’interdetto non può agire il tutore il quale, tuttavia, ha la legittimazione passiva nel giudizio di separazione promosso dall’altro coniuge.Editor: Avv. Elisa Calviello
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Il Superbonus 110%: guida pratica
9 feb. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
Il Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni con la legge n. 77/2020 e meglio noto come Decreto Rilancio, oltre a introdurre misure urgenti in materia di salute, sostegno all’economia e politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a fronte di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, ma anche delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.Ma chi può usufruire del c.d. Superbonus? E quali sono gli interventi c.d. agevolabili?Il Superbonus: cos’è? Chi può usufruirne?Quali sono gli interventi agevolabili?Esistono delle alternative alle detrazioni?Come ottenere il Superbonus 110%?1 - Il Superbonus: cos’è? Chi può usufruirne?Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal Decreto Legge Rilancio che mira ad una migliore efficacia e sicurezza per le abitazioni.Il Superbonus si suddivide in una duplice tipologia di interventi: il Super Ecobonus e il Super Sismabonus.Infatti, le disposizioni del D.L. 34/2020 si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), inclusi gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus), disciplinato dall’art. 16 del Decreto Legislativo n. 63/2013;riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus), a norma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 63/2013. Ma, in concreto, quali sono le agevolazioni previste dal Decreto Rilancio?Questa agevolazione è concessa laddove si eseguano interventi di manutenzione che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici ovvero si riduca il rischio sismico degli stessi.Più nel dettaglio, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari ma che abbiano almeno un accesso autonomo dall’esterno, ed infine sulle singole unità immobiliari.Chi può, quindi, usufruire di questo incentivo?Dalla lettura della normativa è possibile fornire una risposta esaustiva. Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:i condomìni;le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;gli Istituti autonomi case popolari (c.d. IACP), nonché gli enti che abbiano le medesime finalità sociali che rispondano ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/1991 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 242/1999, ma limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.L’incentivo del Superbonus consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire in cinque quote annuali e, solamente per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, in quattro quote annuali.Per gli Istituti Autonomi Case Popolari (i c.d. IACP) il limite temporale entro cui è possibile detrarre le spese è esteso sino al 31 dicembre 2022, prorogabile ulteriormente sino al 30 giugno 2023, solamente nell’ipotesi in cui sia stato completato almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda, invece, i condomini, il limite temporale è esteso sino al 31 dicembre 2022 se, al 30 giugno 2022, sia stato completato almeno il 60% dei lavori.2 - Quali sono gli interventi agevolabili?L’articolo 119 del già citato Decreto Rilancio specifica che le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per le tipologie di interventi c.d. trainanti o principali. Si tratta degli interventi di:isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (es. coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari. Si tratta, più nello specifico, di interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento e/o al raffrescamento e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di: generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche, apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, sistemi di microcogenerazione, collettori solari;interventi antisismici (c.d. Sismabonus). Con il Decreto Rilancio si prevede che la detrazione per gli interventi antisismici previsti dall’art. 16, commi da 1 – bis a 1 – septies, del D. L. n. 63/2013, sia elevata al 110% per le spese sostenute nel periodo sopra indicato.Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per gli interventi ulteriori eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti. Si tratta dei c.d. interventi aggiuntivi o trainati, vale a dire gli interventi di efficientamento energetico, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.3 - Esistono delle alternative alle detrazioni?La risposta è affermativa. Infatti, l’art. 121 del Decreto Rilancio prevede che i soggetti che possono usufruire del Superbonus, possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, quali istituti di credito e intermediari finanziari. 4 - Come ottenere il Superbonus 110%?Per poter ottenere la detrazione, gli interventi dovranno, nel complesso, assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).È inoltre necessario:pagare tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA del soggetto destinatario del bonifico;depositare, se previsto, in Comune la relazione tecnica dell’intervento;acquisire l’A.P.E. pre e post intervento;trasmettere ad ENEA telematicamente, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati per la compilazione della scheda descrittiva che si ricavano dall’A.P.E. e quelli per la compilazione della scheda informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti.Editor: avv. Marco Mezzi
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Disturbo Narcisistico
10 ott. 2023 • tempo di lettura 4 minuti
Narcisismo sano e narcisismo patologicoMolti autori concordano sull’esistenza di un narcisismo sano ben diverso dal disturbo di personalita' vero è proprio. Il Narcisismo sano si riferisce alle caratteristiche che tipicamente sono associate alla personalità narcisistica quali:EgocentrismoAmbizioneAmor proprioAttenzione per la propria immagine.Queste caratteristiche vengono utilizzate in modo creativamente adattivo dalla persona, aiutandola nei fatti a raggiungere i propri obiettivi di crescita personale.Il narcisismo in adolescenzaMolti autori hanno evidenziato una fisiologica, quanto necessaria, fase narcisistica in adolescenza. L’adolescente si trova a vivere la complessità di una costruzione identitaria che passa anche per la creazione di un nuovo sistema di regolazione dell’autostima: l’obiettivo finale è il riconoscimento del proprio valore in quanto individuo.Bleiberg sottolinea quanto sia difficile distinguere chiaramente tra i vissuti di vergogna, onnipotenza e vulnerabilità tipici dell’adolescente che cerca di costruire la propria identità, e quei medesimi vissuti presenti nel narcisismo patologico. Non a caso per effettuare una diagnosi di disturbo narcisistico di personalità si deve aspettare la prima età adulta.Disturbo Narcisistico di Personalità: i sintomiIl Disturbo Narcisistico di Personalità secondo la classificazione del DSM-5 è caratterizzato da:Mancanza totale di empatiaIdea grandiosa di SéCostante necessità di essere ammirati dall’altro.La mancanza di empatia è il frutto della principale difesa del narcisista: non sopportando l’idea di dipendere da qualcuno o che l’altro non sia sotto il proprio controllo, lo nega: nei fatti, è come se lo eliminasse. Pensiamo ad esempio al, breadcrumbig, una dinamica relazionale in cui si attira l'altro a sé con comportamenti ambigui, tenendolo costantemente in sospeso.Ecco che chi soffre di questo disturbo di personalità viene spesso additato come "colpevole" di mettere in atto una manipolazione affettiva del partner all'interno di quella che viene definita relazione tossica. Il Sé grandioso è figlio di una storia familiare dove il bambino è entrato in contatto con genitori iper-esigenti, o ancor peggio, indisponibili emotivamente. È la conseguenza dei cosiddetti mommy o daddy issues.La mancanza di contatto emotivo precoce è una spada di Damocle sull’autostima del bambino, che compensa sviluppando quel “senso di superiorità” così facilmente rintracciabile in questo tipo di personalità. Questo senso di superiorità in età adulta può tradursi in comportamenti di svalutazione dell'altro, come accade nel gasligthing.Il bambino scambia l’ammirazione per amore e nel suo rapporto con l’altro impara a mostrare solo la sua parte brillante nascondendo il resto. La negazione delle proprie fragilità diventa così una gabbia che imprigiona, esattamente come per gli uomini prigionieri della mascolinita' tossica.La vulnerabilità narcisisticaCome sottolineava K. Horney il narcisista non ama sé stesso, ama solo le sue parti grandiose. L’ immagine che il narcisista rimanda è tanto accecante e grandiosa quanto fragile, dovendo essere continuamente alimentata dall’ammirazione e dal consenso altrui. Proprio su questo punto è possibile incontrare tutta la vulnerabilità narcisistica, intesa come:“tendenza a reagire ai rimproveri e alle delusioni con una significativa perdita di autostima…Si pensa che la vulnerabilità narcisistica sorga in seguito a precoci esperienze di impotenza, perdita o rifiuto”L’intera esistenza del Narcisista appare, in questo modo, un grottesco paradosso: incapace di provare empatia per l’altro, si trova ad esservi intrinsecamente legato per poter mantenere viva l’immagine di Sé grandiosa, che come un fuoco, rischia di spegnersi senza essere continuamente alimentata da lusinghe e approvazioni esterne.Nei panni del narcisistaQuando l'ammirazione viene a mancare il narcisista prova senso di vergogna e inadeguatezza che, possono sfociare in vissuti depressivi profondi. Tali vissuti sono comuni anche ad altri disturbi di personalità, come accade, ad esempio, nella personalita' istrionica.Essendo la sua ferita così antica e la negazione delle altre parti di sé così profonda, è davvero difficile che qualcuno riesca ad accedere a tali esperienze; per questo motivo il narcisista si ritrova spesso con la sensazione sgradevole di non sentirsi compreso.In sintesi, ciò che i narcisisti patologici sperimentano è:dipendenza dall’approvazione altruiimpossibilità di amarsi e di amare in modo autenticovissuti depressivisentirsi solipensare di non essere compresi dagli altri.considerazioni sulla personalità narcisisticaLa personalità narcisistica è controversa e a tratti affascinante, non a caso attira l’attenzione di molti. Quando si parla di narcisismo è importante tenere a mente che:Non è così semplice parlare di narcisismo: abbandoniamo le etichette e lasciamo agli esperti il compito di fare diagnosi;Probabilmente abbiamo attraversato tutti una fase in cui siamo stati un po’ "narcisi": ci è servito per crescere e consolidare la nostra autostima;Dietro a un’immagine fatta di egocentrismo e assoluta mancanza di interesse e amore per l’altro, si nasconde una ferita antica: siamo ancora sicuri di voler emettere giudizi impietosi nei confronti dei narcisisti?Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoDiritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency
Continua a leggere
Commenti
Non ci sono commenti




